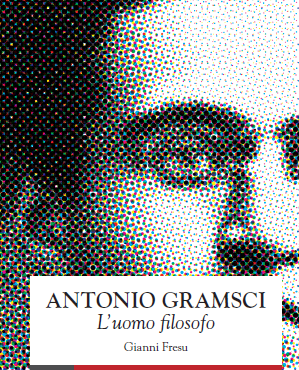“L’autista aveva gli occhi chiusi”
(In risposta all’articolo I miracolati della corriera, di Rosangela Erittu, “L’Unione Sarda” del domenica 29 luglio 2012, pagina 37)
Mi chiamo Gianni (all’anagrafe Giovanni) Fresu, come mio padre, autista delle autolinee Satas, in tempi nei quali guidare “su postale” non era proprio la migliore delle occupazioni possibili: stipendi bassi, eufemismo per non dire da fame, ritmi di lavoro e turni massacranti, mezzi cui spesso era negata o limitata al minimo la manutenzione. Un’azienda privata perennemente in crisi, le cui prospettive fosche si accompagnavano a fasi nelle quali, con il futuro, era incerto anche il presente delle retribuzioni in arretrato. Bisognava porre fine a quella condizione, i lavoratori della Satas iniziarono una vertenza durissima per l’acquisizione pubblica dell’azienda e dei relativi servizi di trasporto: scioperi, agitazioni, la lunga occupazione della stazione autolinee di Cagliari, mesi e mesi di stipendi, già di per sé magri, in fumo, debiti insostenibili contratti dalle famiglie per far fronte all’emergenza, tra queste anche la mia. Passata la nottata, vinta la battaglia (il 9 giugno del 1970 fu istituita con legge regionale l’ARST) per i lavoratori Satas tornò il tempo del lavoro in una fase di transizione dal vecchio al nuovo comunque non ancora priva d’incognite, nella quale autisti, bigliettai e operai della ex Satas si trovarono costretti a lavorare senza sosta per recuperare quel reddito perso nei tanti mesi senza salario, in un contesto confusionario nel quale potevi essere chiamato in servizio senza alcun preavviso, buttato giù dal letto e messo su vetture spesso con i freni, e non solo, in disordine. Non a caso in quel periodo si moltiplicarono gli incidenti che vedevano coinvolte le linee ex Satas. Acadde così il quattro giugno 1972. Mio padre non doveva lavorare, anzi quel giorno avrebbe dovuto assistere al provino per il “Cagliari calcio” del suo figlio maschio più grande, 10 anni. Un giorno atteso da mesi, una gioia per entrambi, che li spinse la sera prima a fare le prove di dribling con le bottiglie disposte nell’andito di casa. Poi una chiamata improvvisa, bisogna sostituire un collega, presa di servizio la mattina presto per la tratta che da Cagliari conduceva per le tortuose strade dell’Ogliastra e addio ai sogni da coltivare a bordo campo, il piccolo Diego farà il provino da solo, senza il conforto e lo sguardo rassicurante del babbo, come per tutto il resto della sua vita dovrà abituarsi a fare lui, le due sorelle, i due fratelli, la mamma. Era una mattinata caldissima, soffocante, e la corriera con venticinque persone a bordo, tra un tornante e l’altro, terminò la sua corsa in una scarpata di Talana, dieci le vittime. Scrivo queste cose non perché voglio tediare con le vicende personali della mia famiglia, ma perché sono rimasto quanto meno amareggiato nel leggere l’articolo I miracolati della corriera, (“L’Unione Sarda” del 29 luglio 2012, pagina 37) dedicato a quell’evento tragico attraverso la testimonianza dei superstiti. Sì perché tutto quel che si può leggere di quell’evento è una frase di questo tenore: «prima che il pullman precipitasse l’autista aveva gli occhi chiusi». Nient’altro, nessuma precisazione, quasi che mio padre avesse gli occhi chiusi perché stesse dormendo, fosse ubriaco o chissà cosa. No, non andò così, mio padre, come tanti suoi colleghi, costretto a non rifiutare turni pesantissimi e straordinari, non era ubriaco, non stava dormendo. Prima del volo ebbe un malore e fu colto, come anche l’autopsia chiarì, da infarto alla guida del mezzo, su una strada infame, abbandonata, come lo è oggi, al suo destino sotto il sole di una caldissima giornata di giugno. A rendere ancora più triste il tutto, l’elicottero che lo trasportò in fin di vita atterrò proprio nel campo di calcio Coni, sede del provino del piccolo Diego. Giovanni Fresu morì dopo quattro giorni di agonia in stato comatoso, non aveva ancora compiuto 37 anni, aveva una moglie e quattro figli piccoli, io sono nato due mesi dopo. Con lui morirono il suo collega Bruno Corso e i passeggeri che ebbero la sventura di salire, come ogni giorno, su quella maledetta corriera. Come tutti gli incidenti sul lavoro, anche quello di mio padre, non fu una fatalità e nemmeno un evento causato da suo dolo o comportamento scorretto. Ci tenevo a precisare questi fatti non perché mi aspettassi di vedere “nero su bianco” i retroscena di quanto accadde (in casa nostra abbiamo ancora conservati tutti gli articoli usciti in quei giorni su “L’Unione sarda”, “L’Unità”, “Famiglia cristiana”) ma per ristabilire una verità storica, offuscata o resa poco comprensibile da una frase lapidaria, il cui significato può essere interpretato in qualsiasi modo. Per noi quel volo, giù per il burrone, non si è mai concluso, quasi a non voler sentire il frastuono dello schianto, quasi a non voler vedere la ferraglia contorta e tutto quel che essa conteneva. Da quel giorno abbiamo vissuto sospesi in attesa della fine del servizio, del suo rientro a casa da lavoro, e a volte bastano poche parole per farci ritornare tutto in mente. Sia chiaro, nessuna malafede, ma forse, quando si ha a che fare con le ferite mai ricucite e i drammi di famiglie come la mia, non una sagra o un banale fatterello di cronaca, un giornalista dovrebbe evitare le approssimazioni e magari approfondire meglio ciò di cui intende scrivere.
Cordiali saluti
Gianni Fresu, figlio di Giovanni Fresu.