Le vicende del PCI si intrecciano strettamente alla costruzione della nostra democrazia repubblicana, a partire dal ruolo assunto da quest’organizzazione nel corso della resistenza e, prima ancora, durante gli anni bui del fascismo trionfante. Tra gli sforzi che il PCI ha condotto con maggior efficacia tra il 1943 e il 1945 c’è senz’altro la lotta contro il cosiddetto “attesismo” di una parte delle forze antifasciste e quella parallela per favorire la partecipazione non solo militare del popolo alla lotta di liberazione nazionale. Il protagonismo nella liberazione del Centro Nord da parte delle divisioni partigiane ha avuto delle conseguenze sullo status post-bellico dell’Italia, contribuendo non poco a un fatto troppo spesso sottovalutato: delle tre nazioni un tempo facenti parte del «Patto tripartito», solo l’Italia vanta una Costituzione frutto di un processo di partecipazione popolare così ampio e socialmente avanzato, non una semplice emanazione degli eserciti occupanti.

Tra rimozioni e omissioni. I 100 anni del PCI e il vizio del giudizio interessato

Cuba e la guerra egemonica dell’Occidente contro gli “Stati canaglia”.
I cento anni del PCI, La Nuova Sardegna, 17/01/2021
Il centesimo anniversario del PCI a finito per essere l’ennesima occasione di approfondimento persa, vanificata dalla volontà di regolare i conti del passato che soverchia la necessità di capire. “Il Corriere della Sera”, “La Stampa”, “La Repubblica”, tutte le grandi testate nazionali si uniscono in una nuova Santa Alleanza, cementata dallo stridore di maledizioni che dovrebbero incenerire tutto quel che quella storia ha rappresentato. È, ad esempio, il caso del pezzo di Filippo Ceccarelli che apre lo speciale dedicato ai 100 anni del PCI da “Robinson”, a suo modo, paradigmatico e ben rappresentativo dell’approccio oggi prevalente.
Nemmeno il più piccolo sforzo per tentare di comprendere l’originalità e la funzione progressiva di questa organizzazione, in un contesto storico denso di contraddizioni interne e internazionali. Va bene prestare attenzione alle contraddizioni, che in quella storia non furono certo poche, ma come si può non avere alcuna curiosità verso la sua ricchezza culturale? Come omettere il suo contributo pedagogico alla socializzazione politica di massa in Italia, ossia al fatto che questo partito è stato comunque strumento di alfabetizzazione e formazione politica, veicolo di partecipazione collettiva per milioni e milioni di “cafoni” (operai, contadini, muratori, lavoratori in genere) fino ad allora esclusi dalla politica e divenuti improvvisamente soggetto attivo e cosciente della vita nazionale. Tutto questo in un Paese storicamente dominato da equilibri sociali regressivi tra le classi, dalle rivoluzioni passive e dal ricorso sistematico al trasformismo che, dal Risorgimento al fascismo, hanno sempre avuto la funzione operativa di escludere e rendere ancora più subalterne le masse popolari. Un pezzo di “riforma intellettuale e morale”, sicuramente incompleto di cui, pur tra mille limiti, quel gruppo dirigente aveva consapevolezza, così sintetizzato da Palmiro Togliatti gennaio del 1958:
“L’adesione di milioni e milioni di donne e di uomini a un partito che combatte per creare una nuova società, è un fatto nuovo nella vita della nazione. L’Umanità e la nazione diventano consapevoli del loro compito, che è di dominare il mondo dei rapporti sociali e dare inizio al regno della libertà. Noi siamo fieri di essere l’avanguardia consapevole di questo grande movimento”, (P. Togliatti, Il partito comunista italiano, Editori Riuniti, Roma, 1961, p. 136-137).
Nel pezzo di Ceccarelli troviamo solo una lunga sequenza di accuse, luoghi comuni, giudizi taglienti e sconcezze osservate dal buco della serratura del più grande partito comunista dell’Occidente. Ma se veramente questa storia non rappresenta nulla e non ha lasciato tracce, solo fallimenti, perché ogni giorno tutti questi intellettuali in servizio permanente nella difesa dello stato di cose presenti sente il bisogno di mobilitarsi per delegittimarne la memoria e cancellare preventivamente la possibilità di trarne insegnamento per il futuro? Questa volontà censoria, infarcita di scomuniche e maledizioni fino alla settima generazione, ci dice semmai l’esatto contrario di quanto raccontato; in realtà, quelle vicende fanno ancora paura a tanti, sebbene nella politica attuale nessuno abbia ancora avuto la forza, la voglia e l’intelligenza di raccoglierne l’eredità.
Per rivendicare un diverso modo di rapportarsi a questo insieme di problemi, di seguito, un mio articolo pubblicato nella rubrica “Diogene” nel numero de “La Nuova Sardegna” del 17 gennaio 2021.
Quella scissione che cambiò la sinistra
Il 21 gennaio di cento anni fa al XVII Congresso del PSI a Livorno la nascita del Partito comunista italiano
Il 21 gennaio ricorre il centenario della fondazione del PCI, si possono avere diverse opinioni in merito alla sua linea politica, condividerne o meno premesse e prospettive ideologiche, resta innegabile l’importanza di quest’organizzazione di massa nella storia d’Italia del XX secolo. Tale riconoscimento non significa omettere le contraddizioni e i limiti della sua traiettoria politica, ma valutarle unitamente ai contenuti progressivi della sua funzione storica. La peculiarità del PCI nel panorama del comunismo internazionale, tuttavia, non riguarda solo il suo peso nelle vicende sociali, politiche e culturali di un Paese la cui collocazione nel blocco occidentale era considerata inderogabile, come le trame eversive e la strategia della tensione nel corso del dopoguerra hanno drammaticamente dimostrato. La vera originalità del comunismo italiano riguarda lo sforzo compiuto dai suoi gruppi dirigenti teso a tradurre i principi del marxismo e il contenuto universale della Rivoluzione russa nelle peculiarità della nostra realtà nazionale. Non si trattava di ripetere formule ideologiche generali, né pretendere di riproporre pedissequamente in Italia modelli affermatisi altrove. Come Gramsci scrisse nel Quaderno 7, «il compito era essenzialmente nazionale, cioè domandava una ricognizione del terreno e una fissazione degli elementi di trincea e di fortezza», ossia, inserirsi nelle articolazioni egemoniche della sua società civile, comprendendone l’essenza e originalità.
Zonde d’ombra
Nella storia del Novecento, le vicende del Partito comunista italiano hanno dato luogo a ricerche e approfondimenti tanto estesi da trovare un corrispettivo solo nel grande interesse verso il Fascismo, sicuramente l’argomento storico-politico italiano più sottoposto a indagine scientifica. Eppure, in questo colossale lavoro di ricostruzione storica ci sono alcune “zone d’ombra” tra le quali spicca senz’altro la mancata o insufficiente storicizzazione della corrente di Amadeo Bordiga, principale artefice e protagonista della nascita del PCd’I. La tendenza a considerare Gramsci il fondatore del “Partito nuovo” è il risultato di una rappresentazione dei fatti strumentale, funzionale alle sue esigenze interne di lotta politica. Tuttavia, cambiato il quadro storico e svanite le necessità dialettiche che ne avevano determinato l’affermazione, una simile visione dei fatti è sopravvissuta allo stesso PCI, così ancora oggi è diffusa l’idea di un “Gramsci padre fondatore del Partito”.
Oltre Bordiga
Il PCd’I, Sezione italiana della III Internazionale, nasce a Livorno il 21 gennaio del 1921. A sottolineare con più decisione la sua radice nazionale, a seguito dello scioglimento dell’Internazionale comunista, assume poi il nome di Partito comunista italiano il 15 maggio del 1943. Tuttavia, la scelta di una più netta contestualizzazione nazionale dell’organizzazione nasce ben prima del 1943, con la profonda svolta impressa da Gramsci alla sua direzione politica tra il 1925 e il ‘26. Le Tesi del Congresso Lione del ‘26 sono state definite l’asse fondamentale della sterzata operata nella storia dei comunisti in Italia, sia in rapporto alla concezione del partito, sia per l’analisi della società. In entrambi i casi si giunge al superamento completo delle Tesi elaborate da Bordiga per il Congresso di Roma, dopo il profondo mutamento nella direzione politica del Partito sotto la guida di Antonio Gramsci. Come è noto, a partire dalla fine degli anni Trenta e soprattutto nella lotta di liberazione nazionale il Partito comunista diviene un soggetto politico capace di attrarre studenti, operai, artisti, letterati, docenti universitari. Da piccolo partito di quadri, presente, e limitatamente, solo in determinate realtà del Paese, diviene la principale organizzazione politica della Resistenza, fino a risultare inaspettatamente il primo partito della sinistra italiana e il più grande partito comunista del campo occidentale. Sembra quasi impossibile una simile trasformazione, tenuto conto della marginalità e della cultura minoritaria al momento della sua nascita e negli anni di affermazione del Fascismo. Una prima spiegazione andrebbe ricercata forse nella tenacia con cui, anche negli anni più duri della repressione fascista, il PCd’I si sforzò di mantenere in Italia una sua struttura operativa clandestina, anziché limitarsi a trasferire all’estero tutta la sua organizzazione. Tuttavia, sebbene importante, la presenza ostinata dei comunisti nel Paese lungo tutto il ventennio mussoliniano non spiegherebbe da sola un fenomeno di crescita tanto esponenziale. Su esso ha probabilmente influito anche l’evoluzione della sua linea, capace di abbandonare gli approcci settari e minoritari delle origini fino ad aderire con maggiore plasticità alle condizioni nazionali, divenendo un partito di massa per molti versi erede della tradizione organizzativa e sociale del vecchio socialismo.
Transizione
Le Tesi di Lione rappresentano uno spartiacque essenziale, sicuramente il punto più alto nel quale l’elaborazione teorica e la direzione politica di Gramsci trovano un punto d’intesa elevatissimo. Nella biografia di Gramsci queste rappresentano un punto di continuità tra le battaglie precedenti il 1926 e le riflessioni carcerarie, la testimonianza più vivida di quanto sia impossibile separare il Gramsci politico e militante dal Gramsci “disinteressato” o “uomo di cultura”. La svolta di Lione costituisce la premessa essenziale per comprendere il ruolo storico assunto dal PCI tanto nella Resistenza, quanto nella fase successiva alla Liberazione; è l’antefatto più pregnante del profondo mutamento nell’iniziativa dei comunisti tra il VII Congresso del Comintern e la “svolta di Salerno” del 1944. Il risultato più fecondo di questa svolta fu il concepire in termini organici le tematiche della lotta al fascismo e quelli della ricostruzione democratica a partire dalla stagione costituente. Il punto d’intesa tra questi due momenti era l’idea della democrazia progressiva, vale a dire, la prospettiva di un permanente allargamento degli spazi di democrazia economica, sociale e politica, tali da consentire al mondo del lavoro di conquistare posizioni di forza, in un processo di transizione democratica al socialismo.
Questione nazionale
Bisognava rimuovere le radici economico sociali del fascismo, ossia la natura monopolistica di un certo suo capitalismo, il parassitismo oligarchico, causa congenita del sovversivismo reazionario di parte significativa delle sue classi dirigenti. Per raggiungere questo obiettivo, così come per quello propedeutico della liberazione dell’occupazione nazifascista, era essenziale trovare un’intesa unitaria con le altre forze popolari del Paese, non solo i socialisti ma anche e soprattutto le masse cattoliche. Al di là di miti e leggende sulla presunta “doppiezza togliattiana”, nella scelta operata con la svolta di Salerno nel 1944, e in quelle successive, fino all’approvazione della Costituzione repubblicana non c’era alcun “abile espediente tattico”, si trattava di scelte strategiche conseguenti alla ricerca di un’originale via italiana al socialismo, frutto delle specificità storiche, culturali e sociali della concreta realtà nazionale in cui i comunisti intendevano agire.
Pubblicato sul numero in edicola de “La Nuova Sardegna”, (“Diogene”, p. 28) del 17 gennaio 2021
Gianni Fresu
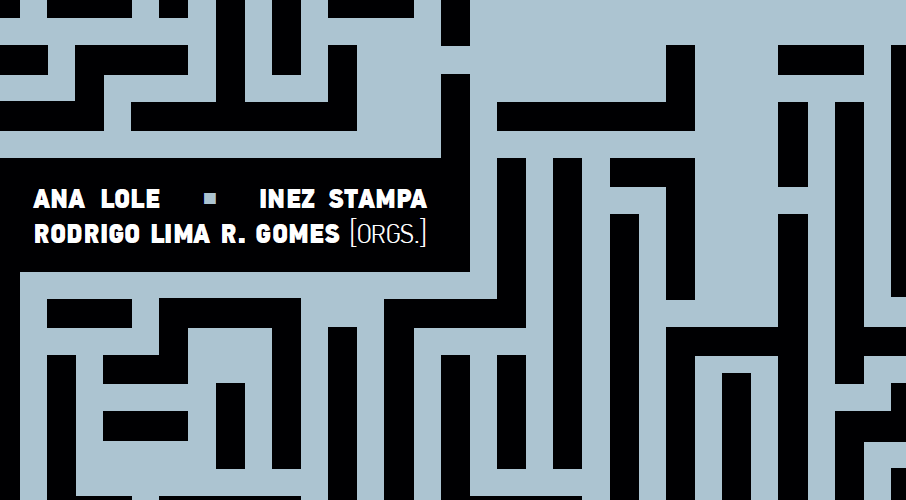
Entre pandemia e crise orgânica: contradições e narrações hegemônicas do capitalismo em colapso
Artigo presente no volume (e-book) Para Além da quarentena: reflexões sobre crise e pandemia, Ana Lole, Ines Stampa, Rodrigo Lima R. Rodrigues, Morula, Rio de Janeiro, 2020, ISBN 978-65-86464-13-9
Entre pandemia e crise orgânica:
contradições e narrações hegemônicas do capitalismo em colapso
Gianni Fresu
(professor de Filosofia Política da UFU/ presidente da IGS Brasil)
- A contradição entre capital e trabalho
Essa acumulação primitiva desempenha na economia política aproximadamente o mesmo papel do pecado original na teologia. Adão mordeu a maçã e, com isso, o pecado se abateu sobre o gênero humano. Sua origem nos é explicada com uma anedota do passado. Numa época muito remota, havia, por um lado, uma elite laboriosa, inteligente e sobretudo parcimoniosa, e, por outro, uma súcia de vadios a dissipar tudo o que tinham e ainda mais. De fato, a legenda do pecado original teológico nos conta como o homem foi condenado a comer seu pão com o suor de seu rosto; mas é a história do pecado original econômico que nos revela como pode haver gente que não tem nenhuma necessidade disso. Seja como for. Deu-se, assim, que os primeiros acumularam riquezas e os últimos acabaram sem ter nada para vender, a não ser sua própria pele. E desse pecado original datam a pobreza da grande massa, que ainda hoje, apesar de todo seu trabalho, continua a não possuir nada para vender a não ser a si mesma, e a riqueza dos poucos, que cresce continuamente, embora há muito tenham deixado de trabalhar.[1]
Em meio à pandemia de covid-19, uma das argumentações mais recorrentes espalhadas pela nova Internacional da direita coordenada por Steve Bannon, que tem entre os seus afiliados Trump, Bolsonaro, Orbán e Salvini, é a necessidade de retomar as atividades produtivas. “A vida não pode parar”, como nesses dias eles vão repetindo, apesar do drama que atinge a realidade atual onde o dado mais visível é que a vida, sem os devidos cuidados e um planejamento político emergencial racional e fundamentado nas indicações da ciência, não apenas pode parar, mas acabar. Dentro dessa narrativa, segundo a qual o verdadeiro perigo mortal seria o colapso econômico, não temos apenas a tentativa de evitar uma crise que abalaria os respectivos governos de Trump e Bolsonaro, mas também uma operação hegemônica. Afirmando que é preciso voltar ao trabalho, essa retórica levanta o problema da sustentação econômica das classes populares apresentando seus propagandistas como defensores dos interesses materiais dos trabalhadores ameaçados pelas indicações da OMS e pelas providências dos governadores que limitaram a “liberdade de iniciativa econômica”.
Claro que tanto o Presidente quanto os empresários, empenhados nessa campanha a favor da reabertura das atividades, são hábeis em ocultar como essa crise tornou ainda mais evidente a contradição entre capital e trabalho. Para além das funções hegemônicas e demagógicas, o desespero do mundo dos negócios e a vontade avassaladora de reabrir fábricas e trazer os trabalhadores de volta à produção, confirmam uma verdade que, embora questionada desde o século XIX, não cessa de se manifestar: sem a exploração do trabalho não há lucro, sem lucro não há capital. Embora tenham tentado durante anos decretar a morte cerebral do velho Marx, alegando que o capital tem novas formas de remuneração totalmente independentes do salário, na realidade, o lucro não pode existir sem a exploração do trabalho. Por outro lado, se não fosse assim, não se explicaria por que estão sempre à procura constante de mão de obra barata a ser explorada nos países em desenvolvimento e prontos para relocalizar sua produção, nem por que, após cada crise, sua receita de política econômica permanece inabalavelmente a mesma: aumentar a produtividade e reduzir os custos de mão de obra.
Depois do prolongado colapso da economia mundial começado em 2008 nos Estados Unidos, que mostrou a natureza aleatória e fraudulenta do sistema especulativo financeiro, a pandemia jogou novamente o capitalismo numa crise orgânica internacional, abalando todas as certezas e as convicções do mundo ocidental, pondo em questão o paradigma neoliberal, que fora assumido acriticamente nas últimas décadas como única opção possível e legítima para os rumos do desenvolvimento histórico. Diante dos efeitos combinados da pandemia e da crise econômica, a contradição entre o direito ao lucro privado e o interesse geral tornou-se cada vez mais evidente. Apenas onde o poder público conservou um papel forte diante das pretensões do mercado, essa crise está sendo enfrentada com sucesso. Onde, pelo contrário, prevaleceu o domínio ideológico da metafísica do mercado, ou seja, a convicção segundo a qual intervir com medidas públicas no livre desenvolvimento da lei da oferta e da procura não passa de pura blasfêmia, tudo se tornou mais complicado. Nos países marcados pela contradição entre miséria absoluta e imensas concentrações da riqueza econômica, nos quais prevalecem a especulação e a lucratividade privada sobre as atividades eminentemente públicas (educação, universidade, saúde, pesquisa, sistema de aposentadoria, políticas de assistência e inclusão social), estamos observando um autêntico fracasso, que alcança proporções inimagináveis se comparamos com a situação de cinco meses atrás.
- A transfiguração ideológica da realidade
A mística do mercado, que subordina o homem à ilusão ideológica da “mão invisível”, é a forma mais sistemática e alienante de totalitarismo criada pelo homem. Um artifício retórico que consegue apresentar o direito à exploração do homem como uma filosofia de liberdade, e não de escravidão. O paradigma do egoísmo absoluto, tornado universal por um hábil trabalho ideológico de reconstrução interessada da realidade, é uma lei de ferro que produz riqueza para poucos e miséria para os demais. A suposta superioridade econômica do liberalismo é um escárnio colossal; a vitória dos netos de Adam Smith se dá em terreno hegemônico, por meio da auto-apologia, certamente não do lado do bem-estar e da riqueza social. Marx e Engels trataram não apenas das condições materiais no fundo dos acontecimentos históricos, eles investigaram a função política das ideologias em relação à tarefa da defesa e da conservação dos equilíbrios passivos tradicionais entre as classes. A história, a filosofia, o direito, a economia, a religião e todas as representações espirituais da realidade tornam-se instrumentos de governo de uma classe sobre as outras, por meio das quais cria-se um conformismo social entre os dominantes e, ao mesmo tempo, se arregimentam os dominados garantindo sua passividade. As ideias da classe dominante são, em cada época, as ideias dominantes, então, essa classe é ao mesmo tempo a força material e espiritual dominante, porque não controla apenas os meios de produção material, mas dispõe também dos meios de produção espiritual. Essas ideias, portanto, sempre se tornam a expressão ideal das relações materiais dominantes, concebidas como ideias que marcam uma inteira era histórica. Estritamente entrelaçada a essa função especializada de produção, Marx e Engels sublinharam a centralidade da separação entre trabalho espiritual e material:
A divisão do trabalho expressa-se também no seio da classe dominante como divisão do trabalho espiritual e material, de tal modo que no interior desta classe uma parte aparece como os pensadores desta classe (seus ideólogos ativos, conceptivos, que fazem da formação de ilusões desta classe a respeito de si mesma seu modo principal de subsistência), enquanto que os outros relacionam-se com estas ideias e ilusões de maneira mais passiva e receptiva, pois são, na realidade, os membros ativos desta classe e têm pouco tempo para produzir ideias e ilusões acerca de si próprios.[2]
- O capitalismo vive porque são os homens que lhe dão vida e o fazem viver
O capitalismo não existe por causa da objetividade implacável de suas leis, assim como jamais será superado única e exclusivamente por causa de suas contradições internas. Esse modo social de produção sobrevive à sucessão de suas crises devastadoras, não pela inegável eficiência econômica de seus equilíbrios, mas porque os homens o mantêm vivo mesmo através de terapias intensivas e, se necessário, por meio de involuções autoritárias (a era do fascismo). Isso porque o capitalismo (além da dominação) não é apenas economia, é também política, filosofia, relações hegemônicas, ou seja, um formidável arsenal capaz de transfigurar a realidade (dando a aparência de universalidade a certos interesses particulares) a ponto de tornar-se a miséria e a exploração “consensualmente” aceitas pelo miserável e pelo explorado[3].
Tanto o liberalismo clássico (segundo o qual o capitalismo não seria um sistema artificial, mas uma realidade objetiva independente da vontade humana, determinada “naturalmente” pelas leis da oferta e da procura) quanto o determinismo marxista (durante anos convencido de que esse sistema econômico burguês entraria em colapso por causa de suas contradições internas) compartilham a mesma visão metafísica das coisas. Cada modo social de produção sempre é o fruto de uma complexa combinação de elementos objetivos e subjetivos em que o fator econômico é sem dúvida predominante, mas não o único. Historicamente, a sociedade burguesa se afirmou no plano econômico e ideológico, no sentido de que era o resultado de uma autodeterminação material e espiritual com a qual essa classe conseguiu escapar tanto das regras corporativas da antiga sociedade feudal (conquistando sua autonomia econômica) quanto da visão de mundo da aristocracia feudal (afirmando o princípio da dignidade humana universal em oposição ao particularismo feudal, que determinou o status legal em razão do nascimento)[4]. O segundo elemento é certamente (em geral) colocado em condição de dependência em relação ao primeiro, mas isso não significa que seja secundário[5]. Por tudo isso, esperar que o capitalismo seja superado por suas contradições internas, quase sem esforço de luta, portanto, sem a irrupção da vontade ativa das massas, sem política e ideologia, significa atribuir a esse modo social de produção uma existência autônoma, independente da vida humana, para torná-lo uma divindade que, por sua natureza transcendente, existe não por causa da vontade humana, mas como consequência da fatalidade das coisas. O velho determinismo socialista veiculou Marx por meio de Darwin e aplicou à história a dinâmica evolutiva das ciências naturais, chegando à conclusão de que a humanidade passaria do feudalismo ao capitalismo e, portanto, ao socialismo, por razões internas às leis da economia, evidentemente, assim como na evolução da espécie passa-se do símio ao homem. As consequências políticas dessa concepção foram três: 1) atribuir aos protagonistas de sua emancipação (o proletariado) uma função totalmente secundária em relação aos líderes encarregados de entender essas leis e enxergar, dentro delas, a hora fatídica da “crise final”; 2) a ideia de que não se deve fazer a revolução, mas preparar sua implacável inelutabilidade, acumulando forças; 3) a convicção de que toda a humanidade estava destinada a viver os mesmos processos evolutivos, pois era necessário percorrer o caminho da via crucis do capitalismo (a civilização industrial do tipo ocidental) para passar à integral emancipação do homem. Este terceiro termo levou o movimento socialista a desinteressar-se da questão camponesa e da questão colonial, a ponto de olhar positivamente para a função civilizadora e modernizadora do imperialismo ocidental. Todos esses três termos foram literalmente varridos pela Revolução de Outubro, e, mais genericamente, todo o conceito de positivismo determinista foi duramente contestado não apenas por Lênin, mas pelo próprio Friedrich Engels:
Segundo a concepção materialista da história, o fator que em última instância é determinante na história é a produção e reprodução da vida real. Mais do que isso nunca foi afirmado nem por Marx nem por mim. Se agora alguém deturpa as coisas, afirmando que o fator econômico é o único determinante, transforma aquela proposição em uma frase vazia, abstrata, absurda. A situação econômica é a base, mas os diversos momentos da superestrutura […] exercem sua própria influência no curso da luta histórica e, em muitos casos, determinam sua forma predominante. Há uma ação recíproca de todos esses fatores, e é através deles que o movimento econômico termina por afirmar-se como elemento central em meio à infinidade de acontecimentos acidentais […], se assim não fosse, a aplicação da teoria em um determinado período da história seria mais simples que a mais elementar equação de primeiro grau[6].
- A queda da religião da liberdade e o relativismo liberal
O capitalismo é um modo de produção social historicamente determinado, portanto, historicamente superável como qualquer produto humano. A questão é que, por sua própria e íntima natureza, esse sistema não só é profundamente revolucionário (sempre pronto para mudar as técnicas de produção, as formas de distribuição, as relações sociais e institucionais), mas tem um arsenal material e imaterial (hegemônico) que nenhuma forma social jamais teve antes na história.
Tendo claro tudo isso, a atual crise nos mostra a necessidade de concentrar nossa investigação crítica não apenas nas contradições da estrutura econômica, mas nos aparelhos hegemônicos por meio dos quais molda-se a opinião pública. Estamos vivendo uma fase de gravíssima crise sanitária e política que atinge de forma combinada o Brasil e o mundo, em que tanto a vida das pessoas quanto as liberdades democráticas estão em perigo diante das constantes tensões entres os poderes do Estado e das recorrentes tentações autoritárias que permeiam parte significativa das classes dirigentes e da sociedade brasileira.
Antigamente o liberalismo se definia de início por sua devoção filosófica à “religião da liberdade”. Assim, Benedetto Croce, um dos maiores filósofos do liberalismo no século XX, enfatizando que essa doutrina não pode ser contrária, em princípio, à “socialização e [à] estatização dos meios de produção”, ressaltou que a convergência entre liberalismo político e liberalismo econômico foi apenas de natureza empírica e provisória, rejeitando a tendência de apresentar as duas dimensões como idênticas:
Como já deveria ser pacífico, o liberalismo não coincide com o chamado liberalismo econômico, com o qual teve apenas concomitâncias, e talvez ainda tenha, mas sempre com uma aparência provisória e contingente, sem atribuir à máxima de deixar outro valor que não o empírico, como válido em certas circunstâncias e não válido em circunstâncias diferentes. Portanto, nem pode rejeitar em princípio a socialização ou estatização dos meios de produção, nem sempre a rejeitou no fato de ter feito, de fato, bastantes obras desse tipo.[7]
Quando isso aconteceu, a recusa foi determinada por razões práticas, não teóricas, ou seja, pela convicção de que tal escolha em determinado momento (não em termos absolutos) poderia ter deprimido a economia gerando um empobrecimento geral sem reduzir as desigualdades. O julgamento de qualquer reforma, segundo Croce, depende antes de tudo de um fator: se ela promove ou restringe a liberdade e a vida dos homens. A devoção à religião da liberdade levou John Stuart Mill a definir o liberalismo inicialmente como recusa de qualquer monismo de valores ou conformismo intelectual, que pelo contrário prevalece prevalente na cultura liberal de hoje:
Se todos os homens, exceto um, tivessem a mesma opinião, e apenas um fosse de opinião contrária, a humanidade não teria maior justificativa para silenciar esse homem do que ele teria, se tivesse o poder, para silenciar a humanidade […] o mal singular de silenciar a expressão de uma opinião é que isso rouba ao gênero humano, tanto a posterioridade quanto a geração existente, e aqueles que discordam da opinião ainda mais do que aqueles que estão de acordo. Se a opinião é correta, a humanidade se priva da oportunidade de trocar o erro pela verdade; se errada, perde aquilo que quase constitui um grande benefício; ou seja, a percepção mais clara e a impressão mais viva da verdade, produzida pela sua colisão com o erro.[8]
Falando de outro autor liberal clássico, Isaiah Berlin, o alvo central de sua obra é o pluralismo dos valores, a convicção de que as visões do mundo que inspiram a vida dos seres humanos sejam não apenas muitas e diversificadas, mas, em vários casos, inconciliáveis e até incompatíveis. Tanto ao nível das culturas gerais quanto em relação aos valores de uma mesma cultura ou pessoa. Seria característico das grandes religiões e das ideologias monistas achar que existe apenas um jeito correto de viver, uma só estrutura de valores de verdade, ou seja, afirmar, de forma fanática e indiscutível, a unicidade de uma tese que inevitavelmente desemboca na perseguição dos valores críticos ou não homologados. O pluralismo seria o único antídoto ao fundamentalismo, uma fonte perene de liberalismo e de tolerância que nunca pretende apagar as outras visões do mundo por ter vieses alternativos a nossas convicções mais profundas[9]. Por concluir com este tema, John Rawls escreve que uma sociedade liberal bem ordenada e regulada por uma concepção política de justiça (como equidade) assim o pode ser apenas dentro de um quadro de razoável pluralismo. Outro objetivo do liberalismo político é descrever como deve ser concebida e quais bases de unidade social deve ter uma sociedade liberal bem ordenada, cuja articulação torne possível o relacionamento dialético entre visões políticas razoavelmente diferentes. A cultura política de uma sociedade liberal democrática é sempre marcada pela presença de diversas doutrinas religiosas, filosóficas e morais em conflito: dialética que o liberalismo considera resultado inevitável do livre exercício das faculdades da razão humana[10].
Um sinal inequívoco do refluxo democrático desses anos nos é dado pelas contradições do mundo liberal, justamente no que diz respeito à questão das liberdades. A dimensão econômica (liberalismo) ocupou definitivamente toda a cena, de modo que a devoção à metafísica do mercado leva os liberais de hoje a considerar sagrada apenas a liberdade de iniciativa econômica. A esfera político-filosófica liberal, por outro lado, acabou encolhendo tanto que o tema das “liberdades fundamentais” parece ser simples retórica em defesa do mero individualismo econômico. Assim, hoje, aqueles que se autodenominam liberais olham com irritação mal disfarçada para as reivindicações de liberdades civis, sexuais e religiosas, bem como para a ideia de pluralismo político, cultural, filosófico e científico. Em suma, eles não suportam o poder público quando se trata de seus negócios, mas gostariam de um Estado autoritário e inquisitorial para comprimir todas as liberdades humanas, exceto a econômica, é claro.
A ideia de uma relação inversamente proporcional entre a esfera da liberdade e a extensão das atividades do Estado tornou-se dos mais duradouros mitos ideológicos, que tornam comum as concepções do “governo limitado” de John Locke e as teorias sobre o totalitarismo de Hannah Arendt. A condenação preventiva ou póstuma à ambição de regulamentar a vida social, intervir na economia e fornecer uma direção social à vida de uma comunidade nacional está diretamente entrelaçada com a mais eficaz representação ideológica do pensamento liberal: a capacidade natural de autorregulamentação das leis do mercado, teoricamente não compatível com a artificial irrupção ordenadora da política. Mas, como escreveu Gramsci, atrás dessa visão o erro teórico justifica-se pelo interesse prático:
A abordagem do movimento de livre comércio baseia-se em um erro teórico do qual não é difícil identificar a origem prática: na distinção entre sociedade política e sociedade civil, que é feita e apresentada como uma distinção orgânica. Assim, afirma-se que a atividade econômica é própria da sociedade civil e que o Estado não deve intervir na sua regulação. Mas, como na realidade a sociedade civil e o Estado coincidem, é preciso estabelecer que o liberalismo econômico é uma regulamentação de caráter estatal, introduzida e mantida por meios legislativos e coercitivos: é um fato de vontade consciente, e não a expressão espontânea e automática do fato econômico.[11]
De acordo com essa visão do mundo, atividades reconduzíveis à iniciativa econômica autônoma de indivíduos privados não podem ser objeto de interferência política porque, “naturalmente”, as leis da oferta e da procura sempre encontram soluções mais adequadas, eficazes e eficientes do que qualquer hipótese de regulação social. A realidade mostra que tanto os grandes empresários quanto seus teóricos são a favor do liberalismo econômico quando pode gerar lucro, mas se tornam intervencionistas quando arriscam seus ativos, porque, assim que os bancos e as grandes empresas veem suas margens de lucro reduzidas, exigem intervenção pública para salvar a economia privada.
Essas situações dramáticas para a humanidade, se de nada mais servirem, são úteis para entender tanto as contradições do liberalismo quanto o relativismo de valores imanentes a essa doutrina: “se a economia cresce, os lucros são meus, entretanto, quando há uma crise, a queda é de todos”. Os lucros são privados, mas as perdas devem ser socializadas. Assim, se normalmente os apologistas do “privado é melhor” invocam o Estado mínimo, considerando blasfêmia a ingerência da política na capacidade “natural” do mercado de se regular, durante as recessões invariavelmente pedem a ajuda do público. Como escreveu Marx a respeito da crise do capitalismo de 1857, “é bom ver que os capitalistas, que tanto gritam contra o direito ao trabalho, agora exigem o apoio público dos governos em todos os lugares, e reivindicam o direito ao lucro às custas da comunidade”[12].
***
Concluindo, apesar das transfigurações ideológicas e das narrações hegemônicas que marcam tanto a luta política quanto o enfrentamento ideológico, como era inevitável, também os efeitos da covid-19 reproduzem um quadro social marcado por uma brutal e unilateral luta de classes (de cima para baixo). No início da pandemia, ouvimos jornalistas falando de um vírus democrático, que não olha a classe social dos atingidos. Nada mais errado. Pelo contrário, a pandemia está desmascarando ainda mais a estrutura oligárquica e classista do país, onde, justamente por tal estrutura, essa doença golpeia sobretudo os mais pobres. O coronavirus chegou ao Brasil de avião, veiculado pelos representantes daquelas mesmas “classes nobres” que hoje pretendem reabrir tudo para retomar as atividades econômicas, todavia, quem está pagando realmente a conta dos erros políticos e da insensatez social espalhada nesse período pelo Brasil são as periferias, as favelas, as áreas rurais largadas ao seu próprio destino e, nelas, os “homens condenados a comer seu pão com o suor de seu rosto”.
[1] Karl Marx, O capital: crítica da economia política, Livro I: O processo de produção do capital, trad. Rubens Enderle,, Boitempo, São Paulo, 2011, p. 960-1.
[2] Karl Marx e Friedrich Engels, A ideologia alemã, trad. Luciano Cavini Martorano, Nélio Schneider e Rubens Enderle, São Paulo, Boitempo, 2007, p. 47.
[3] “Até agora, a arte do governo nada mais tem sido do que a arte de despojar e escravizar a maioria em benefício de uma minoria; e a legislação nada mais tem sido do que o instrumento para erguer esses ataques sistêmicos. Reis e aristocratas fizeram seu trabalho perfeitamente: agora cabe a você fazer o seu.” M. Robespierre, “Discurso sobre o governo representativo”, 10 de maio de 1793, em A revolução jacobina (Roma, Editori Riuniti, 1967), p. 127 (a tradução deste trecho do italiano para o português é de minha autoria).
[4] “Desde este instante, a consciência está em condições de emancipar-se do mundo e entregar-se à criação da teoria, da teologia, da filosofia, da moral, puras. Mas ainda que esta teoria, esta teologia, esta filosofia e esta moral entrem contradição com as relações existentes, isso pode acontecer porque as relações sociais existentes se encontram em contradição com as forças de produção existentes.” Karl Marx e Friedrich Engels, A ideologia alemã, cit., p. 16.
[5] “A classe revolucionária, por já se defrontar desde o início com uma classe, surge não como classe, mas sim como representante de toda a sociedade; ela aparece como a massa inteira da sociedade diante da única classe dominante. Ela pode fazer isso porque no início seu interesse realmente ainda coincide com o interesse coletivo de todas as demais classes não dominantes e porque, sob a pressão das condições até então existentes, seu interesse ainda não pôde se desenvolver como interesse particular de uma classe particular. […] Toda essa aparência, como se a dominação de uma classe determinada fosse apenas a dominação de certas ideias, desaparece por si só, naturalmente, tão logo a dominação de classe deixa de ser a forma do ordenamento social, tão logo não seja mais necessário apresentar um interesse particular como geral ou ‘o geral’ como dominante.” Ibidem, p. 49-50.
[6] Friedrich Engels, Sul materialismo storico (Roma, Editori Riuniti, 1949), p. 75.
[7] Benedetto Croce, Storia d’Europa nel secolo decimonono (Bari, Laterza, 1965), p. 34-5.
[8] John Stuart Mill, Da liberdade individual e econômica (Barueri, Faro editorial, 2019), p. 30.
[9]Isaiah Berlin, Libertà (org. Henry Hardy, Milão, Feltrinelli, 2005), p. 62.
[10] John Rawls, O liberalismo político (São Paulo, Atíca, 2000), p. 46-7.
[11] Antonio Gramsci, Quaderni del carcere 13 (Roma, Editori Riuniti, 1975), p. 1.590.
[12] Carta de Karl Marx ao Friedrich Engels de 13 de novembro de 1857, em Karl Marx e Friedrich Engels, Carteggio (Roma, Editori Riuniti, 1972), vol. III, p. 58.

Il giovane Berlinguer (1943-1950). Tra antifascismo e ricostruzione democratica
Enrico Berlinguer aderì al PCI nell’agosto del 1943, dopo essersi recato con il cugino Sergio Siglienti presso la serra di fiori del pistoiese Renato Bianchi, sede delle riunioni clandestine dei comunisti sassaresi. Nonostante la provenienza sociale, una famiglia importante e carica di storia come i Berlinguer, Enrico si avvicinò al mondo comunista frequentando gli ambienti popolari di Sassari. L’antifascismo faceva parte del codice genetico della sua famiglia, il padre Mario, repubblicano, era una delle personalità più in vista dell’antifascismo sardo e la sua casa era un punto d’incontro politico e intellettuale degli ambienti della borghesia sassarese avversa a Mussolini. Le prime letture sovversive, Bakunin e Marx, arrivarono grazie allo zio paterno Ettore, il più giovane degli zii, scapestrato ed eterno scapolone, ritenuto la pecora nera della famiglia, di orientamento libertario con sfumature che andavano dalle istanze anarcoidi a quelle comuniste. Era lo zio preferito del giovane e ribelle Enrico, piuttosto refrattario alle regole familiari, tanto da avere una vita assai stentata da studente nel prestigioso Liceo Classico Azuni di Sassari. Come numerose biografie hanno ampiamente chiarito, quelle di Peppino Fiori[1] e di Chiara Valentini[2] tra tutte, il giovane Berlinguer alla scuola preferiva le interminabili le partite a poker in un vecchio Bar del centro di Sassari, dal nome altisonante ben poco rispondente alla realtà del luogo, l’Apollo, o nella famigerata bettola di Rubattu, frequentata da operai, artigiani e contadini della città. In questi ambienti ben diversi da quelli familiari, saturi di fumo e odorosi di vino, tra una partita e l’altra si discorreva anche di antifascismo e persino di comunismo. Il suo primo incarico di partito fu organizzare i giovani, e in poco tempo divenne il punto di riferimento delle nuove leve comuniste sassaresi, mostrando doti organizzative ed intellettuali sorprendenti. La vita politica sassarese e più in generale quella sarda erano però al tempo molto limitate, in una condizione oggettivamente arretrata rispetto al resto del Paese. Quando lasciò l’isola, dopo la parentesi romana, Berlinguer trovò a Milano una realtà antifascista profondamente diversa, nella quale le esperienze sociali e politiche della mobilitazione popolare e quelle della lotta armata al nazifascismo avevano contribuito a formare un corpo di dirigenti e militanti di prim’ordine.
Già dalla metà degli anni Trenta all’interno delle stesse organizzazioni di massa del regime si era formata una fronda giovanile destinata ad avere un ruolo fondamentale nella Resistenza. È una generazione precedente a quella di Berlinguer, giovani nati circa un decennio prima, in gran parte sedotti da alcune parole d’ordine anticapitalistiche del fascismo rivoluzionario, che ben presto scoprono la reale natura sociale del regime e compiono una scelta di opposizione proprio negli anni di maggior consenso per Mussolini, una fase comunque attraversata da un clima di strisciante inquietudine tra un numero sempre maggiore di giovani, educati nella dottrina del fascismo, ma profondamente insoddisfatti delle sue realizzazioni concrete. La sede, dove si forma e ha modo di mettersi in connessione questa fronda, è il luogo dove il regime avrebbe voluto celebrare la sua grandezza e continuità presso le nuove generazioni, i Littoriali della cultura. Sono importanti i nomi che transitano in questo universo Ruggero Zangrandi, Mario Alicata, Renato Guttuso, Antonello Trombadori, Alberto Vigevano, Ernesto Treccani, Pietro Ingrao,Vittorini e tanti altri, tra loro una figura destinata a diventare punto di riferimento per Enrico Berlinguer, e non solo, Eugenio Curiel.
Lo smottamento generazionale nel fascismo fu un processo molecolare, anche se frammentario, di cui non si può indicare un inizio preciso – per alcuni fu il 1935 per altri il ‘38 – nel quale giovani con storie e formazioni diverse entrarono direttamente o indirettamente in contatto con la rete clandestina antifascista o ne subirono il fascino. Si trattava in gran parte di studenti e operai, alcuni di loro non si definivano, né si sentivano, comunisti eppure cercavano il contatto con il partito, altri si proclamavano tali anche senza aver mai avuto nessun tipo di rapporto con l’organizzazione.
Nella storia non sono mancate fratture generazionali, tuttavia, i risultati più profondi in termini di rinnovamento si sono avuti quando tra vecchie e nuove generazioni si è determinata una saldatura incentrata sulle scelte di campo. La lotta di liberazione dal nazifascismo è un esempio in tal senso, proprio per l’irrompere diffuso di giovani cresciuti nel regime che, nella clandestinità, trovarono un terreno d’incontro con i vecchi protagonisti dell’antifascismo sconfitto da Mussolini. Ovviamente questo processo non è lineare, privo di incoerenze e arretramenti, invece, è incredibilmente accidentato, all’interno di una realtà lacerata da profonde divisioni sedimentatesi negli anni come l’antifascismo italiano. La stessa organizzazione cui decide di aderire, il Partito comunista, vive, tra il 1926 e il ’36, scontri furibondi, sconfitte cocenti, epurazioni feroci, ripensamenti traumatici, mutamenti radicali di linea politica[3]. Proprio per la problematicità e i segnali contrastanti di questa vicenda, l’esito positivo del processo di liberazione nazionale dal nazifascismo assume un certo interesse storico[4].
Tra le vecchie generazioni di antifascisti, in gran parte esuli sconfitti anche se non piegati dal fascismo, e questi giovani c’era un salto generazionale, ciò nonostante, negli anni a cavallo tra i Trenta e i Quaranta si determinò una saldatura destinata a costituire la spina dorsale della Resistenza. I leader del vecchio movimento antifascista, costretti all’emigrazione dopo il carcere e le violenze subite, senza l’apporto delle nuove generazioni difficilmente avrebbero potuto dar corso a una tanto vasta mobilitazione contro il movimento di Mussolini. Per certi versi, prima ancora delle leggi razziali, dell’alleanza con la Germania di Hitler e la rovinosa partecipazione alla guerra, le originarie crepe alla stabilità del regime erano da ricercarsi nella perdita di egemonia presso le nuove generazioni. Le nuove leve allevate a “pane e fascismo” e non contaminate dal germe delle ideologie liberali, democratiche o marxiste, quelle su cui il regime tanto aveva puntato e da cui doveva venir fuori «l’uomo nuovo fascista», si rivelarono in definitiva il suo punto debole[5]. Ma al di là dell’aspetto quantitativo, di massa, l’apporto di questa generazione è determinante perché sollecitò il vecchio antifascismo ad abbandonare il suo settarismo, la vocazione romantica e volontarista dell’approccio cospirativo, insomma lo aiutò a superare la sua natura minoritaria, spingendolo a radicarsi nel Paese, tra i giovani e i lavoratori[6]. Il fascismo non si reggeva solo sul dominio violento, esercitava un consenso reale, se s’intendeva rovesciarlo bisognava lavorare anche con quanti erano rimasti sedotti dalle illusioni della demagogia fascista. Nel PCI, ad esempio, la scelta di abbandonare la politica disastrosa del socialfascismo e abbracciare quella dell’unità delle forze democratiche contro il fascismo fu accompagnata e sperimentata anzitutto da questa generazione, impegnata a lavorare nei sindacati fascisti come nei GUF.
Come Tortorella ha chiarito, in un’intervista concessami per la realizzazione di un mio libro dedicato a Eugenio Curiel, a questa generazione si unì quella dei giovani fascisti partiti in guerra che scoprirono proprio al fronte le bugie del regime tanto da decidere, al loro ritorno, di arruolarsi nelle brigate partigiane. Infine ci fu l’ultima generazione, di cui facevano parte Berlinguer e il più giovane Tortorella:
“Non eravamo la generazione del fascismo né quella dell’antifascismo eroico pre guerra, bensì la generazione della Resistenza, ossia, diventammo adulti nella lotta di liberazione trovandoci “impigliati”, volenti o nolenti, nella Resistenza”.
In Sardegna, il peso dell’antifascismo, anche dopo il 25 luglio ‘43, era assai modesto, con limitate capacità di egemonia politica, circoscritto agli ambienti intellettuali delle città e ad alcune ristrette fronde tra i ceti medi. Dopo l’8 settembre prese le mosse una prima rete di coordinamento, il Comitato di concentrazione antifascista, incapace però di andare oltre la ristretta cerchia del vecchio notabilato liberale. Anche l’agonia e il crollo del regime fascista avvennero senza particolari scossoni e nella quasi assenza di qualsiasi forma di mobilitazione popolare. Solo nei primi mesi del ’44, in particolare a Ozieri e, come vedremo, a Sassari, scoppiarono dei moti popolari di un certo rilievo conclusisi con l’assalto agli edifici pubblici e la cacciata dei funzionari amministrativi, ma si trattava di lotte per la sopravvivenza più che consapevole azione antifascista. Diverso era il caso del bacino minerario del Sulcis, attivo sia sul versante politico sia sindacale, dove l’attività antifascista si sviluppò intensamente e con continuità tra il 1944-’45. Nonostante questi limiti, secondo Giovanni Lay, l’attività dei comunisti sardi, per quanto marginale, non si era mai arrestata ed era comunque continuata fino alla caduta del regime, pur nell’assenza di contatti organizzativi stabili. Tra il 1942 e il 43, lo sfollamento di Cagliari aveva portato i militanti comunisti, che lasciavano la città con le famiglie, ad iniziare un’opera di proselitismo nei paesi in cui andavano ad insediarsi. Così, grazie all’opera di piccoli nuclei, già all’indomani dell’arresto di Mussolini si costituirono nei centri agricoli della Sardegna i primi gruppi e in diversi casi le prime sezioni comuniste, tanto che nel tumultuoso post 25 luglio la rete di questi gruppi era riuscita ad organizzare una prima riunione a San Gavino. I mesi che seguirono furono un brulicare di attività che portarono l’organizzazione ad articolare e radicare la sua presenza nei diversi centri dell’isola fino al Convegno regionale del 5 novembre 1943, che sanciva la sua linea di lavoro indicando il piano di collaborazione con gli altri partiti antifascisti. L’isolamento geografico e l’assenza di contatti con la ricostituita direzione nazionale avevano lasciato fuori il PCI sardo dalla «Svolta di Salerno», recepita dai vecchi qudri come un «abile espediente tattico». Gli strascichi di bordighismo, di cui Berlinguer parlò riferendosi alla situazione sassarese, avevano contribuito far sopravvivere un’idea settaria dell’azione comunista, fatta di elementare determinismo economico e intransigente fede rivoluzionaria. In questa dialettica s’inseriva però la novità delle giovani leve, Berlinguer e Renzo Laconi tra tutti[7]. Il 13 gennaio del 1944, scoppiarono a Sassari i moti del pane, per la difficile situazione alimentare in una città assediata dal freddo, fu un inverno particolarmente gelido, e dalla fame, causata da una gestione disastrosa, quando non proprio malavitosa (legata al mercato nero) delle risorse annonarie da parte delle autorità civili e militari. Per due giorni la città fu infiammata da veri e propri moti insurrezionali popolari, scontri con i carabinieri, assalti a Municipio, panifici, pastifici e soprattutto ai depositi delle derrate alimentari. Berlinguer e il gruppo di giovani costituitosi attorno a lui, nonostante la forte contrarietà degli adulti del partito, furono tra i protagonisti di queste vicende.
Intanto a livello nazionale, nell’autunno del 1943, nel partito, si era discusso su quale sarebbe dovuto essere il modo più appropriato per intercettare i giovani, rilanciare la Federazione giovanile comunista oppure creare un organismo unitario della gioventù antifascista?[8] Prevalse questa seconda possibilità, così su indicazione del Centro comunista e grazie all’impegno di Giancarlo Pajetta, a Milano, nel gennaio del 1944, fu creato il Fronte della Gioventù[9]. Non si trattava di un’organizzazione giovanile riservata ai comunisti o ai simpatizzanti, esso nasceva come fronte unitario con lo scopo di raccogliere e valorizzare le energie militanti delle nuove generazioni disposte a lottare contro l’occupazione nazifascista sul terreno militare, nella lotta economica e sindacale, in quella culturale ed educativa. A Pajetta si affiancarono Gillo Pontecorvo, militante nelle file antifasciste dal 1938, e Eugenio Curiel[10]. I primi due lavoravano anzitutto per stabilire rapporti con giovani socialisti, liberali e cattolici, studenti indipendenti. Con l’arrivo di Curiel a Milano, Pajetta passò ad altri incarichi, mentre al primo fu affidata la responsabilità di seguire e dirigere il movimento giovanile. Ai primi di dicembre del 1943 Ingrao, con cui aveva lavorato fino a quel momento, fu mandato dal partito a Roma, allora Gillo Pontecorvo iniziò a lavorare sotto la direzione di Eugenio Curiel, «una delle personalità più straordinarie della Resistenza italiana, il comandante “Barbieri”, colto, audace, coraggioso», di cui di fatto divenne il vice[11]. Curiel affidò al futuro regista il compito di formare un’organizzazione clandestina unitaria con tutti i partiti antifascisti, democristiani e liberali compresi: il Fronte della Gioventù. Pontecorvo ricorda che l’impresa dei due, nei rapporti con i cattolici, fu aiutata dal gruppo di sacerdoti della chiesa di San Carlo al corso, tra i quali David Maria Turoldo e Camillo De Piaz. Dalla costituzione del Fronte si passò, nel febbraio ’44, alla creazione di gruppi armati per la necessità di estendere l’attività dell’organizzazione dal solo terreno politico a quello militare. Fu così creata una prima brigata con la funzione di compiere azioni di disturbo contro fascisti e tedeschi, Pontecorvo, già responsabile politico, ne assunse la direzione.
A Sassari, tre giorni dopo i moti per il pane, Berlinguer venne arrestato e incarcerato nelle prigioni di San Sebastiano. Fu liberato, insieme ai suoi compagni, il 25 aprile del 1944. Proprio in questi mesi Berlinguer decise di abbandonare l’università (la facoltà di giurisprudenza dove si era iscritto nel 1940), per dedicarsi completamente al lavoro politico per il partito. Dopo un primo incontro con Togliatti, favorito dal padre Mario impegnato in prima fila a Salerno, si trasferì a Roma nel settembre del ’44 per andare a lavorare alla direzione comunista accompagnato da un bigliettino vergato personalmente dal “Migliore”, “questo è il compagno Berlinguer, che viene dalla Sardegna, Utilizzatelo nella vostra organizzazione”.
La sua prima mansione fu l’organizzazione sindacale tra i giovani, quindi venne inviato a Milano per prendere il posto di Eugenio Curiel (ucciso dai fascisti il 24 febbraio) a capo dell’organizzazione giovanile. A Milano era presente una forte organizzazione misuratasi nell’attività clandestina, a Berlinguer fu affidato il compito di traghettarla in campo aperto, nell’attività legale del nuovo quadro democratico. Pontecorvo era ora il coinquilino del futuro Segretario del PCI[12], al di là del lavoro politico tra i due nacque un rapporto di amicizia strettissimo durato poi tutta la vita. Per Pontecorvo, Berlinguer era una sorta di rincarnazione del suo amico scomparso, perché avevano molte cose in comune, la serietà, la riservatezza, la passione per lo studio. «Per Curiel Berlinguer provava una vera curiosità. E si faceva raccontare tutto quello che poteva, studiava i suoi rapporti e i suoi documenti»[13]. L’arrivo a Milano di Berlinguer nell’estate del ‘45, in una fase complessa ed esaltante insieme, sembrò, al futuro regista, quasi colmare il vuoto enorme lasciato dalla morte del suo amico. Berlinguer sentiva di averne ereditato il ruolo, avvertiva appieno il peso di quella responsabilità fino a sentirsi persino inadeguato a farne le veci. Dopo la liberazione, Enrico Berlinguer promosse diverse attività – seminari di formazione, pubblicazioni, convegni e iniziative commemorative – con il preciso scopo di restituire al suo predecessore il giusto ruolo nella storia dell’antifascismo e, segnatamente, in quella dei comunisti italiani. Nella direzione milanese Berlinguer trovò anzitutto Luigi Longo, quindi il gruppo di giovani formatisi nel FdG attorno a Curiel, tra questi, oltre al già citato Pontecorvo con cui condivideva una stanza con due brandine, nella sede del Partito in via dei Filodrammatici, un certo Aldo Tortorella.
Al VI Congresso del PCI, tenutosi a Roma nel gennaio del 1946, divenne membro del Comitato Centrale e per Togliatti il giovane dirigente sardo avrebbe dovuto continuare a lavorare alla costruzione dell’organizzazione unitaria dell’antifascismo, estendendola dal Cetro Nord al Mezzogiorno. Così nel settembre 1946 si tenne a Bologna il Congresso nazionale del FdG, fu una triplice prova del fuoco per Berlinguer: 1) sul piano organizzativo, perché fu lui a costruirlo in ogni minimo aspetto; 2) sul piano politico, perché portò alla sua elezione a Segretario generale dell’organizzazione; 3) sul piano della comunicazione, perché concluse il Congresso con il suo primo grande comizio davanti a decine di migliaia di militanti arrivati da tutto il Paese. Il nuovo incarico sancì il suo ritorno a Roma, dove iniziò a lavorare sempre più a stretto contatto con Togliatti. Ma i rapporti sempre più tesi fra i Partiti che avevano dato vita al CLN, fino alla cacciata di comunisti e socialisti dal governo dopo il viaggio negli USA di De Gasperi, nel maggio del 1947, decretarono la fine del Fronte unitario giovanile. In realtà già a inizio anno, alla conferenza di organizzazione del partito a Firenze, Berlinguer aveva avanzato la necessità di affiancare il Fronte con un’organizzazione autonoma dei Giovani Comunisti.
Nel clima infuocato, interno e internazionale, che precedette le elezioni del 18 aprile ’48, nacquero, su idea di Luigi Longo, le «avanguardie garibaldine», organizzazione giovanili unitarie di socialisti e comunisti, che anche nel nome si richiamavano alla tradizione partigiana, a migliaia si riunirono in Congresso al Salone Ansaldo di Genova l’8 di febbraio. Due anni dopo, il 2 aprile 1950, veniva ricostituita, non casualmente a Livorno, la Federazione giovanile comunista, dopo che il CC del Partito aveva già deliberato in tal senso nel marzo del 1949. Nel mentre era successo di tutto, la sconfitta cocente alle elezioni politiche, l’attentato a Togliatti, uno sciopero generale spontaneo dilagato in moto insurrezionale in diverse parti del Paese a fatica fatto rientrare nei ranghi da un Togliatti scampato alla morte. Proprio lo stesso Togliatti, oramai completamente ristabilitosi, consegnò simbolicamente la bandiera rossa con la stella al centro e la sigla FGCI a Berlinguer, eletto segretario dell’organizzazione. La FGCI divenne «un partito nel partito», che in poco tempo raddoppiò i suoi iscritti fino a raggiungere e superare le 400 mila unità, un’organizzazione molto articolata (scuole quadri, associazioni sportive, ludiche culturali), coccolata, controllata e persino contesa da tre personalità piuttosto ingombranti, Togliatti, Secchia e Longo, ognuno dei quali con una sua idea particolare di cosa dovesse essere la federazione giovanile. Coerentemente con l’impostazione data da Togliatti al lavoro del Partito, il giovane Berlinguer concepiva in termini organici le tematiche della lotta al fascismo e quelli della ricostruzione democratica attraverso la stagione costituente[14]. Il punto d’intesa tra questi due momenti era l’idea della democrazia progressiva tanto cara al suo predecessore Curiel, ossia la prospettiva di un permanente allargamento degli spazi di democrazia economica, sociale e politica, tali da consentire al mondo del lavoro di conquistare posizioni di forza, in un processo di transizione democratica al socialismo. Bisognava rimuovere le radici economico sociali del fascismo, ossia la natura monopolistica di un certo suo capitalismo, il parassitismo oligarchico, causa congenita del sovversivismo reazionario di parte significativa delle sue classi dirigenti. Per raggiungere questo obiettivo, così come per quello precedente della liberazione dell’occupazione nazifascista, era essenziale trovare un’intesa unitaria con le altre forze popolari del Paese, non solo i socialisti ma anche e soprattutto le masse cattoliche. Al di là di miti e leggende sulla presunta “doppiezza togliattiana”, nella scelta operata con la svolta di salerno nel 1944, e in quelle successive, fino all’approvazione della Costituzione non c’era alcun espediente tattico, si trattava di scelte strategiche conseguenti alla ricerca di una via italiana al socialismo scaturite dalle specificità storiche, culturali e sociali della concreta realtà italiana[15]. Era un’anticipazione convinta del tema del policentrismo, poi sviluppato un decennio dopo da Togliatti. In tutto questo, il lavoro di Berlinguer a capo dell’organizzazione giovanile fu pienamente conseguente, senza esitazioni, nonostante i perturbamenti provocati da una fase storica, oramai dominata dal clima della guerra fredda, ricca di contraddizioni e fasi di arretramento. All’interno di questo universo, Enrico Berlinguer, entrato nel gennaio del 1948 nella ristretta e prestigiosa Direzione Nazionale, sebbene non avesse un Curriculum rivoluzionario paragonabile agli eroi della Resistenza, fosse schivo per natura, e evitasse in qualsiasi modo pose teatrali da capo carismatico, divenne la guida indiscussa e quasi idolatrata dei giovani comunisti. Sia chiaro, non fu una marcia trionfale, al contrario non tardrano a manifestarsi molteplici contraddizioni, soprattutto a partire dal 1956, con profonde ripercussioni sull’organizzazione uscita da quella profonda crisi ridimensionata per effettivi, peso e capacità di influenza.
* * *
A questa storia e quegli ideali giovanili di integrale emancipazione umana Berlinguer rimase fedele anche negli anni della maturità, senza mai prendere in considerazione l’ipotesi, poi materializzatasi dopo la sua morte, di liquidare o trasformare in altra cosa il PCI. Ciò nonostante, in vita e ancora più dopo la sua morte, attorno alla figura di Berlinguer le polemiche non sono mai cessate. Si può discutere a lungo se il ragionamento sulla “fine della spinta propulsiva della Rivoluzione d’ottobre” (e il conseguente distanziamento dall’URSS) fu o meno un errore strategico. È legittimo mettere in discussione la prospettiva del blocco di unità nazionale, per il cui successo mancavano le basi politiche, viste le ambiguità del PSI e le zone d’ombra nel principale partito di governo. Tuttavia, la direzione di Berlinguer rappresentò l’ultimo tentativo di rilanciare la questione comunista in Occidente con basi e prospettive di massa. Sicuramente il PCI fece diversi errori, tuttavia, Berlinguer comprese le prospettive di involuzione autoritaria e di riflusso democratico (il discorso sull’austerità e sulla necessità non solo di un diverso modello di sviluppo, ma di una civiltà su basi antropologicamente diverse, rientrava in questa preoccupazione). Al contrario, molti dei gruppi alla sua sinistra consideravano quella fase oggettivamente e soggettivamente rivoluzionaria, non la vigilia del riflusso, individuando nel PCI il principale ostacolo alla liberazione di nuove soggettività di classe e rivoluzionarie. Tutti quelli che lo hanno frequentato sanno perfettamente quanto Berlinguer vivesse con tormento il rischio di una svolta cilena nell’Italia della metà degli anni Settanta, e tutti quanti sappiamo come queste preoccupazioni fossero tutt’altro che campate in area. In quegli anni Berlinguer sollevò il problema del valore universale della democrazia non solo per polemizzare con la sottovalutazione sovietica di questo tema, ma anche per richiamare il quadro dell’arco costituzionale ai valori dell’antifascismo in una fase marcata dalla strategia della tensione e dai molteplici rischi di Golpe autoritari. Sicuramente sbagliò tanto sul piano dell’analisi quanto su quello della proposta politica, riconoscendolo qualche anno dopo, ma sbagliarono ancora di più quei gruppi convinti di essere alla vigilia della rivoluzione che non compresero l’importanza del PCI, in grado di inquadrare milioni di lavoratori e con una capacità di azione che nessun altro partito comunista in Occidente poteva vantare. Berlinguer ci rimanda a un’esperienza e a un tempo nel quale si guardava all’Italia come originale laboratorio politico, non solo per la presenza del più grande partito comunista dell’Occidente, in un Paese chiave per gli equilibri del Patto Atlantico, ma anche per il tentativo di rilancio sia dei suoi presupposti teorici, sia delle sue prospettive politiche in una fase di crisi del movimento a livello internazionale, soprattutto per le contraddizioni interne alla sua nazione guida. In una fase tanto drammatica Berlinguer trovò contro una parte consistente del suo partito, quella che poi prevalse, le diverse e litigiose anime del composito movimento antagonista e extraparlamentare, gli intellettuali che iniziavano a contrapporre il partito in quanto tale alla “società civile”, individuando proprio nel PCI il principale ostacolo al rinnovamento della sinistra. Tutte queste componenti, a partire da punti di vista differenti e con prospettive antitetiche, avevano un minimo comun denominatore, condiviso anche dalle ambizioni di cannibalismo politico di Bettino Craxi: la convinzione che con la fine del PCI si sarebbe superata un’anomalia che avrebbe spalancato le porte alla palingenesi (socialdemocratica, radicale o di classe) della sinistra italiana. Al contrario, dal funerale del PCI non si è determinata né la nascita di un serio e credibile partito di ispirazione socialdemocratica, né un movimento radicale e di classe capace di aprire al mondo del lavoro un nuovo terreno di lotte e conquiste. Al contrario l’Italia ha oggi la sinistra più marginale e priva di credibilità in Europa che di quegli anni ha però conservato una prerogativa: la litigiosità.
Nonostante la lezione della storia, a tanti anni di distanza, ancora non si riesce a sfuggire da quei vecchi posizionamenti, così le esigenze celebrative e politicamente neutralizzanti di quanti ne rinnegarono l’eredità politica convergono con quelle di coloro che individuano in Berlinguer il principale responsabile della fine del PCI, producendo atteggiamenti (speculari e perfettamente complementari) agiografici o liquidatori. Entrambe queste visioni sorvolano sulle contraddizioni storiche e politiche che inevitabilmente hanno reso accidentata e complessa una biografia politica e umana che comunque, dalla gioventù al drammatico comizio di Padova, rimane legata indissolubilmente, senza conversioni o rinnegamenti, alla storia del comunismo italiano. Piaccia o non piaccia, nell’immaginario collettivo della maggioranza degli italiani Berlinguer è ricordato non come un “uomo buono” o un banale riformista, ma come l’ultimo grande comunista del nostro Paese.
Gillo Pontecorvo ebbe a ricordare un aneddoto che racchiude bene la personalità di Enrico Berlinguer con la quale concludiamo questa riflessione. In una delle tante giornate milanesi, successive alla liberazione, un giornalista recatosi a intervistare il futuro regista, si voltò dall’altra parte della stanza e fece una domanda al giovane e ancora sconosciuto Berlinguer: «e lei?, da quanto è in politica?», Berlinguer sollevò la testa, sottraendosi alla lettura in cui era immerso, e lapidario rispose: «io non sono in politica, io sono comunista»[16].
[1] G. Fiori, Vita di Enrico Berlinguer, Laterza, Roma-Bari, 1989.
[2] C. Valentini, Berlinguer. L’eredità difficile, Editori Riuniti, Roma, 2007.
[3] P. Spriano, Storia del Partito comunista italiano. Gli anni della clandestinità, vol. II, Einaudi, Torino, 1969.
[4] P. Togliatti, Discorsi ai giovan, prefazione di E. Berlinguer, Editori riuniti, Roma, 1971.
[5] Ruggero Zangrandi, Il lungo viaggio attraverso il fascismo. Contributo alla storia di una generazione, Feltrinelli, Milano, 1976.
[6] P. Secchia, Lotta antifascista e giovani generazioni, La Pietra, Milano, 1973.
[7] P. Spriano, Storia del Partito comunista italiano. I fronti popolari, Stalin, la guerra. Vol. III, Einaudi, Torino, 1970.
[8] L. Longo, I centri dirigenti del PCI nella Resistenza, Editori Riuniti, Roma, 1977.
[9] P. Secchia, Il Partito comunista italiano e la guerra di liberazione nazionale (1943-1945), Annali Feltrinelli, anno tredicesimo, 1971, Milano.
[10] P. De Lazzari, Storia del Fronte della gioventù, Editori Riuniti, Roma, 1974.
[11] I. Bignardi, Memorie estorte a uno smemorato. Vita di Gillo Pontecorvo, Feltrinelli, Milano, 1999, pag. 47.
[12] «Hanno dato ad Enrico, un alloggio di emergenza: una brandina in uno stanzone scuro e spoglio della Direzione comunista per l’alta Italia, che ha sede in un vecchio palazzo d’abitazioni di via dei Filodrammatici, dietro la Scala. Poco distante, in via del Conservatorio 9, a due passi da San Babila, è la palazzina dell’ex Gil, che il 27 aprile 1945 le Brigate giovanili hanno occupato per metterci il Fronte della Gioventù», G. Fiori, Vita di Enrico Berlinguer, Laterza, Roma -Bari, 1989, pag. 59.
[13] I. Bignardi, Memorie estorte a uno smemorato. Vita di Gillo Pontecorvo, op. cit., pag. 64.
[14] «Critica Marxista», Gli anni di Berlinguer, n. 2-3, marzo giugno 1985, anno 23, Editori Riuniti, Roma.
[15] D. Sassoon, Togliatti e la via italiana al socialismo. Il Pci dal 1944 al 1964,Einaudi, Torino, 1980.
[16] I Bignardi, Memorie estorte a uno smemorato, Vita di Gillo Pontecorvo, Feltrinelli, Milano, 1999, pag. 64.

Il fascismo e la lunga coda di paglia dei liberali italiani
Il fascismo rappresenta un grande buco nero per la civiltà europea, nel nostro caso, la contraddizione nazionale rispetto alla quale i liberali italiani non riescono a nascondere la propria lunghissima coda di paglia. Per questa ragione Croce definì il fascismo una crisi morale europea senza alcuna radice sociale (borghesia) o politica (liberalismo) riconducibile al suo album di famiglia e, oggi, i suoi discendenti, anziché studiare le responsabilità endogene del collasso liberale, preferiscono considerarlo una conseguenza del fanatismo totalitario bolscevico, non il prodotto storico del colonialismo e del suo portato ideologico autoritario e razzista di dominio assoluto di una civiltà sulle altre.
L’operazione del “Corriere della sera” annunciata in questi giorni, che si dimentica totalmente di storicizzare le gravi colpe del liberalismo italiano, conferma questo canone interpretativo e la scelta di campo autoindulgente e conservatrice. Eppure, non sono mancati studiosi e intellettuali liberali, come Denis Mack Smith, che hanno localizzato nella debole tradizione liberale e democratica italiana la ragione della capitolazione dei principali leaders liberali di fronte a Mussolini. Così come, in Italia, (senza citare Gramsci) altri liberali come Gobetti e Guido De Ruggiero hanno sottolineato le cause del baratro fascista in una contraddizione tutta interna alla storia politica italiana: l’assenza di una vera dialettica (sociale e parlamentare) tra liberali e conservatori, dunque l’efficacia permanente del dispositivo trasformista nella formazione della classe politica italiana, spiegherebbero la grande facilità con cui le ideologie radicaloidi e sovversive si affermarono da (D’Annunzio a Mussolini) tra le classi dirigenti nazionali.
A questo tentativo di analisi autocritica “Il Corriere della sera” contrappone la vecchia ferramenta dell’autodifesa ideologica, lanciando una nuova operazione revisionista, il cui unico intento è (nuovamente) mettere sullo stesso piano il nazifascismo con i tentativi rivoluzionari del Novecento, equiparando Mussolini e Hitler a Lenin e Fidel Castro. Quando questi liberali con la memoria corta faranno finalmente i conti con le loro storiche responsabilità rispetto al fascismo sarà sempre troppo tardi. Basterebbe ricordare, ad esempio, che Mussolini entrò in parlamento con il suo manipolo di trogloditi grazie alla gentile ospitalità delle liste di Giovanni Giolitti e non con il lasciapassare di Lenin. Peccato, perché, se recuperasse la memoria smarrita, il giornale milanese potrebbe realizzare un’opera in volumi veramente interessante, spiegando agli italiani come e perché lo storico direttore del “Corriere” (Albertini), il proprio politico di riferimento (Salandra), e il loro filosofo di punta (Croce), salutarono calorosamente l’irruzione della violenza fascista sul movimento operaio e contadino.
Ma il versante della lotta ideologica non riguarda solo il passato, al contrario si estende al presente e al futuro con un intento dichiarato: affermare l’assoluta irripetibilità del pericolo fascista sulla base dei propri studi storico-archivistici.
Pretendere di comprendere le dinamiche della politica di oggi fondando le proprie certezze solo sulla frequentazione di qualche archivio è una delle tante contraddizioni della storiografia oggi di moda. Difficilmente possiamo parlare del presente e del futuro di una persona solo perché ne conosciamo l’albero genealogico o perché abbiamo avuto accesso a qualche registro capace di documentare il passaggio su questa terra dei suoi avi. L’autopsia di un organismo senza vita ci può dire qualcosa del soggetto che stiamo analizzando, non di quelli che verranno dopo di lui. La politica è materia viva, dialettica, piena di reazioni e controreazioni e ogni forma di determinismo (economico o archivistico) non è in grado di coglierne le dinamiche. La pura descrittività sociologica e il determinismo (in tutte le sue forme) non sono capaci di comprendere il passaggio dal mutamento quantitativo a quello qualitativo, ossia, non sono in grado di prevedere e concettualizzare i salti qualitativi della storia, le grandi rotture che irrompono sconvolgendo la linearità e prevedibilità degli avvenimenti umani. Rileggere le lezioni sulla filosofia della storia di Hegel forse servirebbe. La storia non è solo una trascrizione notarile di atti e documenti, per quanto questi siano fondamentali alla sua comprensione. In tal senso, affermare solennemente che oggi non esiste un problema “fascismo” solo perché ai giorni nostri non è possibile immaginare la presa del potere da parte di un manipolo di reduci con la camicia nera e il fez, che si esprimono con il lessico e la retorica arditiststa di D’Annunzio, significa confondere la grandezza del divenire storico con la cronaca giornalistica. Sicuramente non rivedremo una marcia su Roma con quelle caratteristiche, perché nulla nella storia si ripresenta nelle stesse forme, ciò nonostante, sebbene non sia corretto applicare l’aggettivo fascista a qualsiasi manifestazione di ideologia reazionaria o conservatrice, esiste oggi una innegabile emergenza democratica a livello internazionale riconducibile alla fascistizzazione del senso comune e della cultura politica prevalente.
Il problema di oggi, come dopo la Prima guerra mondiale, è la grave crisi organica del capitalismo mondiale e la contemporanea crisi di egemonia delle vecchie classi dirigenti liberali, ben testimoniata dal panico dei partiti protagonisti dell’unificazione europea, tutti prossimi a un drammatico ridimensionamento elettorale. In un simile contesto, l’elemento comune con il passato è la radicalizzazione sovversiva e reazionaria di strati significativi dei ceti medi, convinti di trovare una soluzione alla crisi mondializzante nel nazionalismo protezionista e grazie a una svolta autoritaria in tutti i principali aspetti della vita sociale. Nel 1919-22 i “nemici interni” delle milizie armate fasciste erano i vecchi dirigenti liberali (incapaci di difendere l’ordine sociale e responsabili della “vittoria mutilata”) insieme al movimento operaio e contadino ritenuto forza di disgregazione antinazionale; oggi i gruppi del sovranismo (con le sue differenti gradazioni) trovano nel nazionalismo antieuropeista, tendenzialmente autoritario antidemocratico, e nella lotta all’immigrazione la base di una nuova identità ideologica combattiva e anticonformista, attraverso la quale contendere il campo della lotta egemonica tanto alle correnti liberali dell’europeismo quanto alle divisioni superstiti (sempre più esigue) della sinistra. Il punto non è se questo nuovo campo possa essere definito fascista o meno, problema politicamente ozioso, ma utilizzare con attenzione le categorie analitiche forniteci dalla storia per capire se nei loro processi evolutivi troviamo elementi di fascistizzazione tradizionali o inediti. Un lavoro di analisi che, ad esempio, nel Paese dove vivo e lavoro da oramai cinque anni (il Brasile) si sta iniziando a fare rispetto al fenomeno “Bolsonaro”. Perlomeno a sinistra, questo sforzo analitico sarebbe da intraprendere, credo, pure in Italia.

Domenico Losurdo, um grande intérprete do pensamento crítico contemporâneo
O falecimento de Domenico Losurdo suscitou grande emoção no mundo filosófico e político em muitos países onde ele era não só apreciado e estudado, mas recebido como um dos filósofos mais orgânicos, sistemáticos e coerentes do século XX e início deste novo século. Para mim, que tive a sorte de me formar com ele, foi não apenas um mestre, mas o ponto de referência intelectual através do qual pude estudar e compreender os grandes intérpretes do passado. No Brasil Losurdo encontrou também um público de apaixonados. Os seus livros foram e continuam sendo traduzidos e publicados com grande sucesso de vendas e sendo objeto de estudo nas principais universidades brasileiras. As conferências e palestras que ele proferiu por toda parte neste grande país (as últimas no final do ano passado) sempre estiveram lotadas, sendo acompanhadas por jovens, estudiosos e leitores que, mesmo partidários de diferentes vertentes ideológicas, animavam debates e discussões que se estendiam para além do evento. Aquele que, no futuro, desejar escrever a primeira biografia intelectual deste pensador, irá assumir não apenas uma grande responsabilidade, mas uma carga de trabalho que não poderá ser cumprida apressadamente e com superficialidade, tamanha a profundidade e amplitude da sua produção teórica: dos clássicos da filosofia ao debate em torno da figura de Stalin; da análise do papel da China ao revisionismo histórico; do pensamento liberal às questões do bonapartismo e da democracia moderna; da história do pensamento ocidental aos problemas do colonialismo e do imperialismo. Os estudos de Losurdo sobre o materialismo histórico, assim como aqueles sobre Kant, Hegel, Heidegger e Nietzsche, são um marco fundamental na história das ideias e dos acontecimentos das sociedades humanas, tamanhas a sua seriedade científica e autonomia intelectual, sua riqueza problemática e complexidade interpretativa. Em tempos tão sombrios, dominados pelo refluxo democrático ao nível internacional, a sua batalha filosófica jamais se esqueceu de entrelaçar-se às exigências da política. Não obstante, a clareza das suas posições nunca se traduziu na apologia das convicções ideológicas que evocava, nem no abrandamento do rigor intelectual que lhe era característico. Pelo contrário, Losurdo sempre indagou com severidade crítica e sem indulgência os limites do universo filosófico-político em que decidira militar e ao qual dedicou todas as energias de sua vida. Sua última obra, “O marxismo ocidental”, publicado em 2017 na Itália e agora também no Brasil pela Boitempo, representa uma síntese exemplar de tudo isso. Poderíamos classificá-la como uma espécie de testamento político intelectual. Losurdo não amava a retórica, estando sempre disponível para confrontar-se no plano intelectual com todos, e por isso este grande intérprete do pensamento crítico, além das longas horas dedicadas aos estudos, gastava uma boa parte do seu tempo com uma mala nas mãos, viajando incansavelmente pela Europa, América Latina e Ásia, de modo a estimular uma dialética não ritual e nem apologética em torno dos seus trabalhos. A melhor maneira de homenagear este grande filósofo, que tanto amou o Brasil, seria debater com profundidade esta sua última obra e, através dela, encaminhar um sistemático trabalho de investigação científica sobre a sua amplíssima produção intelectual, tão imprescindível no panorama mundial do pensamento crítico contemporâneo.
Gianni Fresu
(Doutor em Filosofia pela Università di Urbino, professor de Filosofia política Universidade Federal de Uberlândia)

Resistenza e Costituzione repubblicana
Intervento al Convegno
“70° della Costituzione”. Dalla Resistenza alla costituente, fra passato e futuro.
Cagliari 15 gennaio 2017.
Secondo Calamandrei, per comprendere lo spirito della Costituzione era necessario risalire al processo che la generò, la sua origine andava ricercata tra i monti, là dove si combatté la lotta di liberazione nazionale dal nazi-fascismo. Un concetto che ritroviamo in un altro Padre costituente particolarmente importante per noi come Renzo Laconi. Tra le carte trovate dopo la sua morte (avvenuta il 19 giugno 1967) un posto di particolare rilievo è occupato dagli appunti per un saggio destinato a «Critica marxista» per il ventesimo anniversario della Costituzione repubblicana[1]. In queste note la sua polemica era rivolta alla vulgata esegetica della letteratura giuridica e costituzionale che si andava accumulando con l’approssimarsi di quell’anniversario. Laconi lamentava un deficit di indagine storica sulle origini ideologiche e politiche della Costituzione, dato che l’interesse degli studiosi sembrava concentrarsi totalmente sugli atti dell’Assemblea costituente e sul suo quadro dottrinale. Uno studio meramente tecnico, sia sul versante giuridico sia su quello politico, che attribuiva più importanza alla comparatistica costituzionale che al concreto contesto storico da cui era scaturita la Costituzione. Ma una Costituzione, specie quella italiana, scrive Laconi in queste note, è un documento politico e ideologico, sorge dalla dialettica politica, dal contrasto delle idee tra uomini, forze sociali e politiche.
Non esiste concezione politica (organica e coerente o contraddittoria che sia) senza una impostazione ideologica e anche il paradigma anti-ideologico è una ideologia in sé, eppure oggi non c’è ambito politico, giornalistico o accademico nel quale non si ripeta il mantra della critica alle ideologie. Come se il limite della politica contemporanea sia da ricercare nel suo contenuto ideologico e non, al contrario, nell’assenza di visione complessiva del mondo. Si confonde l’ideologia con la demagogia, ma anche questa, a sua volta, come scriveva Gramsci, può assumere una funzione positiva e progressiva se posta al servizio di un processo teso all’elevamento di più ampi strati sociali rispetto a quelli tradizionali dominanti.
A partire da questa consapevolezza, secondo Laconi, la Costituzione va considerata come un atto vivente, non può essere ridotta a una sommatoria di norme, a uno schema tecnico «elaborato a tavolino». Per questa ragione non sarebbe stato possibile né comprendere né valutare criticamente sia l’impianto generale sia le minute norme della Costituzione senza aver colto il senso dell’impostazione concettuale e ideologica che in questa dialettica ha finito per prevalere, giungendo ad una volontà collettiva ed unitaria. Per Laconi la gran parte dei costituzionalisti italiani non comprendeva l’effettiva originalità ideologica della Costituzione italiana perché la interpretavano come una semplice restaurazione modernizzata, sotto le forme repubblicane, della macchina statale liberale prefascista. Una tale impostazione era per Laconi antistorica e priva di consistenza scientifica, oltre a essere del tutto arbitraria. Per interpretare il significato della Costituzione si sarebbe dovuto partire dal coacervo di avvenimenti che caratterizzarono il periodo tra il 43 e il 46, con il superamento della classe dirigente prefascista e l’avvento dei tre partiti di massa, l’opposizione storica nel vecchio Stato liberale che nell’Assemblea costituente ottennero 392 voti su 476. Tra questi tre partiti non c’era piena affinità ideologica, ma essi partivano da una base comune: non solo la condanna del fascismo, e la critica pesante per le responsabilità dei gruppi dirigenti liberali, ma anche l’esigenza di creare uno Stato interventista di tipo solidaristico. Questa base comune trovava nella Costituzione un impianto programmatico vincolante che andava oltre la concezione liberale dello Stato, dunque non era né una rivoluzione né una restaurazione.
Ma se la Costituzione ha le sue radici nella lotta di liberazione nazionale, l’origine di quest’ultima andrebbe ricercata nel decennio più drammatico eppure di svolta per l’antifascismo, segnato dal massimo trionfo interno e internazionale del regime di Mussolini. Il quadro in cui si determina la cosiddetta svolta degli anni Trenta ci parla di un movimento antifascista, fin lì perdente e lacerato da profonde divisioni, per la prima volta finalmente capace di guardare in faccia ai propri errori e superarli sottoponendo a severa autocritica l’astrattezza settaria del suo operare e, più in generale, una concezione meramente moralistica e cospirativa di opposizione alla dittatura. Come ho spiegato in una mia monografia a lui dedicata[2], Curiel e la sua generazione si sono rivelati decisivi nel favorire e accompagnare questo processo, consentendo all’antifascismo di recuperare legami con una realtà nazionale (in particolare i giovani e il mondo del lavoro) del tutto indifferente agli sforzi compiuti in clandestinità o in esilio.
Contrariamente a quanto ritenuto da gran parte dell’antifascismo, il regime di Mussolini esercitava un consenso reale nel Paese, non era solo esercizio monopolistico e violento della forza statale. Il fascismo era una forma nuova e moderna di regime autoritario, si serviva abilmente dei grandi mezzi di comunicazione di massa, puntava a irreggimentare e mobilitare (seppur in funzione passiva e coreografica) le grandi masse popolari nel regime, certo basava il suo potere anzitutto sul dominio diretto, ciò nonostante, riusciva, grazie a complessi e stratificati strumenti di costruzione del consenso presso la società civile, anche a esercitare un’egemonia reale piuttosto estesa nella metà degli anni Trenta. La comprensione di ciò, era la premessa essenziale per un differente approccio all’attività antifascista e per abbandonare ogni atteggiamento settario, moralistico e meramente cospirativo. Dividere l’Italia in due blocchi monolitici e contrapposti (da una parte le anime perse e irrecuperabili dei sostenitori del regime, dall’altra i puri del movimento antifascista), non aveva senso. Grazie alla forza di un’efficace azione repressiva e alla macchina della propaganda, il regime aveva il sostegno dalla maggioranza degli italiani, dunque anziché ritrarsi in una sfera di presunta purezza e limitarsi a un’attività cospirativa incentrata sulla mistica del gesto, bisognava mischiarsi con quel popolo, quotidianamente, entrare nelle organizzazioni di massa del regime, coglierne le intime contraddizioni e svuotarne dall’interno le sue basi di consenso. Lavorare nel sindacato fascista e utilizzare le singole lotte economiche dei lavoratori, era la strada scelta per perseguire questo obiettivo. Ciò valeva particolarmente per i giovani ingannati dal regime, presso i quali l’antifascismo doveva compiere un faticoso lavoro di conquista egemonica.
Al di là del contenuto propagandistico, l’offensiva ideologica del fascismo, agli inizi degli anni Trenta, si rivelò efficace nell’attivare politicamente le nuove generazioni. Giovani intellettuali, variamente collocati in ambito sindacale o impegnati culturalmente, in gran parte studenti, trovarono nelle parole d’ordine antiborghesi e nella promessa di una rivoluzione le ragioni del proprio impegno. Aver seminato tante promesse, dando libero sfogo a una retorica profondamente distante da quel che realmente il regime era nella realtà, operazione spregiudicata poi ritortasi contro il fascismo, ebbe però inizialmente l’effetto di rinnovarlo profondamente consentendogli di allargare la base del suo consenso e di superare il momento di crisi, nonostante le grandi contraddizioni e il crescente malessere del mondo del lavoro[3]. Questa paziente attività carsica di penetrazione ed erosione trovò modo di manifestarsi clamorosamente nel corso della guerra, quando una parte significativa di quella gioventù cresciuta a pane e fascismo divenne la spina dorsale della Resistenza.
Gli scioperi scoppiati nelle città industriali del Nord, partiti dall’officina 19 della Fiat Mirafiori di Torino il 5 marzo 1943, che in pochi giorni coinvolsero centomila lavoratori, sono una tappa decisiva nella crisi del fascismo, perché segnano la discesa in campo della classe operaia, e non più, come era accaduto nel corso del “ventennio”, con scioperi parziali, fermate di lavoro o agitazioni circoscritte, in questo caso si trattò di una fermata complessiva dal chiaro significato politico verso il regime. Secondo Secchia, che in proposito richiama anche una stizzita dichiarazione di Mussolini[4], gli avvenimenti di marzo non potevano essere separati dalla definitiva vittoria riportata a Stalingrado il 2 di febbraio, perché questo avvenimento ebbe l’effetto di infondere coraggio sui lavoratori. A questo si aggiunsero i pesanti bombardamenti sulle città italiane, uno schiaffo alle millanterie del fascismo, di cui però fu il popolo a pagare le peggiori conseguenze. La guerra in casa, con le città sfregiate dalle distruzioni, straziate dai corpi senza vita o gravemente feriti di tanti cittadini innocenti, aprì definitivamente gli occhi agli italiani sulle illusioni di vittoria e le bugie di Mussolini rispetto alle sorti della guerra. L’inizio degli scioperi nel marzo ’43 segnarono l’inizio della Resistenza.
Nonostante i tanti dirigenti in carcere o al confino, la rete organizzativa clandestina era riuscita a estendersi dando vita nelle fabbriche ai comitati unitari d’azione antifascista. Nelle settimane che precedettero gli scioperi i gruppi di operai comunisti si riunivano a gruppi di tre, al massimo cinque unità, una copia clandestina de «l’Unità» passava di mano in mano e arrivava a essere letta da almeno cinquanta persone, così come il materiale propagandistico, diffuso secondo severe norme di sicurezza da un’organizzazione per compartimenti stagni. A Milano, già dal 1942, c’era una tipografia del partito a Porta Ticinese, dopo i bombardamenti, venne spostata in una Cascina a Vaprio D’adda. Nonostante i controlli, «l’Unità» usciva con quattro pagine e una tiratura di 4.000 copie raggiungendo tutti gli stabilimenti industriali della città. Nella fase di massima crisi del regime il Partito comunista disponeva, al Centro-Nord, di una struttura operativa, verso cui si orientò il malcontento del mondo del lavoro, essenziale a dare la spallata finale al potere di Mussolini. La Resistenza armata vera è propria iniziò il giorno dopo l’8 settembre, con il tentativo disordinato mal riuscito di difendere Roma. Tuttavia, la narrazione di una Resistenza esplosa immediatamente e in maniera spontanea, con la partecipazione di tutto il popolo, è solo mitologia, in realtà le difficoltà furono enormi. In ogni luogo, là dove si verificarono episodi di opposizione e lotta armata esisteva un’organizzazione antifascista, «non tutti gli italiani si schierarono dalla parte della Resistenza, ma soltanto una minoranza attiva»[5]. Bisogna tenere conto di quanti decisero di schierarsi con i nazifascisti e soprattutto dei tanti che, magari solo per timore e prudenza, si astennero dal farlo senza per questo aderire alla Resistenza. Anche in una parte dell’antifascismo, per un certo periodo, prevalse l’inattività, un atteggiamento «attesista», per eccesso di prudenza si preferì aspettare l’arrivo degli eserciti alleati, evitando «inutili perdite». A fronte di tutto questo, tuttavia, tanti cittadini mostrarono solidarietà verso la Resistenza, cui fornirono aiuti materiali, ospitalità e assistenza, chiarito questo fatto, inizialmente non ci fu certo una corsa in massa per arruolarsi tra le divisioni partigiane. Come ha scritto Secchia, «La Resistenza non fu né un miracolo, né un fenomeno spontaneo: dovette essere organizzata. Dura, difficile, piena di difficoltà fu sempre la lotta, sino alla fine, ma soprattutto all’inizio»[6].
Dopo l’8 settembre, non c’erano solo i problemi della guerra contro l’occupazione, e le mai del tutto superate divisioni interne al fronte antifascista, a rendere più complicato il tutto, c’era l’esigenza di garantire l’unità e l’efficacia delle potenze impegnate nella guerra al nazifascismo. Come ha scritto un altro protagonista come Luigi Longo, gli anglo-americani avevano l’obiettivo di «precostituirsi posizioni di vantaggio nell’Italia liberata» che mal si conciliavano con l’idea della mobilitazione popolare e di massa della lotta partigiana[7] Oltre a ciò, l’aspirazione di una parte dell’antifascismo italiano era tornare all’equilibrio pre-fascista, nella convinzione che il “ventennio” dovesse essere superato e archiviato come una “brutta parentesi” nella storia d’Italia, è questa l’idea del fascismo inteso come “malattia morale dell’Europa”. Tutto questo non poteva non avere riflessi sulle coordinate della guerra di liberazione e sul modo di concepire sia il presente – dunque il tema della partecipazione popolare alle operazioni militari – sia, soprattutto, il futuro: bisognava ricostruire da zero le fondamenta del nuovo Stato democratico oppure salvare e ristrutturare quelle derivanti dal vecchio Statuto Albertino? La linea dell’antifascismo che scelse la prima opzione aveva un duplice connotato: 1) evitare nuovamente la passivizzazione coatta delle grandi masse popolari (attendere gli eserciti alleati e delegare a loro la liberazione), in un momento storico nel quale invece dovevano essere protagoniste; 2) saldare strettamente la lotta popolare di liberazione alla costruzione del futuro quadro democratico costituzionale. Nello specifico, il quadro concettuale e programmatico dei comunisti italiani si articolava a partire dall’idea della “democrazia progressiva”, che concepiva la lotta di liberazione come premessa essenziale per l’avanzamento sociale e politico delle masse popolari nel post-liberazione. Intensificare la partecipazione popolare attraverso gli organismi della resistenza significava dare da subito fondamenta solide a una tale prospettiva. La democrazia progressiva non andava intesa come una «tappa» di avvicinamento alla “terra promessa”, il socialismo, bensì, un «processo» di costruzione molecolare con il quale bisognava misurarsi quotidianamente attraverso ogni singola lotta. Questa processualità necessariamente si sarebbe dovuta manifestare nel contributo delle masse popolari alla ricostruzione materiale e morale del Paese.
L’opera di ricostruzione non poteva fondarsi sui parametri consueti del liberismo e dell’esclusiva proprietà privata dei mezzi di produzione, bisognava connotare in termini sociali la nuova democrazia, che non avrebbe potuto fare a meno della partecipazione statale e delle forme cooperative di intervento economico. Nell’immediato della guerra partigiana l’indicazione strategica era chiara: occorreva legare le azioni di guerriglia, di sabotaggio, propaganda e iniziativa sociale per superare non solo la dittatura fascista, ma anche la semplice riproposizione della vecchia Italia liberale giolittiana. Per questo era necessario rimuovere le condizioni sociali su cui si era strutturato e affermato il fascismo, quindi costruire un quadro politico che non risolvesse la partecipazione popolare al solo momento delle elezioni e nel mero rapporto passivo di delega alla rappresentanza parlamentare. L’insieme delle lotte quotidiane, nelle quali si articolava l’azione delle organizzazioni di massa protagoniste della Resistenza, erano «la realizzazione consentita dalla situazione attuale di quella democrazia progressiva, per la quale si lotta»[8].
Con la guerra di liberazione in corso erano già percepibili le profonde differenziazioni tra le forze antifasciste sulle prospettive del Paese, fondamentalmente divise tra due fronti contrapposti: uno, di ispirazione liberale guidato da Croce, favorevole ad una restaurazione dei vecchi assetti istituzionali prefascisti; un altro interessato a costruire attraverso l’Assemblea costituente un diverso equilibrio democratico.
In tal senso, la lotta all’attesismo, che vide in prima fila comunisti, socialisti, azionisti e anche cattolici, dunque lo sforzo teso a favorire la partecipazione del popolo alla lotta di liberazione nazionale, non va archiviata come una semplice manifestazione di dialettica politica. Il ruolo delle divisioni partigiane nella liberazione del Centro Nord ha avuto delle conseguenze sullo status post-bellico dell’Italia, contribuendo non poco a un fatto troppo spesso sottovalutato: delle tre nazioni un tempo facenti parte del «Patto tripartito», solo l’Italia vanta una Costituzione frutto di un processo di partecipazione popolare così ampio e socialmente avanzato, non emanazione degli eserciti occupanti. Tutto questo trovò poi traduzione nella Costituzione nata da questo processo popolare, perché la sua ispirazione fondamentale, sia nei primi 3 articoli, sia in quelli di previsione economico-istituzionale, non si limita a disegnare l’impianto di uno Stato che detta le regole e si limita a farle rispettare, lo “Stato Ottocentesco della toga e della spada”. La Costituzione nasce con un obbiettivo radicalmente nuovo rispetto al vecchio Statuto pre-fascista, attribuire alla Repubblica il compito di “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. Come è stato scritto sovente, essa nasce dalla fusione delle tre principali culture politiche del Paese (cattolica, liberale e marxista) sforzandosi di conciliare i concetti di uguaglianza formale e sostanziale, in un nuovo quadro più avanzato orientato al progressivo ampliamento degli spazi di democrazia politica, economica e sociale con il compito di garantire la partecipazione permanente e il protagonismo dei lavoratori nella vita del Paese. Dunque non solo l’idea di libertà negativa, propria della tradizione liberale, intesa come intangibilità da parte dello Stato della sfera individuale privata, ma anche quella di libertà positiva, di tradizione democratica, intesa come diritto del popolo a essere parte attiva e protagonista, non passiva e subalterna, dei processi decisionali, nella quale la rimozione degli ostacoli economico sociali all’esercizio dell’effettiva uguaglianza (sul piano sostanziale e non semplicemente formale) assume un ruolo inedito nella storia dell’Italia. La Costituzione ha messo in discussione idea di un rapporto inversamente proporzionale tra sfera delle libertà e estensione delle attività dello Stato, uno dei più duraturi miti del liberalismo. Ha messo in soffitta la tradizionale condanna all’ambizione di regolare politicamente la vita sociale, intervenire in economia e dare un indirizzo alla vita di una comunità nazionale. Questo è il dato filosofico-politico di fondo, tuttavia, guardando in modo spassionato all’attualità, dobbiamo fare i conti con una realtà ben differente. In un periodo storico nel quale viene riaffermata la pretesa capacità “naturale” di autoregolamentazione delle leggi di mercato, teoricamente incompatibile con “l’artificiale” irruzione ordinatrice della politica, proprio su questo versante programmatico, il quadro di oggi appare drammaticamente più arretrato e ottocentesco rispetto ad allora. In questa contraddizione, squisitamente politica, risiede la ragione della parziale e limitata applicazione della Costituzione, dunque la mancata attuazione di molti dei suoi principi fondamentali, problemi non risolvibili attraverso le cicliche e fallimentari operazioni di ingegneria istituzionale degli ultimi decenni.
[1] R. Laconi, Parlamento e Costituzione, (a cura di) E. Berlinguer, G. Chiaromonte, Editori Riuniti, Roma, 1969.
[2] G. Fresu, Eugenio Curiel. Il lungo viaggio contro il fascismo, Odradek, Roma, 2013.
[3] G. Accame, Il fascismo immenso e rosso, Settimo Sigillo, Roma, 1990.
[4] P. Secchia, Lotta antifascista e giovani generazioni, La Pietra, Milano, 1973, pag. 6.
[5] P. Secchia, Il Partito comunista italiano e la guerra di liberazione nazionale (1943-1945),Op. cit., pag. 110.
[6] Ivi, pag. 111.
[7] L. Longo, I centri dirigenti del PCI nella Resistenza, Editori riuniti, Roma, 1977, pag. 24.
[8] Il Fronte della Gioventù verso la democrazia progressiva, «Bollettino del Fronte della Gioventù», n. 8, agosto 1944, pag. 1, in “Fondo Curiel”, sez. VI, cart. 1, Archivio Istituto “Gramsci”, Roma.

Le ipocrisie dell’ideologia liberale e il cosiddetto odio di classe
Nel parlamento brasiliano (ma la stessa discussione si sta insinuando anche in Europa) è stata presentata in questi giorni una proposta di legge finalizzata a punire penalmente l’apologia di comunismo, con la seguente argomentazione: “il comunismo avrebbe fatto un centinaio di milioni di morti”. Tralasciamo le considerazioni sulla natura grossolana di questa operazione, perché i simboli che si vorrebbero proibire (la falce e martello e i richiami alla tradizione teorica del socialismo) rappresentano un panorama incredibilmente variegato, non riducibile a una unica esperienza, all’interno del quale si situa con tutte le sue articolazioni la storia della lotta per l’emancipazione del mondo del lavoro. Nelle argomentazioni utilizzate si dice, “è necessario impedire l’istigazione all’odio e alla guerra di classe!” Farebbe sorridere, se non fosse tragica, un’affermazione simile, perché l’odio di classe è non solo istigato sul piano teorico ma concretamente praticato nelle nostre società occidentali, dall’alto verso il basso però. Come definire diversamente almeno quattro decenni di assedio ai diritti sociali e a quelli del mondo del lavoro tesi a favorire l’accumulazione dei capitali e la speculazione finanziaria? Come chiamare il vertiginoso aumento negli ultimi quaranta anni della forbice tra chi ha tanto (sempre sfacciatamente di più e in forme indecorosamente concentrate) e chi non ha nulla? Come classificare la sistematica spoliazione delle ricchezze dei cosiddetti Paesi “sottosviluppati” da parte di quelli ricchi, cui si aggiunge la beffa della limitazione della libera circolazione dei loro cittadini? Noi abbiamo avuto per secoli (e conserviamo ancora) il diritto di invaderli, sfruttarli e rapinarli, però non ai poveri del Sud del mondo non è concesso spostarsi dal deserto che abbiamo creato intorno a loro. Cosa sarebbe tutto questo se non odio e guerra di classe?
Si parla spesso in termini puramente retorici di libertà fondamentali, ma la prima di queste consiste nel diritto a non morire di fame, ignoranza e per assenza di cure sanitarie, dunque, se guardiamo alla realtà con una prospettiva meno edulcorata, possiamo tranquillamente affermare che queste sono negate alla stragrande maggioranza della popolazione mondiale.
Oramai è diventato un luogo comune citare la discutibile contabilità dei lutti fatta (all’ingrosso) nel famigerato “Libro nero del comunismo”, nel quale vengono compresi anche i morti per guerre e carestie in gran parte dei casi indotte dall’esterno. Sarebbe ora, credo, di scrivere pure un “Libro nero del liberalismo”, Domenico Losurdo ha fatto nei decenni questo lavoro attraverso una puntuale critica storica e filosofica, manca però un banale libro in cifre, di semplice ragioneria politica del capitalismo. Se, infatti, usassimo gli stessi parametri adottati da Stéphane Courtois &Co., quante centinaia di milioni di morti dovremmo imputare all’espansione mondiale delle nostre relazioni sociali borghesi? Proviamo solo a pensare: le conseguenze storiche dell’accumulazione originale del capitale sulle sterminate masse rurali cacciate dalle campagne trasfromate in moltitudini mendicanti nelle grandi periferie urbane; lo sterminio dei popoli nativi nel Nord e Sud America, Asia e Oceania; i morti dovuti alla miseria e allo sfruttamento coloniale occidentale in Africa, schiavismo compreso; le infinite guerre imperialiste condotte negli ultimi due secoli in ogni angolo del pianeta per rapinare le risorse dei “popoli incivili”. Un’ecatombe, ben occultata nei libri o nelle trattazioni divulgative sulla storia dell’umanità. Anche questo conferma un punto già colto da Marx e Engels nella metà dell’800: è proprio nel terreno delle ideologie il vero successo della società borghese, così l’aver trasformato il mondo in un grande cimitero è presentato come affermazione dei principi di libertà e civiltà sulla barbarie. Il paradosso storico è che, pur essendo maestri di ideologia, i grandi e piccoli teorici del liberalismo fanno della critica alle ideologie la propria battaglia più caratterizzante. La conferma della loro capacità egemonica è che la maggioranza delle persone, dotata anche di una buona cultura, ci crede e la riproduce più o meno consapevolmente.
“Nell’economia politica la cosiddetta accumulazione originaria del capitale svolge la stessa funzione del peccato originale nella teologia: Adamo dette un morso alla mela e con ciò il peccato colpì il genere umano. Se ne spiega l’origine raccontandola come aneddoto del passato. C’era una volta, in una età da lungo tempo trascorsa, da una parte una élite dirigente, intelligente e soprattutto risparmiatrice, e dall’altra c’erano gli sciagurati oziosi che sperperavano tutto il proprio e anche di più. Però la leggenda del peccato originale teologico ci racconta come l’uomo sia stato condannato a mangiare il pane nel sudore della fronte; invece la storia del peccato originale economico ci rivela come mai vi sia della gente che non ha affatto bisogno di faticare. Fa lo stesso! Così è avvenuto che i primi hanno accumulato ricchezza e che gli altri non hanno avuto all’ultimo altro da vendere che la propria pelle. E da questo peccato originale data la povertà della gran massa che, ancor sempre, non ha altro da vendere fuorché se stessa, nonostante tutto il suo lavoro, e la ricchezza dei pochi che cresce continuamente, benché da gran tempo essi abbiano cessato di lavorare[1]”
[1] K. Marx, Il capitale. Critica dell’economia politica. Editori riuniti, Roma, 1997, pag. 777.

Un secolo di rivoluzioni. Percorsi gramsciani nel mondo. (Convegno di studi internazionale)
Università di Cagliari – Regione Autonoma della Sardegna – Comune di Cagliari
GramsciLab – Associazioni gramsciane sarde
Convegno internazionale per l’Anno Gramsciano
Cagliari 27-28 aprile 2017
Un secolo di rivoluzioni. Percorsi gramsciani nel mondo
A Century of Revolutions. Gramscian Paths across the World
Teatro Piccolo Auditorium
Piazzetta Dettori, Cagliari
Giovedì 27 aprile
ore15,00 – 19,30
Saluti
Maria Del Zompo, Rettore Università di Cagliari
Cecilia Novelli, Direttore del Dipartimento di Scienze Sociali e delle Istituzioni
Ignazio Putzu, Direttore del Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica
Massimo Zedda, Sindaco Comune di Cagliari
Paolo Frau, Assessore alla Cultura, Comune di Cagliari
Giuseppe Dessena, Assessore alla Cultura, Regione Sardegna
Rappresentanti Associazioni gramsciane
Intervento introduttivo
Patrizia Manduchi, DISSI e GramsciLab
1^ Sessione
ore 16,30 -19,00
Dall’agire rivoluzionario al populismo. Conflitti e rivoluzioni nel “secolo breve”
From Revolution to Populism: Conflicts and Revolutions in the “Short Twentieth Century”
discussant Mauro Pala
- Angelo D’Orsi, Università di Torino
Da Lenin al Sessantotto: le rivoluzioni del secolo breve
- Lea Durante, Università di Bari
Aleksandra Kollontaj e Clara Zetkin: per una genealogia femminista della Rivoluzione
- Michele Cometa, Università di Palermo
Gramsci e Benjamin: un’affinità postuma?
- Roberto Dainotto, Duke University, Usa
Vedi alla voce “Populismo”: l’attualità della lezione di Antonio Gramsci
Dibattito
ore 19,00 – 19,30
Venerdì 28 aprile
ore 9,00 – 19,30
Intervento introduttivo
Álvaro Marcelo García Linera, Vice Presidente della Bolivia
2^sessione
ore 9,30-11,00
Conflitti e rivoluzioni nel XXI secolo: prospettive epistemologiche gramsciane
Conflicts and Revolutions in the XXI century: Gramscian Epistemological Perspectives
discussant Sabrina Perra
- Guido Liguori, Università di Roma
Il concetto di rivoluzione in Gramsci, dall’Ottobre ai Quaderni del carcere
- Miguel Mellino, Università l’Orientale Napoli
Secolare, subalterno, postcoloniale. Decolonizzare il marxismo occidentale a partire da Gramsci
- Gilbert Achcar, SOAS, University of London
Morbid Symptoms: A Gramscian Perspective on Global Developments
Coffee break ore 11,00 – 11,30
3^ sessione
ore 11,30-13,30
Movimenti contro egemonici e rivoluzioni passive in Asia e America Latina
Passive Revolutions and Counter-hegemonic Movements in Asia and Latin America
discussant Francesca Congiu
- Gianni Fresu, Universidade Federal de Uberlandia, Brasile
Coutinho, traduttore e interprete di Gramsci. L’elaborazione di una teoria gramsciana sul Brasile
- Ana Maria Said, Universidade Federal de Uberlandia, Brasile
Rivoluzione e democrazia: l’eurocomunismo in Brasile nel crepuscolo della dittatura
- Kevin Gray, University of Sussex, GB
Beyond States and Markets: Late Development and Passive Revolution in East Asia
Dibattito
ore 13,30 – 14,00
4^ sessione
ore 15,30 – 17,30
Percorsi rivoluzionari in Medio Oriente
Revolutionary Paths in the Middle East
discussant Alessandra Marchi
- Massimo Campanini, Università di Trento
Gramsci e la ricerca dell’egemonia nel pensiero politico islamista contemporaneo
- Asef Bayat, University of Illinois, USA
Revolutions of the Neoliberal Times. From the Iranian revolution to the Arab Spring
- Gennaro Gervasio, Università Roma 3
La Rivoluzione Egiziana: una prospettiva subalterna
- Daniela Melfa, Università di Catania
Utopie rivoluzionarie e comunisti in Tunisia. Itinerari di un’élite
Dibattito e saluti finali
Comitato Scientifico :
Francesca Congiu (Università degli Studi Cagliari)
Gianni Fresu (Universidade Federal de Uberlandia, Brasile)
Patrizia Manduchi (Università degli Studi di Cagliari)
Alessandra Marchi (Università degli Studi di Cagliari)
Mauro Pala (Università degli Studi di Cagliari)
Sabrina Perra (Università degli Studi di Cagliari)
