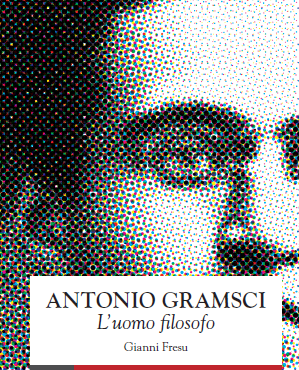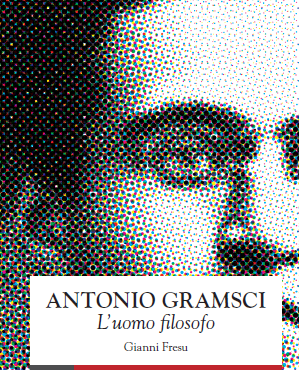Il centesimo anniversario del PCI a finito per essere l’ennesima occasione di approfondimento persa, vanificata dalla volontà di regolare i conti del passato che soverchia la necessità di capire. “Il Corriere della Sera”, “La Stampa”, “La Repubblica”, tutte le grandi testate nazionali si uniscono in una nuova Santa Alleanza, cementata dallo stridore di maledizioni che dovrebbero incenerire tutto quel che quella storia ha rappresentato. È, ad esempio, il caso del pezzo di Filippo Ceccarelli che apre lo speciale dedicato ai 100 anni del PCI da “Robinson”, a suo modo, paradigmatico e ben rappresentativo dell’approccio oggi prevalente.
Nemmeno il più piccolo sforzo per tentare di comprendere l’originalità e la funzione progressiva di questa organizzazione, in un contesto storico denso di contraddizioni interne e internazionali. Va bene prestare attenzione alle contraddizioni, che in quella storia non furono certo poche, ma come si può non avere alcuna curiosità verso la sua ricchezza culturale? Come omettere il suo contributo pedagogico alla socializzazione politica di massa in Italia, ossia al fatto che questo partito è stato comunque strumento di alfabetizzazione e formazione politica, veicolo di partecipazione collettiva per milioni e milioni di “cafoni” (operai, contadini, muratori, lavoratori in genere) fino ad allora esclusi dalla politica e divenuti improvvisamente soggetto attivo e cosciente della vita nazionale. Tutto questo in un Paese storicamente dominato da equilibri sociali regressivi tra le classi, dalle rivoluzioni passive e dal ricorso sistematico al trasformismo che, dal Risorgimento al fascismo, hanno sempre avuto la funzione operativa di escludere e rendere ancora più subalterne le masse popolari. Un pezzo di “riforma intellettuale e morale”, sicuramente incompleto di cui, pur tra mille limiti, quel gruppo dirigente aveva consapevolezza, così sintetizzato da Palmiro Togliatti gennaio del 1958:
“L’adesione di milioni e milioni di donne e di uomini a un partito che combatte per creare una nuova società, è un fatto nuovo nella vita della nazione. L’Umanità e la nazione diventano consapevoli del loro compito, che è di dominare il mondo dei rapporti sociali e dare inizio al regno della libertà. Noi siamo fieri di essere l’avanguardia consapevole di questo grande movimento”, (P. Togliatti, Il partito comunista italiano, Editori Riuniti, Roma, 1961, p. 136-137).
Nel pezzo di Ceccarelli troviamo solo una lunga sequenza di accuse, luoghi comuni, giudizi taglienti e sconcezze osservate dal buco della serratura del più grande partito comunista dell’Occidente. Ma se veramente questa storia non rappresenta nulla e non ha lasciato tracce, solo fallimenti, perché ogni giorno tutti questi intellettuali in servizio permanente nella difesa dello stato di cose presenti sente il bisogno di mobilitarsi per delegittimarne la memoria e cancellare preventivamente la possibilità di trarne insegnamento per il futuro? Questa volontà censoria, infarcita di scomuniche e maledizioni fino alla settima generazione, ci dice semmai l’esatto contrario di quanto raccontato; in realtà, quelle vicende fanno ancora paura a tanti, sebbene nella politica attuale nessuno abbia ancora avuto la forza, la voglia e l’intelligenza di raccoglierne l’eredità.
Per rivendicare un diverso modo di rapportarsi a questo insieme di problemi, di seguito, un mio articolo pubblicato nella rubrica “Diogene” nel numero de “La Nuova Sardegna” del 17 gennaio 2021.
Quella scissione che cambiò la sinistra
Il 21 gennaio di cento anni fa al XVII Congresso del PSI a Livorno la nascita del Partito comunista italiano
Il 21 gennaio ricorre il centenario della fondazione del PCI, si possono avere diverse opinioni in merito alla sua linea politica, condividerne o meno premesse e prospettive ideologiche, resta innegabile l’importanza di quest’organizzazione di massa nella storia d’Italia del XX secolo. Tale riconoscimento non significa omettere le contraddizioni e i limiti della sua traiettoria politica, ma valutarle unitamente ai contenuti progressivi della sua funzione storica. La peculiarità del PCI nel panorama del comunismo internazionale, tuttavia, non riguarda solo il suo peso nelle vicende sociali, politiche e culturali di un Paese la cui collocazione nel blocco occidentale era considerata inderogabile, come le trame eversive e la strategia della tensione nel corso del dopoguerra hanno drammaticamente dimostrato. La vera originalità del comunismo italiano riguarda lo sforzo compiuto dai suoi gruppi dirigenti teso a tradurre i principi del marxismo e il contenuto universale della Rivoluzione russa nelle peculiarità della nostra realtà nazionale. Non si trattava di ripetere formule ideologiche generali, né pretendere di riproporre pedissequamente in Italia modelli affermatisi altrove. Come Gramsci scrisse nel Quaderno 7, «il compito era essenzialmente nazionale, cioè domandava una ricognizione del terreno e una fissazione degli elementi di trincea e di fortezza», ossia, inserirsi nelle articolazioni egemoniche della sua società civile, comprendendone l’essenza e originalità.
Zonde d’ombra
Nella storia del Novecento, le vicende del Partito comunista italiano hanno dato luogo a ricerche e approfondimenti tanto estesi da trovare un corrispettivo solo nel grande interesse verso il Fascismo, sicuramente l’argomento storico-politico italiano più sottoposto a indagine scientifica. Eppure, in questo colossale lavoro di ricostruzione storica ci sono alcune “zone d’ombra” tra le quali spicca senz’altro la mancata o insufficiente storicizzazione della corrente di Amadeo Bordiga, principale artefice e protagonista della nascita del PCd’I. La tendenza a considerare Gramsci il fondatore del “Partito nuovo” è il risultato di una rappresentazione dei fatti strumentale, funzionale alle sue esigenze interne di lotta politica. Tuttavia, cambiato il quadro storico e svanite le necessità dialettiche che ne avevano determinato l’affermazione, una simile visione dei fatti è sopravvissuta allo stesso PCI, così ancora oggi è diffusa l’idea di un “Gramsci padre fondatore del Partito”.
Oltre Bordiga
Il PCd’I, Sezione italiana della III Internazionale, nasce a Livorno il 21 gennaio del 1921. A sottolineare con più decisione la sua radice nazionale, a seguito dello scioglimento dell’Internazionale comunista, assume poi il nome di Partito comunista italiano il 15 maggio del 1943. Tuttavia, la scelta di una più netta contestualizzazione nazionale dell’organizzazione nasce ben prima del 1943, con la profonda svolta impressa da Gramsci alla sua direzione politica tra il 1925 e il ‘26. Le Tesi del Congresso Lione del ‘26 sono state definite l’asse fondamentale della sterzata operata nella storia dei comunisti in Italia, sia in rapporto alla concezione del partito, sia per l’analisi della società. In entrambi i casi si giunge al superamento completo delle Tesi elaborate da Bordiga per il Congresso di Roma, dopo il profondo mutamento nella direzione politica del Partito sotto la guida di Antonio Gramsci. Come è noto, a partire dalla fine degli anni Trenta e soprattutto nella lotta di liberazione nazionale il Partito comunista diviene un soggetto politico capace di attrarre studenti, operai, artisti, letterati, docenti universitari. Da piccolo partito di quadri, presente, e limitatamente, solo in determinate realtà del Paese, diviene la principale organizzazione politica della Resistenza, fino a risultare inaspettatamente il primo partito della sinistra italiana e il più grande partito comunista del campo occidentale. Sembra quasi impossibile una simile trasformazione, tenuto conto della marginalità e della cultura minoritaria al momento della sua nascita e negli anni di affermazione del Fascismo. Una prima spiegazione andrebbe ricercata forse nella tenacia con cui, anche negli anni più duri della repressione fascista, il PCd’I si sforzò di mantenere in Italia una sua struttura operativa clandestina, anziché limitarsi a trasferire all’estero tutta la sua organizzazione. Tuttavia, sebbene importante, la presenza ostinata dei comunisti nel Paese lungo tutto il ventennio mussoliniano non spiegherebbe da sola un fenomeno di crescita tanto esponenziale. Su esso ha probabilmente influito anche l’evoluzione della sua linea, capace di abbandonare gli approcci settari e minoritari delle origini fino ad aderire con maggiore plasticità alle condizioni nazionali, divenendo un partito di massa per molti versi erede della tradizione organizzativa e sociale del vecchio socialismo.
Transizione
Le Tesi di Lione rappresentano uno spartiacque essenziale, sicuramente il punto più alto nel quale l’elaborazione teorica e la direzione politica di Gramsci trovano un punto d’intesa elevatissimo. Nella biografia di Gramsci queste rappresentano un punto di continuità tra le battaglie precedenti il 1926 e le riflessioni carcerarie, la testimonianza più vivida di quanto sia impossibile separare il Gramsci politico e militante dal Gramsci “disinteressato” o “uomo di cultura”. La svolta di Lione costituisce la premessa essenziale per comprendere il ruolo storico assunto dal PCI tanto nella Resistenza, quanto nella fase successiva alla Liberazione; è l’antefatto più pregnante del profondo mutamento nell’iniziativa dei comunisti tra il VII Congresso del Comintern e la “svolta di Salerno” del 1944. Il risultato più fecondo di questa svolta fu il concepire in termini organici le tematiche della lotta al fascismo e quelli della ricostruzione democratica a partire dalla stagione costituente. Il punto d’intesa tra questi due momenti era l’idea della democrazia progressiva, vale a dire, la prospettiva di un permanente allargamento degli spazi di democrazia economica, sociale e politica, tali da consentire al mondo del lavoro di conquistare posizioni di forza, in un processo di transizione democratica al socialismo.
Questione nazionale
Bisognava rimuovere le radici economico sociali del fascismo, ossia la natura monopolistica di un certo suo capitalismo, il parassitismo oligarchico, causa congenita del sovversivismo reazionario di parte significativa delle sue classi dirigenti. Per raggiungere questo obiettivo, così come per quello propedeutico della liberazione dell’occupazione nazifascista, era essenziale trovare un’intesa unitaria con le altre forze popolari del Paese, non solo i socialisti ma anche e soprattutto le masse cattoliche. Al di là di miti e leggende sulla presunta “doppiezza togliattiana”, nella scelta operata con la svolta di Salerno nel 1944, e in quelle successive, fino all’approvazione della Costituzione repubblicana non c’era alcun “abile espediente tattico”, si trattava di scelte strategiche conseguenti alla ricerca di un’originale via italiana al socialismo, frutto delle specificità storiche, culturali e sociali della concreta realtà nazionale in cui i comunisti intendevano agire.
Pubblicato sul numero in edicola de “La Nuova Sardegna”, (“Diogene”, p. 28) del 17 gennaio 2021
Gianni Fresu