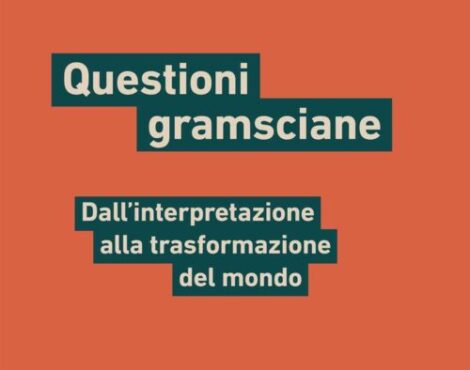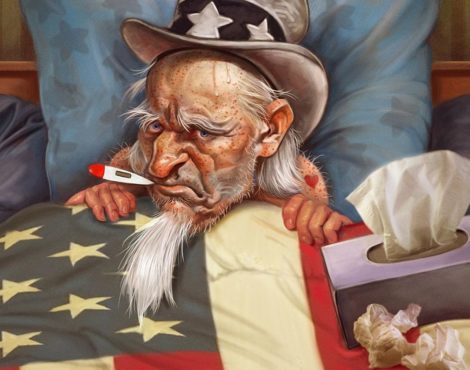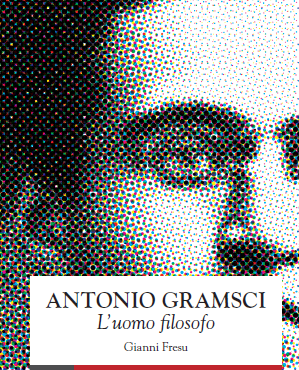(“L’Unione Sarda”, 18/10/24, Prima pagina (Editoriale)
Come è a tutti noto, in Sardegna, attorno ai progetti che intendono creare dei parchi eolici e fotovoltaici, è in corso uno scontro durissimo che contrappone i comitati delle comunità coinvolte alle grandi compagnie energetiche. I movimenti mobilitatisi in difesa del proprio patrimonio produttivo, storico e ambientale denunciano l’approccio neocoloniale sotteso al piano: trasformare l’isola, già sovraccaricata dal 65% delle servitù militari di tutta l’Italia, in grande una piattaforma di produzione energetica quasi totalmente funzionale alle esigenze del continente e alle logiche speculative e di profitto delle multinazionali.

Posto che la transizione energetica è una necessità ineludibile verso la quale tendere, archiviare positivisticamente tale processo di trasformazione a questione “tecnica” è un errore politico imperdonabile. Gli strumenti di produzione (anche energetica) non sono mai neutri, ma sempre funzionali a determinate relazioni sociali, pertanto, pur essendo d’accordo sulla premessa e sulle prospettive, per i comitati resta tutto intero il tema politico del “come” e del “perché” fare una determinata cosa.
Stando al “come”, bisogna vedere se il passaggio a eolico e fotovoltaico avviene democraticamente (ossia coinvolgendo le comunità e rispettando le loro istanze) oppure bonapartisticamente, dall’alto verso il basso, come un ordine militare che (in nome del progresso) non ammette discussioni. Rispetto al “perché”, invece, dobbiamo domandarci se il vero movente di questo iperattivismo delle multinazionali dell’energia risponda realmente una nobile esigenza collettiva (liberarci dalla dipendenza dagli idrocarburi) o sia il frutto della più prosaica volontà di lucrare grazie alle grandi remunerazioni dei capitali investiti che questo settore garantirebbe per una consistente serie di ragioni: generosi contributi pubblici e considerevoli vantaggi fiscali; semplificazione burocratica degli iter di autorizzazione; assenza di una quantità considerevole forza lavoro da retribuire lungo il processo produttivo (eccezion fatta per la sua fase di avvio).
Se a prevalere fosse la seconda esigenza, infatti, ci troveremmo di fronte a un colossale processo di alienazione di beni pubblici (simile alla accumulazione originaria su cui scrisse Marx) in favore di grandi fortune (private) senza alcuna ricaduta sociale, a meno di non prendere per buona la leggenda della cara vecchia “mano invisibile”, che trasformerebbe l’utile individuale in ricchezza generale.
Al di là dei richiami al principio della cosiddetta “generazione distributiva”, nei fatti, la tendenza prevalente spinge a raggruppare i parchi eolici in una determinata regione per produrre una grande quantità di energia da uno spazio concentrato. In un mondo contraddistinto da rapporti di sviluppo diseguale la scelta sul dove “concentrare” è tutto fuorché politicamente neutra. Detta in altre parole, in assenza di una pianificazione democratica, i “Sud del mondo”, interni ed esterni all’Occidente, sono inevitabilmente destinati a essere oggetto di molteplici e stratificati processi di assedio, continuando a svolgere indefinitamente nel tempo il ruolo passivo di aree di sfruttamento coloniale a vantaggio delle regioni ricche del pianeta.
Così, non è un caso se in Brasile (sesta nazione al mondo (e leader in America Latina per capacità eolica installata, con 910 parchi eolici, con 10.178 turbine eoliche e una capacità installata di 26.057,53 MW) l’80% dei progetti riguarda il Nordest (Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Bahia, Piaui, Paraiba), ossia, la parte storicamente più povera e sfruttata, ora trasformata in piattaforma energetica a vantaggio del Sud ricco e industrializzato.
Tutto questo non è avvenuto pacificamente, ma per mezzo di un colossale processo di espropriazione che ha contrapposto le multinazionali energetiche alle comunità dei contadini, dei pescatori, degli Indios in molti casi costrette ad abbandonare i loro insediamenti, segnati da radicali mutamenti di ecosistema, relazioni sociali e rapporti produttivi.
La transizione energetica è un grande progresso e un’opportunità, a condizione che sia democratica, con tutta la radicalità che questo termine assume nella storia dell’umanità, non il risultato di relazioni di dominio e sfruttamento tra chi governa e chi è governato.