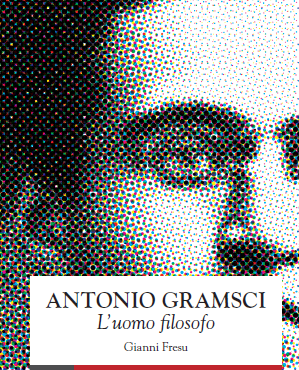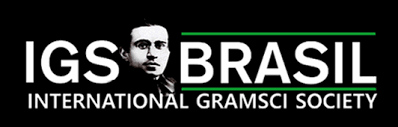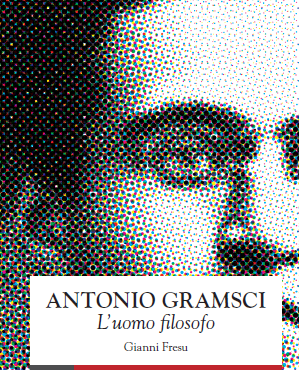di Gianni Fresu
 A Gramsci il fascismo appariva per sua natura in profonda contraddizione con i coevi tentativi di razionalizzazione fordista […]. «Lo Stato fascista – scriveva nei Quaderni – crea nuovi redditieri, cioè promuove le vecchie forme di accumulazione parassitaria del risparmio e tende a creare dei quadri chiusi sociali. In realtà finora l’indirizzo corporativo ha funzionato per sostenere posizioni pericolanti di classi medie, non per eliminare queste e sta sempre più diventando, per gli interessi costituiti che sorgono dalla vecchia base, una macchina di conservazione dell’esistente così come è e non una molla di propulsione. Perché? Perché l’indirizzo corporativo è anche in dipendenza della disoccupazione: difende agli occupati un certo minimo di vita che, se fosse libera la concorrenza, crollerebbe anch’esso, provocando gravi rivolgimenti sociali; e crea occupazioni di nuovo tipo, organizzativo e non produttivo, ai disoccupati delle classi medie». Attraverso la trasformazione dello Stato e la creazione del corporativismo, il fascismo produceva trasformazioni nella struttura produttiva tendenti alla socializzazione e alla cooperazione nella produzione, senza intaccare però le modalità individuali e private di appropriazione dei profitti. In concreto questo significava che attraverso il fascismo si cercava uno sviluppo delle forze produttive industriali senza sottrarne la direzione alle classi tradizionali, per consentire al capitalismo italiano di uscire dalla sua crisi organica e competere con le potenze capitalistiche detentrici del monopolio delle materie prime e con capacità di accumulazione maggiore. Lo schema di questa rivoluzione passiva per Gramsci aveva ben poche possibilità di riuscita pratica, tuttavia dal punto di vista della mobilitazione e della capacità egemonica del regime, ciò era di importanza relativa: «Ciò che importa ideologicamente è che esso può avere realmente la virtù di prestarsi a creare un periodo di attesa e di speranze, specialmente in certi gruppi sociali italiani, come la massa dei piccolo-borghesi urbani e rurali, e quindi a mantenere il sistema egemonico e le forze di coercizione militare e civile a disposizione delle classi dirigenti tradizionali» (dai «Quaderni dal carcere»). In coclusione, le riflessioni sul fascismo di Gramsci sfuggono a troppo rigide classificazioni storiografiche. Il materialismo storico è il dato di partenza, tuttavia, anche i termini soggettivi, compresa la crisi morale della borghesia – hanno un ruolo determinante e centrale. Anche Gramsci interpreta il fascismo come reazione a una fase di profondi rivolgimenti sociali legati alla prima guerra mondiale e soprattutto alla rivoluzione d’ottobre, tuttavia, non giunge mai a considerare la borghesia e il suo modo di produzione come un unico blocco omogeneo. Egli legge all’interno del blocco sociale dominante differenziazioni e contraddizioni palesatisi proprio in rapporto alla nascita e all’avvento del fascismo. Gramsci, come gran parte dei suoi coevi compagni di lotte, ha analizzato il tentativo di centralizzazione degli interessi borghesi dietro al fascismo, ma lo riteneva un fenomeno sociale sorto tra la piccola e media borghesia urbana, sviluppatosi grazie agli apporti degli agrari e quelli, non sempre lineari e armonici, del grande capitale industriale. Infine, l’intellettuale sardo ha interpretato storicisticamente il fascismo in rapporto alla debolezza delle classi dirigenti e ai limiti nel processo di unificazione politica e modernizzazione economica dell’Italia, ma non lo ha mai inteso un esito inevitabile di quel processo. In tutto questo, un ruolo peculiare è attribuito al ruolo di alcune categorie ampiamente operative in quel dato frangente storico: il cesarismo, il bonapartismo, la fede verso le virtù taumaturgiche del «capo carismatico», cui Grasmci dedica numerose riflessioni e che meriterebbero una trattazione separata per la vastità dei contenuti trattati e delle implicazioni analitiche. Tutto questo insieme di valutazioni porta a un’ultima conclusione: il fascismo non può certo essere ritenuto una parentesi irrazionale in una storia per il resto segnata dall’inarrestabile progressione liberale e democratica, un’improvvisa malattia morale, capace di obnubilare le menti degli italiani, che ha aggredito un corpo sano per poi sparire senza lasciare traccia. A centocinquanta anni dall’Unità d’Italia, le riflessioni di Gramsci suggeriscono di evitare accuratamente ogni lettura agiografica di quella storia. Senza trasformarla in un’opera di teratologia intellettuale, è opportuno interrogarsi problematicamente sulla totalità e organicità dei processi storici, sui limiti congeniti dell’intera vita politica italiana. Proprio questa problematicità ha spinto Gramsci a evitare qualsiasi lettura storiografica e politica manichea. Il fascismo costituisce la negazione più completa per valori e prospettive del campo marxista, ciò nonostante l’intellettuale sardo lo ha analizzato come fenomeno razionale e reale, scaturito da precise cause storicamente determinate.
A Gramsci il fascismo appariva per sua natura in profonda contraddizione con i coevi tentativi di razionalizzazione fordista […]. «Lo Stato fascista – scriveva nei Quaderni – crea nuovi redditieri, cioè promuove le vecchie forme di accumulazione parassitaria del risparmio e tende a creare dei quadri chiusi sociali. In realtà finora l’indirizzo corporativo ha funzionato per sostenere posizioni pericolanti di classi medie, non per eliminare queste e sta sempre più diventando, per gli interessi costituiti che sorgono dalla vecchia base, una macchina di conservazione dell’esistente così come è e non una molla di propulsione. Perché? Perché l’indirizzo corporativo è anche in dipendenza della disoccupazione: difende agli occupati un certo minimo di vita che, se fosse libera la concorrenza, crollerebbe anch’esso, provocando gravi rivolgimenti sociali; e crea occupazioni di nuovo tipo, organizzativo e non produttivo, ai disoccupati delle classi medie». Attraverso la trasformazione dello Stato e la creazione del corporativismo, il fascismo produceva trasformazioni nella struttura produttiva tendenti alla socializzazione e alla cooperazione nella produzione, senza intaccare però le modalità individuali e private di appropriazione dei profitti. In concreto questo significava che attraverso il fascismo si cercava uno sviluppo delle forze produttive industriali senza sottrarne la direzione alle classi tradizionali, per consentire al capitalismo italiano di uscire dalla sua crisi organica e competere con le potenze capitalistiche detentrici del monopolio delle materie prime e con capacità di accumulazione maggiore. Lo schema di questa rivoluzione passiva per Gramsci aveva ben poche possibilità di riuscita pratica, tuttavia dal punto di vista della mobilitazione e della capacità egemonica del regime, ciò era di importanza relativa: «Ciò che importa ideologicamente è che esso può avere realmente la virtù di prestarsi a creare un periodo di attesa e di speranze, specialmente in certi gruppi sociali italiani, come la massa dei piccolo-borghesi urbani e rurali, e quindi a mantenere il sistema egemonico e le forze di coercizione militare e civile a disposizione delle classi dirigenti tradizionali» (dai «Quaderni dal carcere»). In coclusione, le riflessioni sul fascismo di Gramsci sfuggono a troppo rigide classificazioni storiografiche. Il materialismo storico è il dato di partenza, tuttavia, anche i termini soggettivi, compresa la crisi morale della borghesia – hanno un ruolo determinante e centrale. Anche Gramsci interpreta il fascismo come reazione a una fase di profondi rivolgimenti sociali legati alla prima guerra mondiale e soprattutto alla rivoluzione d’ottobre, tuttavia, non giunge mai a considerare la borghesia e il suo modo di produzione come un unico blocco omogeneo. Egli legge all’interno del blocco sociale dominante differenziazioni e contraddizioni palesatisi proprio in rapporto alla nascita e all’avvento del fascismo. Gramsci, come gran parte dei suoi coevi compagni di lotte, ha analizzato il tentativo di centralizzazione degli interessi borghesi dietro al fascismo, ma lo riteneva un fenomeno sociale sorto tra la piccola e media borghesia urbana, sviluppatosi grazie agli apporti degli agrari e quelli, non sempre lineari e armonici, del grande capitale industriale. Infine, l’intellettuale sardo ha interpretato storicisticamente il fascismo in rapporto alla debolezza delle classi dirigenti e ai limiti nel processo di unificazione politica e modernizzazione economica dell’Italia, ma non lo ha mai inteso un esito inevitabile di quel processo. In tutto questo, un ruolo peculiare è attribuito al ruolo di alcune categorie ampiamente operative in quel dato frangente storico: il cesarismo, il bonapartismo, la fede verso le virtù taumaturgiche del «capo carismatico», cui Grasmci dedica numerose riflessioni e che meriterebbero una trattazione separata per la vastità dei contenuti trattati e delle implicazioni analitiche. Tutto questo insieme di valutazioni porta a un’ultima conclusione: il fascismo non può certo essere ritenuto una parentesi irrazionale in una storia per il resto segnata dall’inarrestabile progressione liberale e democratica, un’improvvisa malattia morale, capace di obnubilare le menti degli italiani, che ha aggredito un corpo sano per poi sparire senza lasciare traccia. A centocinquanta anni dall’Unità d’Italia, le riflessioni di Gramsci suggeriscono di evitare accuratamente ogni lettura agiografica di quella storia. Senza trasformarla in un’opera di teratologia intellettuale, è opportuno interrogarsi problematicamente sulla totalità e organicità dei processi storici, sui limiti congeniti dell’intera vita politica italiana. Proprio questa problematicità ha spinto Gramsci a evitare qualsiasi lettura storiografica e politica manichea. Il fascismo costituisce la negazione più completa per valori e prospettive del campo marxista, ciò nonostante l’intellettuale sardo lo ha analizzato come fenomeno razionale e reale, scaturito da precise cause storicamente determinate.