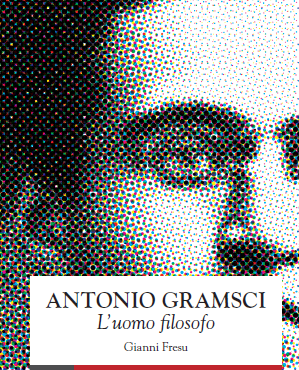Crisi organica e sovversivismo reazionario.
Coincidenze politiche di un binomio indissolubile.
Gianni Fresu
In più occasioni mi è capitato di affermarlo, l’opera di Antonio Gramsci è spesso percepita come materia buona giusto per l’archeologia politica o materiale liturgico-iconografico, preso in considerazione per gli anniversari di nascita e morte dell’intellettuale sardo. Al contrario, ritengo l’opera di Gramsci uno straordinario strumento per leggere alcune contraddizioni caratteristiche della società in cui viviamo. Certe dinamiche sociali e storiche tendono a ripresentarsi ciclicamente, con forme, modalità, spinte profondamente diverse, tuttavia, in filigrana è possibile leggere impressionanti elementi in comune. Quanto affermato sopra vale soprattutto per l’analisi di Gramsci sulla «crisi organica» della società capitalistica prima e dopo la guerra mondiale, una crisi non solo economica ma di civiltà, e la conseguente involuzione autoritaria del quadro politico-sociale. Un tema al quale Gramsci ha dedicato tutta la sua esistenza, dagli scritti giovanili alle ultime pagine di Lettere e Quaderni. Oggi ci troviamo esattamente in una condizione di «crisi organica» mondiale che investe sia le modalità di produzione, accumulazione e redistribuzione, sia i modelli politici e sociali fin qui prevalenti.
* * *
La prima guerra mondiale provocò nella società europea una profonda crisi economica, politica e culturale. La guerra era stata invocata come progresso e igiene dell’umanità ma, dopo la sbornia di retorica patriottica e militare, quel che restava era un quadro sociale profondamente disgregato segnato da alcuni fattori destinati a deflagrare tra loro: l’inefficacia e l’instabilità del sistema liberale, l’impoverimento e il ridimensionamento dei ceti medi, l’irrompere sulla scena delle grandi masse popolari mobilitate durante il conflitto. La situazione attuale ha come elemento profondo di diversità la passività o comunque la grande disgregazione delle masse popolari, tuttavia, se allora la crisi fu originata dalla disillusione per i miraggi del bottino bellico, oggi possiamo dire che essa scaturisce dal fallimento delle mirabili promesse della globalizzazione liberista. Con la fine della guerra fredda (la cosiddetta «fine della storia»), secondo gli apologeti delle leggi di mercato, grazie alla concorrenza e l’uniformarsi del mondo a un solo modello di sviluppo, si sarebbe dovuta aprire una fase nuova di prosperità e pace: più lavoro, opportunità e ricchezza per tutti.
Sia dopo la prima guerra mondiale, sia in questa crisi, a fronte del concentrarsi di ricchezze enormi sulle categorie sociali elevate, abbiamo un impoverimento generale della società che raggiunge le sue forme più fragorose nei ceti medi irrequieti. Allora si parlò di proletarizzazione dei ceti medi, oggi magari si usano altre terminologie ma la sostanza delle cose non muta troppo.
Peraltro, oggi come allora, proprio i ceti medi hanno vissuto il proprio declassamento come un tradimento. Se il principale megafono dell’«ideologia astratta e ampollosa della guerra» fu proprio la piccola e media borghesia, dagli anni Ottanta in poi la principale base sociale delle politiche liberiste si ritrova (in Europa come negli USA) tra i ceti medi. Pensiamo al caso italiano, dalla Marcia dei Quarantamila fino all’avvento del berlusconismo. Proprio come nel dopoguerra, la classe più mobilitata nella rincorsa della nuova frontiera è uscita dalla “trincea” con le ossa rotte e un ruolo politico, economico e sociale ridimensionato. In linea generale, secondo Gramsci, nelle fasi di «crisi organica» si hanno insieme un declassamento e una radicalizzazione dei ceti medi, per questo i rischi maggiori di «sovversivismo reazionario» vengono proprio dalle convulsioni di questa classe sociale.
Tutto questo fu descritto con grande capacità di sintesi nell’articolo Il popolo delle scimmie, pubblicato su «L’Ordine Nuovo», il 2 gennaio 1921, nel quale Gramsci descrive la parabola della piccola borghesia italiana: dall’avvento della “sinistra” al potere sino alla nascita del movimento fascista. Con lo sviluppo del capitalismo finanziario la piccola borghesia perde una sua funzione nella produzione divenendo «pura classe politica» che per Gramsci si specializza nel «cretinismo parlamentare». È questo un fenomeno che assume fisionomie diverse e che si esprime attraverso i governi della sinistra, il giolittismo, il riformismo socialista. A questa degenerazione della piccola borghesia corrisponde la degenerazione del Parlamento che diviene «bottega di chiacchiere e scandali, diviene un mezzo al parassitismo», un Parlamento corrotto fino al midollo che perde progressivamente prestigio presso le masse popolari. La sfiducia verso l’istituzione parlamentare porta le stesse masse popolari ad individuare nell’azione diretta dell’opposizione sociale l’unico strumento di controllo e pressione, l’unico modo per far valere la propria sovranità contro gli arbitri del potere. In tal senso Gramsci interpreta la settimana rossa del giugno 1914. Attraverso l’interventismo, l’avventurismo di D’Annunzio e il fascismo, la piccola borghesia «scimmieggia la classe operaia e scende in piazza».
La decadenza del Parlamento è massima nel corso della guerra e la piccola borghesia cerca di consolidare la sua nuova posizione barricadera attraverso un miscuglio ideologico di imperialismo nazionalista e sindacalismo rivoluzionario. Nella sua carica antiparlamentare secondo Gramsci la piccola borghesia cerca di organizzarsi attorno a padroni più ricchi, trova un punto di sostegno tra gli agrari e gli industriali. Così anche se l’avventura fiumana si pone come il «motivo sentimentale» di questa intensa iniziativa, il centro vero dell’organizzazione risiede nella difesa della proprietà industriale e agraria, contro le rivendicazioni delle classi subalterne e la loro crescente efficacia organizzativa. A sua volta la classe proprietaria commette l’errore di credere che si possa difendere meglio dagli assalti del movimento operaio e contadino abbandonando gli istituti del suo Stato e seguendo «i capi isterici della piccola borghesia».
Quando si verifica una condizione di «crisi organica», i gruppi sociali si staccano dai loro partiti tradizionali non riconoscendo più nei propri gruppi dirigenti l’espressione politica dei propri interessi di classe. In situazioni di tale tipo si moltiplicano le possibili soluzioni di forza, i rischi di sovversivismo reazionario, le operazioni oscure sotto la guida di capi carismatici. Il determinarsi di questa frattura tra rappresentati e rappresentanti porta per riflesso al rafforzamento di tutte quegli organismi relativamente indipendenti dalle oscillazioni dell’opinione pubblica come la burocrazia militare e civile, l’alta finanza, la chiesa. Dietro alla crisi di egemonia del regime liberale in Italia c’era l’inutile sforzo per la guerra, con il suo carico di promesse millantate non mantenute, l’irrompere di soggetti sociali prima passivi.
E il contenuto è la crisi di egemonia della classe dirigente, che avviene o perché la classe dirigente ha fallito in qualche sua grande impresa politica per cui ha domandato o imposto con la forza il consenso delle grandi masse (come la guerra) o perché vaste masse (specialmente di contadini e piccoli borghesi intellettuali) sono passati di colpo dalla passività politica a una certa attività e pongono rivendicazioni che nel loro complesso disorganico costituiscono una rivoluzione. Si parla di «crisi di autorità» e ciò è appunto la crisi di egemonia, o crisi dello Stato nel suo complesso .
In una fase di crisi organica sono le classi subalterne a correre i maggiori rischi, poiché le classi dirigenti tradizionali dispongono di quadri e personale dirigente più addestrato, esse sono capaci di modificare uomini e programmi riacquistando il pieno controllo di una realtà che gli andava sfuggendo, mantenendo il potere e utilizzandolo per rafforzare la propria posizione. Si ha così il passaggio della massa di manovra dei diversi partiti in un unico partito che riassume gli interessi dell’intera classe centralizzandone la direzione, ritenuta la sola capace di superare il pericolo mortale insito nella crisi. Sempre tenuto conto del riferimento italiano, sembra chiaro per Gramsci che l’avvento del fascismo avesse tra le sue cause sia i limiti del movimento socialista sia quelli delle classi dirigenti tradizionali.
Quando la crisi non trova questa soluzione organica, ma quella del capo carismatico, significa che esiste un equilibrio statico (i cui fattori possono essere i più disparati, ma in cui prevale l’immaturità delle forze progressive) che nessun gruppo, né quello conservativo né quello progressivo, ha la forza necessaria alla vittoria e che anche il gruppo conservativo ha bisogno di un padrone.
Oggi, una delle principali professione di fede di movimenti come i “forconi” è la loro contrapposizione alla politica in quanto tale e un odio viscerale vero i partiti, qua non mi interessa discutere su quanto siano profonde e giustificate le ragioni di questo atteggiamento, bensì riflettere sulla sua tipicità e tendenziale emersione nelle fasi di crisi. Gramsci rilevò tra i «caratteri del popolo italiano» un certo inidividualismo apoliticista, in ragione del quale ai partiti politici e al sindacato si preferiscono altre forme organizzate, le cricche, più di carattere malavitoso o camorristico che politico. Ogni livello di civiltà ha un suo tipo di individualismo, e questo corrispondeva alla fase nelle quale i bisogni economici non potevano trovare soddisfazione regolare e permanente a causa della miseria e della disoccupazione. Le origini di tale condizione erano profonde e le responsabilità stavano in capo alla classe dirigente nazionale.
All’apoliticismo delle masse popolari corrisponde una sorta di corporativismo settario negli strati superiori e dominanti, legato però non all’intransigenza su principi e valori (quindi non un settarismo giacobino alla francese o alla russa), bensì a meri interessi economici, allo spirito di consorteria. Espressione politica di questo «carattere del popolo italiano» è il «pressappoco» nella fisionomia dei programmi, delle ideologie, dei partiti. La natura di questo carattere spiega per Gramsci la deteriorità dei partiti politici italiani, sorti tutti non come frazione organica o avanguardie delle classi popolari ma sul terreno elettorale. Quei partiti furono «un insieme di piccoli intellettuali di provincia che rappresentavano una selezione alla rovescia», dato il livello di miseria del paese queste organizzazioni erano attrattive soprattutto per le possibilità economiche che sapevano offrire. Anche in questo caso non occorre troppa fantasia per trovare punti di congiunzione fortissimi con la situazione che abbiamo sotto gli occhi. Per far parte di un determinato partito bastava l’approssimazione del «pressappoco», «bastavano poche idee vaghe, imprecise, indeterminate, sfumate: ogni selezione era impossibile, ogni meccanismo di selezione mancava e le masse dovevano seguire questi partiti perché altri non ne esistevano». La passività e l’apoliticismo delle grandi masse, che facilitano il reclutamento di volontari, rendendole massa di manovra; la composizione sociale italiana, nella quale esisteva una presenza sproporzionata e «malsana» di borghesia rurale improduttiva, di piccola e media borghesia al cui interno si formano intellettuali irrequieti facilmente suggestionabili da qualsiasi iniziativa «anche la più bizzarra che sia vagamente sovversiva», dunque «volontari»; la grande presenza di sottoproletariato urbano e bracciantato agricolo. Tra gli elementi che hanno concorso alla popolarità di D’Annunzio e del fascismo Gramsci elenca: anzitutto, l’apoliticità del popolo italiano e soprattutto della piccola borghesia, una apoliticità, definita irrequieta e riottosa, facilmente seducibile da parte di qualsiasi avventura e avventuriero, specie se a essa le forze dell’ordine costituito si oppongono solo debolmente e senza metodo; l’assenza di una tradizione dominante e forte, riconducibile un partito di massa, capace di orientare le passioni popolari con direttive storico politiche, vale a dire l’assenza di un vero e proprio partito di massa della borghesia; il contesto successivo alla guerra, dove tutti questi fattori di apoliticità riottosa si moltiplicano. Quattro anni di guerra hanno disancorato da qualsiasi disciplina statale gli elementi più irrequieti della piccola borghesia rendendoli, ancora di più, «moralmente e socialmente vagabondi»; «quistioni sessuali, che dopo quattro anni di guerra si capisce essersi riscaldate enormemente».
Oggi ci troviamo in una situazione per molti versi simile, sicuramente diversa, non comprimibile nelle braghe dell’analogia storica, tuttavia, proprio dai drammi passati deve scaturire per le forze politiche della sinistra la consapevolezza che nulla va sottovalutato. Le crisi organiche sono dominate dalle «rivoluzioni passive», vale a dire, fasi di modernizzazione autoritaria nelle quali le “riforme” vengono realizzate attraverso la passività coatta delle grandi masse popolari, con il preciso obiettivo di consolidare l’ordine sociale ed uscire dalla situazione di crisi. Il fascismo è uno degli esempi più emblematici di ciò, ma non il solo.
Siamo di fronte ad un gigantesco tentativo di ristrutturazione internazionele dei rapporti sociali e di produzione da parte delle classi dominanti, la cui portata potrà essere valutata appieno solo tra venti o trenta anni. Le scorciatoie per raggiungere questo risultato sono sempre in agguato. Le forze favorevoli alle svolte reazionarie tendono a utilizzare le categorie sociali irrequiete, come massa di manovra, e sovente si servono di movimenti più ambigui e bizzarri:
È questo un modo di procedere molto utile per facilitare le «operazioni» di quelle «forze occulte» o «irresponsabili» che hanno per portavoce i «giornali indipendenti»: esse hanno bisogno ogni tanto di creare movimenti occasionali di opinione pubblica, da mantenere accesi fino al raggiungimento di determinati scopi e da lasciar poi illanguidire e morire .
Riflettere e provare a mettere in relazione i tanti segnali contraddittori della situazione attuale non è per niente facile, ma penso sia un dovere impossibile da aggirare, salvo pentirsene amaramente in seguito per non averlo fatto.