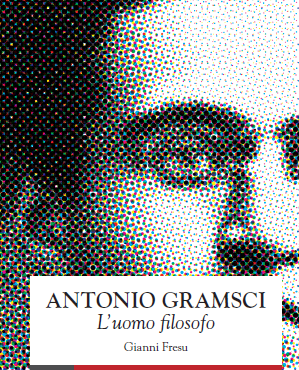Intervento al Convegno
“70° della Costituzione”. Dalla Resistenza alla costituente, fra passato e futuro.
Cagliari 15 gennaio 2017.
Secondo Calamandrei, per comprendere lo spirito della Costituzione era necessario risalire al processo che la generò, la sua origine andava ricercata tra i monti, là dove si combatté la lotta di liberazione nazionale dal nazi-fascismo. Un concetto che ritroviamo in un altro Padre costituente particolarmente importante per noi come Renzo Laconi. Tra le carte trovate dopo la sua morte (avvenuta il 19 giugno 1967) un posto di particolare rilievo è occupato dagli appunti per un saggio destinato a «Critica marxista» per il ventesimo anniversario della Costituzione repubblicana[1]. In queste note la sua polemica era rivolta alla vulgata esegetica della letteratura giuridica e costituzionale che si andava accumulando con l’approssimarsi di quell’anniversario. Laconi lamentava un deficit di indagine storica sulle origini ideologiche e politiche della Costituzione, dato che l’interesse degli studiosi sembrava concentrarsi totalmente sugli atti dell’Assemblea costituente e sul suo quadro dottrinale. Uno studio meramente tecnico, sia sul versante giuridico sia su quello politico, che attribuiva più importanza alla comparatistica costituzionale che al concreto contesto storico da cui era scaturita la Costituzione. Ma una Costituzione, specie quella italiana, scrive Laconi in queste note, è un documento politico e ideologico, sorge dalla dialettica politica, dal contrasto delle idee tra uomini, forze sociali e politiche.
Non esiste concezione politica (organica e coerente o contraddittoria che sia) senza una impostazione ideologica e anche il paradigma anti-ideologico è una ideologia in sé, eppure oggi non c’è ambito politico, giornalistico o accademico nel quale non si ripeta il mantra della critica alle ideologie. Come se il limite della politica contemporanea sia da ricercare nel suo contenuto ideologico e non, al contrario, nell’assenza di visione complessiva del mondo. Si confonde l’ideologia con la demagogia, ma anche questa, a sua volta, come scriveva Gramsci, può assumere una funzione positiva e progressiva se posta al servizio di un processo teso all’elevamento di più ampi strati sociali rispetto a quelli tradizionali dominanti.
A partire da questa consapevolezza, secondo Laconi, la Costituzione va considerata come un atto vivente, non può essere ridotta a una sommatoria di norme, a uno schema tecnico «elaborato a tavolino». Per questa ragione non sarebbe stato possibile né comprendere né valutare criticamente sia l’impianto generale sia le minute norme della Costituzione senza aver colto il senso dell’impostazione concettuale e ideologica che in questa dialettica ha finito per prevalere, giungendo ad una volontà collettiva ed unitaria. Per Laconi la gran parte dei costituzionalisti italiani non comprendeva l’effettiva originalità ideologica della Costituzione italiana perché la interpretavano come una semplice restaurazione modernizzata, sotto le forme repubblicane, della macchina statale liberale prefascista. Una tale impostazione era per Laconi antistorica e priva di consistenza scientifica, oltre a essere del tutto arbitraria. Per interpretare il significato della Costituzione si sarebbe dovuto partire dal coacervo di avvenimenti che caratterizzarono il periodo tra il 43 e il 46, con il superamento della classe dirigente prefascista e l’avvento dei tre partiti di massa, l’opposizione storica nel vecchio Stato liberale che nell’Assemblea costituente ottennero 392 voti su 476. Tra questi tre partiti non c’era piena affinità ideologica, ma essi partivano da una base comune: non solo la condanna del fascismo, e la critica pesante per le responsabilità dei gruppi dirigenti liberali, ma anche l’esigenza di creare uno Stato interventista di tipo solidaristico. Questa base comune trovava nella Costituzione un impianto programmatico vincolante che andava oltre la concezione liberale dello Stato, dunque non era né una rivoluzione né una restaurazione.
Ma se la Costituzione ha le sue radici nella lotta di liberazione nazionale, l’origine di quest’ultima andrebbe ricercata nel decennio più drammatico eppure di svolta per l’antifascismo, segnato dal massimo trionfo interno e internazionale del regime di Mussolini. Il quadro in cui si determina la cosiddetta svolta degli anni Trenta ci parla di un movimento antifascista, fin lì perdente e lacerato da profonde divisioni, per la prima volta finalmente capace di guardare in faccia ai propri errori e superarli sottoponendo a severa autocritica l’astrattezza settaria del suo operare e, più in generale, una concezione meramente moralistica e cospirativa di opposizione alla dittatura. Come ho spiegato in una mia monografia a lui dedicata[2], Curiel e la sua generazione si sono rivelati decisivi nel favorire e accompagnare questo processo, consentendo all’antifascismo di recuperare legami con una realtà nazionale (in particolare i giovani e il mondo del lavoro) del tutto indifferente agli sforzi compiuti in clandestinità o in esilio.
Contrariamente a quanto ritenuto da gran parte dell’antifascismo, il regime di Mussolini esercitava un consenso reale nel Paese, non era solo esercizio monopolistico e violento della forza statale. Il fascismo era una forma nuova e moderna di regime autoritario, si serviva abilmente dei grandi mezzi di comunicazione di massa, puntava a irreggimentare e mobilitare (seppur in funzione passiva e coreografica) le grandi masse popolari nel regime, certo basava il suo potere anzitutto sul dominio diretto, ciò nonostante, riusciva, grazie a complessi e stratificati strumenti di costruzione del consenso presso la società civile, anche a esercitare un’egemonia reale piuttosto estesa nella metà degli anni Trenta. La comprensione di ciò, era la premessa essenziale per un differente approccio all’attività antifascista e per abbandonare ogni atteggiamento settario, moralistico e meramente cospirativo. Dividere l’Italia in due blocchi monolitici e contrapposti (da una parte le anime perse e irrecuperabili dei sostenitori del regime, dall’altra i puri del movimento antifascista), non aveva senso. Grazie alla forza di un’efficace azione repressiva e alla macchina della propaganda, il regime aveva il sostegno dalla maggioranza degli italiani, dunque anziché ritrarsi in una sfera di presunta purezza e limitarsi a un’attività cospirativa incentrata sulla mistica del gesto, bisognava mischiarsi con quel popolo, quotidianamente, entrare nelle organizzazioni di massa del regime, coglierne le intime contraddizioni e svuotarne dall’interno le sue basi di consenso. Lavorare nel sindacato fascista e utilizzare le singole lotte economiche dei lavoratori, era la strada scelta per perseguire questo obiettivo. Ciò valeva particolarmente per i giovani ingannati dal regime, presso i quali l’antifascismo doveva compiere un faticoso lavoro di conquista egemonica.
Al di là del contenuto propagandistico, l’offensiva ideologica del fascismo, agli inizi degli anni Trenta, si rivelò efficace nell’attivare politicamente le nuove generazioni. Giovani intellettuali, variamente collocati in ambito sindacale o impegnati culturalmente, in gran parte studenti, trovarono nelle parole d’ordine antiborghesi e nella promessa di una rivoluzione le ragioni del proprio impegno. Aver seminato tante promesse, dando libero sfogo a una retorica profondamente distante da quel che realmente il regime era nella realtà, operazione spregiudicata poi ritortasi contro il fascismo, ebbe però inizialmente l’effetto di rinnovarlo profondamente consentendogli di allargare la base del suo consenso e di superare il momento di crisi, nonostante le grandi contraddizioni e il crescente malessere del mondo del lavoro[3]. Questa paziente attività carsica di penetrazione ed erosione trovò modo di manifestarsi clamorosamente nel corso della guerra, quando una parte significativa di quella gioventù cresciuta a pane e fascismo divenne la spina dorsale della Resistenza.
Gli scioperi scoppiati nelle città industriali del Nord, partiti dall’officina 19 della Fiat Mirafiori di Torino il 5 marzo 1943, che in pochi giorni coinvolsero centomila lavoratori, sono una tappa decisiva nella crisi del fascismo, perché segnano la discesa in campo della classe operaia, e non più, come era accaduto nel corso del “ventennio”, con scioperi parziali, fermate di lavoro o agitazioni circoscritte, in questo caso si trattò di una fermata complessiva dal chiaro significato politico verso il regime. Secondo Secchia, che in proposito richiama anche una stizzita dichiarazione di Mussolini[4], gli avvenimenti di marzo non potevano essere separati dalla definitiva vittoria riportata a Stalingrado il 2 di febbraio, perché questo avvenimento ebbe l’effetto di infondere coraggio sui lavoratori. A questo si aggiunsero i pesanti bombardamenti sulle città italiane, uno schiaffo alle millanterie del fascismo, di cui però fu il popolo a pagare le peggiori conseguenze. La guerra in casa, con le città sfregiate dalle distruzioni, straziate dai corpi senza vita o gravemente feriti di tanti cittadini innocenti, aprì definitivamente gli occhi agli italiani sulle illusioni di vittoria e le bugie di Mussolini rispetto alle sorti della guerra. L’inizio degli scioperi nel marzo ’43 segnarono l’inizio della Resistenza.
Nonostante i tanti dirigenti in carcere o al confino, la rete organizzativa clandestina era riuscita a estendersi dando vita nelle fabbriche ai comitati unitari d’azione antifascista. Nelle settimane che precedettero gli scioperi i gruppi di operai comunisti si riunivano a gruppi di tre, al massimo cinque unità, una copia clandestina de «l’Unità» passava di mano in mano e arrivava a essere letta da almeno cinquanta persone, così come il materiale propagandistico, diffuso secondo severe norme di sicurezza da un’organizzazione per compartimenti stagni. A Milano, già dal 1942, c’era una tipografia del partito a Porta Ticinese, dopo i bombardamenti, venne spostata in una Cascina a Vaprio D’adda. Nonostante i controlli, «l’Unità» usciva con quattro pagine e una tiratura di 4.000 copie raggiungendo tutti gli stabilimenti industriali della città. Nella fase di massima crisi del regime il Partito comunista disponeva, al Centro-Nord, di una struttura operativa, verso cui si orientò il malcontento del mondo del lavoro, essenziale a dare la spallata finale al potere di Mussolini. La Resistenza armata vera è propria iniziò il giorno dopo l’8 settembre, con il tentativo disordinato mal riuscito di difendere Roma. Tuttavia, la narrazione di una Resistenza esplosa immediatamente e in maniera spontanea, con la partecipazione di tutto il popolo, è solo mitologia, in realtà le difficoltà furono enormi. In ogni luogo, là dove si verificarono episodi di opposizione e lotta armata esisteva un’organizzazione antifascista, «non tutti gli italiani si schierarono dalla parte della Resistenza, ma soltanto una minoranza attiva»[5]. Bisogna tenere conto di quanti decisero di schierarsi con i nazifascisti e soprattutto dei tanti che, magari solo per timore e prudenza, si astennero dal farlo senza per questo aderire alla Resistenza. Anche in una parte dell’antifascismo, per un certo periodo, prevalse l’inattività, un atteggiamento «attesista», per eccesso di prudenza si preferì aspettare l’arrivo degli eserciti alleati, evitando «inutili perdite». A fronte di tutto questo, tuttavia, tanti cittadini mostrarono solidarietà verso la Resistenza, cui fornirono aiuti materiali, ospitalità e assistenza, chiarito questo fatto, inizialmente non ci fu certo una corsa in massa per arruolarsi tra le divisioni partigiane. Come ha scritto Secchia, «La Resistenza non fu né un miracolo, né un fenomeno spontaneo: dovette essere organizzata. Dura, difficile, piena di difficoltà fu sempre la lotta, sino alla fine, ma soprattutto all’inizio»[6].
Dopo l’8 settembre, non c’erano solo i problemi della guerra contro l’occupazione, e le mai del tutto superate divisioni interne al fronte antifascista, a rendere più complicato il tutto, c’era l’esigenza di garantire l’unità e l’efficacia delle potenze impegnate nella guerra al nazifascismo. Come ha scritto un altro protagonista come Luigi Longo, gli anglo-americani avevano l’obiettivo di «precostituirsi posizioni di vantaggio nell’Italia liberata» che mal si conciliavano con l’idea della mobilitazione popolare e di massa della lotta partigiana[7] Oltre a ciò, l’aspirazione di una parte dell’antifascismo italiano era tornare all’equilibrio pre-fascista, nella convinzione che il “ventennio” dovesse essere superato e archiviato come una “brutta parentesi” nella storia d’Italia, è questa l’idea del fascismo inteso come “malattia morale dell’Europa”. Tutto questo non poteva non avere riflessi sulle coordinate della guerra di liberazione e sul modo di concepire sia il presente – dunque il tema della partecipazione popolare alle operazioni militari – sia, soprattutto, il futuro: bisognava ricostruire da zero le fondamenta del nuovo Stato democratico oppure salvare e ristrutturare quelle derivanti dal vecchio Statuto Albertino? La linea dell’antifascismo che scelse la prima opzione aveva un duplice connotato: 1) evitare nuovamente la passivizzazione coatta delle grandi masse popolari (attendere gli eserciti alleati e delegare a loro la liberazione), in un momento storico nel quale invece dovevano essere protagoniste; 2) saldare strettamente la lotta popolare di liberazione alla costruzione del futuro quadro democratico costituzionale. Nello specifico, il quadro concettuale e programmatico dei comunisti italiani si articolava a partire dall’idea della “democrazia progressiva”, che concepiva la lotta di liberazione come premessa essenziale per l’avanzamento sociale e politico delle masse popolari nel post-liberazione. Intensificare la partecipazione popolare attraverso gli organismi della resistenza significava dare da subito fondamenta solide a una tale prospettiva. La democrazia progressiva non andava intesa come una «tappa» di avvicinamento alla “terra promessa”, il socialismo, bensì, un «processo» di costruzione molecolare con il quale bisognava misurarsi quotidianamente attraverso ogni singola lotta. Questa processualità necessariamente si sarebbe dovuta manifestare nel contributo delle masse popolari alla ricostruzione materiale e morale del Paese.
L’opera di ricostruzione non poteva fondarsi sui parametri consueti del liberismo e dell’esclusiva proprietà privata dei mezzi di produzione, bisognava connotare in termini sociali la nuova democrazia, che non avrebbe potuto fare a meno della partecipazione statale e delle forme cooperative di intervento economico. Nell’immediato della guerra partigiana l’indicazione strategica era chiara: occorreva legare le azioni di guerriglia, di sabotaggio, propaganda e iniziativa sociale per superare non solo la dittatura fascista, ma anche la semplice riproposizione della vecchia Italia liberale giolittiana. Per questo era necessario rimuovere le condizioni sociali su cui si era strutturato e affermato il fascismo, quindi costruire un quadro politico che non risolvesse la partecipazione popolare al solo momento delle elezioni e nel mero rapporto passivo di delega alla rappresentanza parlamentare. L’insieme delle lotte quotidiane, nelle quali si articolava l’azione delle organizzazioni di massa protagoniste della Resistenza, erano «la realizzazione consentita dalla situazione attuale di quella democrazia progressiva, per la quale si lotta»[8].
Con la guerra di liberazione in corso erano già percepibili le profonde differenziazioni tra le forze antifasciste sulle prospettive del Paese, fondamentalmente divise tra due fronti contrapposti: uno, di ispirazione liberale guidato da Croce, favorevole ad una restaurazione dei vecchi assetti istituzionali prefascisti; un altro interessato a costruire attraverso l’Assemblea costituente un diverso equilibrio democratico.
In tal senso, la lotta all’attesismo, che vide in prima fila comunisti, socialisti, azionisti e anche cattolici, dunque lo sforzo teso a favorire la partecipazione del popolo alla lotta di liberazione nazionale, non va archiviata come una semplice manifestazione di dialettica politica. Il ruolo delle divisioni partigiane nella liberazione del Centro Nord ha avuto delle conseguenze sullo status post-bellico dell’Italia, contribuendo non poco a un fatto troppo spesso sottovalutato: delle tre nazioni un tempo facenti parte del «Patto tripartito», solo l’Italia vanta una Costituzione frutto di un processo di partecipazione popolare così ampio e socialmente avanzato, non emanazione degli eserciti occupanti. Tutto questo trovò poi traduzione nella Costituzione nata da questo processo popolare, perché la sua ispirazione fondamentale, sia nei primi 3 articoli, sia in quelli di previsione economico-istituzionale, non si limita a disegnare l’impianto di uno Stato che detta le regole e si limita a farle rispettare, lo “Stato Ottocentesco della toga e della spada”. La Costituzione nasce con un obbiettivo radicalmente nuovo rispetto al vecchio Statuto pre-fascista, attribuire alla Repubblica il compito di “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. Come è stato scritto sovente, essa nasce dalla fusione delle tre principali culture politiche del Paese (cattolica, liberale e marxista) sforzandosi di conciliare i concetti di uguaglianza formale e sostanziale, in un nuovo quadro più avanzato orientato al progressivo ampliamento degli spazi di democrazia politica, economica e sociale con il compito di garantire la partecipazione permanente e il protagonismo dei lavoratori nella vita del Paese. Dunque non solo l’idea di libertà negativa, propria della tradizione liberale, intesa come intangibilità da parte dello Stato della sfera individuale privata, ma anche quella di libertà positiva, di tradizione democratica, intesa come diritto del popolo a essere parte attiva e protagonista, non passiva e subalterna, dei processi decisionali, nella quale la rimozione degli ostacoli economico sociali all’esercizio dell’effettiva uguaglianza (sul piano sostanziale e non semplicemente formale) assume un ruolo inedito nella storia dell’Italia. La Costituzione ha messo in discussione idea di un rapporto inversamente proporzionale tra sfera delle libertà e estensione delle attività dello Stato, uno dei più duraturi miti del liberalismo. Ha messo in soffitta la tradizionale condanna all’ambizione di regolare politicamente la vita sociale, intervenire in economia e dare un indirizzo alla vita di una comunità nazionale. Questo è il dato filosofico-politico di fondo, tuttavia, guardando in modo spassionato all’attualità, dobbiamo fare i conti con una realtà ben differente. In un periodo storico nel quale viene riaffermata la pretesa capacità “naturale” di autoregolamentazione delle leggi di mercato, teoricamente incompatibile con “l’artificiale” irruzione ordinatrice della politica, proprio su questo versante programmatico, il quadro di oggi appare drammaticamente più arretrato e ottocentesco rispetto ad allora. In questa contraddizione, squisitamente politica, risiede la ragione della parziale e limitata applicazione della Costituzione, dunque la mancata attuazione di molti dei suoi principi fondamentali, problemi non risolvibili attraverso le cicliche e fallimentari operazioni di ingegneria istituzionale degli ultimi decenni.
[1] R. Laconi, Parlamento e Costituzione, (a cura di) E. Berlinguer, G. Chiaromonte, Editori Riuniti, Roma, 1969.
[2] G. Fresu, Eugenio Curiel. Il lungo viaggio contro il fascismo, Odradek, Roma, 2013.
[3] G. Accame, Il fascismo immenso e rosso, Settimo Sigillo, Roma, 1990.
[4] P. Secchia, Lotta antifascista e giovani generazioni, La Pietra, Milano, 1973, pag. 6.
[5] P. Secchia, Il Partito comunista italiano e la guerra di liberazione nazionale (1943-1945),Op. cit., pag. 110.
[6] Ivi, pag. 111.
[7] L. Longo, I centri dirigenti del PCI nella Resistenza, Editori riuniti, Roma, 1977, pag. 24.
[8] Il Fronte della Gioventù verso la democrazia progressiva, «Bollettino del Fronte della Gioventù», n. 8, agosto 1944, pag. 1, in “Fondo Curiel”, sez. VI, cart. 1, Archivio Istituto “Gramsci”, Roma.