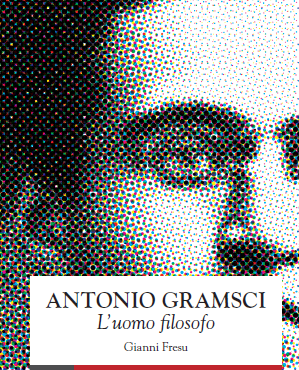Enrico Berlinguer aderì al PCI nell’agosto del 1943, dopo essersi recato con il cugino Sergio Siglienti presso la serra di fiori del pistoiese Renato Bianchi, sede delle riunioni clandestine dei comunisti sassaresi. Nonostante la provenienza sociale, una famiglia importante e carica di storia come i Berlinguer, Enrico si avvicinò al mondo comunista frequentando gli ambienti popolari di Sassari. L’antifascismo faceva parte del codice genetico della sua famiglia, il padre Mario, repubblicano, era una delle personalità più in vista dell’antifascismo sardo e la sua casa era un punto d’incontro politico e intellettuale degli ambienti della borghesia sassarese avversa a Mussolini. Le prime letture sovversive, Bakunin e Marx, arrivarono grazie allo zio paterno Ettore, il più giovane degli zii, scapestrato ed eterno scapolone, ritenuto la pecora nera della famiglia, di orientamento libertario con sfumature che andavano dalle istanze anarcoidi a quelle comuniste. Era lo zio preferito del giovane e ribelle Enrico, piuttosto refrattario alle regole familiari, tanto da avere una vita assai stentata da studente nel prestigioso Liceo Classico Azuni di Sassari. Come numerose biografie hanno ampiamente chiarito, quelle di Peppino Fiori[1] e di Chiara Valentini[2] tra tutte, il giovane Berlinguer alla scuola preferiva le interminabili le partite a poker in un vecchio Bar del centro di Sassari, dal nome altisonante ben poco rispondente alla realtà del luogo, l’Apollo, o nella famigerata bettola di Rubattu, frequentata da operai, artigiani e contadini della città. In questi ambienti ben diversi da quelli familiari, saturi di fumo e odorosi di vino, tra una partita e l’altra si discorreva anche di antifascismo e persino di comunismo. Il suo primo incarico di partito fu organizzare i giovani, e in poco tempo divenne il punto di riferimento delle nuove leve comuniste sassaresi, mostrando doti organizzative ed intellettuali sorprendenti. La vita politica sassarese e più in generale quella sarda erano però al tempo molto limitate, in una condizione oggettivamente arretrata rispetto al resto del Paese. Quando lasciò l’isola, dopo la parentesi romana, Berlinguer trovò a Milano una realtà antifascista profondamente diversa, nella quale le esperienze sociali e politiche della mobilitazione popolare e quelle della lotta armata al nazifascismo avevano contribuito a formare un corpo di dirigenti e militanti di prim’ordine.
Già dalla metà degli anni Trenta all’interno delle stesse organizzazioni di massa del regime si era formata una fronda giovanile destinata ad avere un ruolo fondamentale nella Resistenza. È una generazione precedente a quella di Berlinguer, giovani nati circa un decennio prima, in gran parte sedotti da alcune parole d’ordine anticapitalistiche del fascismo rivoluzionario, che ben presto scoprono la reale natura sociale del regime e compiono una scelta di opposizione proprio negli anni di maggior consenso per Mussolini, una fase comunque attraversata da un clima di strisciante inquietudine tra un numero sempre maggiore di giovani, educati nella dottrina del fascismo, ma profondamente insoddisfatti delle sue realizzazioni concrete. La sede, dove si forma e ha modo di mettersi in connessione questa fronda, è il luogo dove il regime avrebbe voluto celebrare la sua grandezza e continuità presso le nuove generazioni, i Littoriali della cultura. Sono importanti i nomi che transitano in questo universo Ruggero Zangrandi, Mario Alicata, Renato Guttuso, Antonello Trombadori, Alberto Vigevano, Ernesto Treccani, Pietro Ingrao,Vittorini e tanti altri, tra loro una figura destinata a diventare punto di riferimento per Enrico Berlinguer, e non solo, Eugenio Curiel.
Lo smottamento generazionale nel fascismo fu un processo molecolare, anche se frammentario, di cui non si può indicare un inizio preciso – per alcuni fu il 1935 per altri il ‘38 – nel quale giovani con storie e formazioni diverse entrarono direttamente o indirettamente in contatto con la rete clandestina antifascista o ne subirono il fascino. Si trattava in gran parte di studenti e operai, alcuni di loro non si definivano, né si sentivano, comunisti eppure cercavano il contatto con il partito, altri si proclamavano tali anche senza aver mai avuto nessun tipo di rapporto con l’organizzazione.
Nella storia non sono mancate fratture generazionali, tuttavia, i risultati più profondi in termini di rinnovamento si sono avuti quando tra vecchie e nuove generazioni si è determinata una saldatura incentrata sulle scelte di campo. La lotta di liberazione dal nazifascismo è un esempio in tal senso, proprio per l’irrompere diffuso di giovani cresciuti nel regime che, nella clandestinità, trovarono un terreno d’incontro con i vecchi protagonisti dell’antifascismo sconfitto da Mussolini. Ovviamente questo processo non è lineare, privo di incoerenze e arretramenti, invece, è incredibilmente accidentato, all’interno di una realtà lacerata da profonde divisioni sedimentatesi negli anni come l’antifascismo italiano. La stessa organizzazione cui decide di aderire, il Partito comunista, vive, tra il 1926 e il ’36, scontri furibondi, sconfitte cocenti, epurazioni feroci, ripensamenti traumatici, mutamenti radicali di linea politica[3]. Proprio per la problematicità e i segnali contrastanti di questa vicenda, l’esito positivo del processo di liberazione nazionale dal nazifascismo assume un certo interesse storico[4].
Tra le vecchie generazioni di antifascisti, in gran parte esuli sconfitti anche se non piegati dal fascismo, e questi giovani c’era un salto generazionale, ciò nonostante, negli anni a cavallo tra i Trenta e i Quaranta si determinò una saldatura destinata a costituire la spina dorsale della Resistenza. I leader del vecchio movimento antifascista, costretti all’emigrazione dopo il carcere e le violenze subite, senza l’apporto delle nuove generazioni difficilmente avrebbero potuto dar corso a una tanto vasta mobilitazione contro il movimento di Mussolini. Per certi versi, prima ancora delle leggi razziali, dell’alleanza con la Germania di Hitler e la rovinosa partecipazione alla guerra, le originarie crepe alla stabilità del regime erano da ricercarsi nella perdita di egemonia presso le nuove generazioni. Le nuove leve allevate a “pane e fascismo” e non contaminate dal germe delle ideologie liberali, democratiche o marxiste, quelle su cui il regime tanto aveva puntato e da cui doveva venir fuori «l’uomo nuovo fascista», si rivelarono in definitiva il suo punto debole[5]. Ma al di là dell’aspetto quantitativo, di massa, l’apporto di questa generazione è determinante perché sollecitò il vecchio antifascismo ad abbandonare il suo settarismo, la vocazione romantica e volontarista dell’approccio cospirativo, insomma lo aiutò a superare la sua natura minoritaria, spingendolo a radicarsi nel Paese, tra i giovani e i lavoratori[6]. Il fascismo non si reggeva solo sul dominio violento, esercitava un consenso reale, se s’intendeva rovesciarlo bisognava lavorare anche con quanti erano rimasti sedotti dalle illusioni della demagogia fascista. Nel PCI, ad esempio, la scelta di abbandonare la politica disastrosa del socialfascismo e abbracciare quella dell’unità delle forze democratiche contro il fascismo fu accompagnata e sperimentata anzitutto da questa generazione, impegnata a lavorare nei sindacati fascisti come nei GUF.
Come Tortorella ha chiarito, in un’intervista concessami per la realizzazione di un mio libro dedicato a Eugenio Curiel, a questa generazione si unì quella dei giovani fascisti partiti in guerra che scoprirono proprio al fronte le bugie del regime tanto da decidere, al loro ritorno, di arruolarsi nelle brigate partigiane. Infine ci fu l’ultima generazione, di cui facevano parte Berlinguer e il più giovane Tortorella:
“Non eravamo la generazione del fascismo né quella dell’antifascismo eroico pre guerra, bensì la generazione della Resistenza, ossia, diventammo adulti nella lotta di liberazione trovandoci “impigliati”, volenti o nolenti, nella Resistenza”.
In Sardegna, il peso dell’antifascismo, anche dopo il 25 luglio ‘43, era assai modesto, con limitate capacità di egemonia politica, circoscritto agli ambienti intellettuali delle città e ad alcune ristrette fronde tra i ceti medi. Dopo l’8 settembre prese le mosse una prima rete di coordinamento, il Comitato di concentrazione antifascista, incapace però di andare oltre la ristretta cerchia del vecchio notabilato liberale. Anche l’agonia e il crollo del regime fascista avvennero senza particolari scossoni e nella quasi assenza di qualsiasi forma di mobilitazione popolare. Solo nei primi mesi del ’44, in particolare a Ozieri e, come vedremo, a Sassari, scoppiarono dei moti popolari di un certo rilievo conclusisi con l’assalto agli edifici pubblici e la cacciata dei funzionari amministrativi, ma si trattava di lotte per la sopravvivenza più che consapevole azione antifascista. Diverso era il caso del bacino minerario del Sulcis, attivo sia sul versante politico sia sindacale, dove l’attività antifascista si sviluppò intensamente e con continuità tra il 1944-’45. Nonostante questi limiti, secondo Giovanni Lay, l’attività dei comunisti sardi, per quanto marginale, non si era mai arrestata ed era comunque continuata fino alla caduta del regime, pur nell’assenza di contatti organizzativi stabili. Tra il 1942 e il 43, lo sfollamento di Cagliari aveva portato i militanti comunisti, che lasciavano la città con le famiglie, ad iniziare un’opera di proselitismo nei paesi in cui andavano ad insediarsi. Così, grazie all’opera di piccoli nuclei, già all’indomani dell’arresto di Mussolini si costituirono nei centri agricoli della Sardegna i primi gruppi e in diversi casi le prime sezioni comuniste, tanto che nel tumultuoso post 25 luglio la rete di questi gruppi era riuscita ad organizzare una prima riunione a San Gavino. I mesi che seguirono furono un brulicare di attività che portarono l’organizzazione ad articolare e radicare la sua presenza nei diversi centri dell’isola fino al Convegno regionale del 5 novembre 1943, che sanciva la sua linea di lavoro indicando il piano di collaborazione con gli altri partiti antifascisti. L’isolamento geografico e l’assenza di contatti con la ricostituita direzione nazionale avevano lasciato fuori il PCI sardo dalla «Svolta di Salerno», recepita dai vecchi qudri come un «abile espediente tattico». Gli strascichi di bordighismo, di cui Berlinguer parlò riferendosi alla situazione sassarese, avevano contribuito far sopravvivere un’idea settaria dell’azione comunista, fatta di elementare determinismo economico e intransigente fede rivoluzionaria. In questa dialettica s’inseriva però la novità delle giovani leve, Berlinguer e Renzo Laconi tra tutti[7]. Il 13 gennaio del 1944, scoppiarono a Sassari i moti del pane, per la difficile situazione alimentare in una città assediata dal freddo, fu un inverno particolarmente gelido, e dalla fame, causata da una gestione disastrosa, quando non proprio malavitosa (legata al mercato nero) delle risorse annonarie da parte delle autorità civili e militari. Per due giorni la città fu infiammata da veri e propri moti insurrezionali popolari, scontri con i carabinieri, assalti a Municipio, panifici, pastifici e soprattutto ai depositi delle derrate alimentari. Berlinguer e il gruppo di giovani costituitosi attorno a lui, nonostante la forte contrarietà degli adulti del partito, furono tra i protagonisti di queste vicende.
Intanto a livello nazionale, nell’autunno del 1943, nel partito, si era discusso su quale sarebbe dovuto essere il modo più appropriato per intercettare i giovani, rilanciare la Federazione giovanile comunista oppure creare un organismo unitario della gioventù antifascista?[8] Prevalse questa seconda possibilità, così su indicazione del Centro comunista e grazie all’impegno di Giancarlo Pajetta, a Milano, nel gennaio del 1944, fu creato il Fronte della Gioventù[9]. Non si trattava di un’organizzazione giovanile riservata ai comunisti o ai simpatizzanti, esso nasceva come fronte unitario con lo scopo di raccogliere e valorizzare le energie militanti delle nuove generazioni disposte a lottare contro l’occupazione nazifascista sul terreno militare, nella lotta economica e sindacale, in quella culturale ed educativa. A Pajetta si affiancarono Gillo Pontecorvo, militante nelle file antifasciste dal 1938, e Eugenio Curiel[10]. I primi due lavoravano anzitutto per stabilire rapporti con giovani socialisti, liberali e cattolici, studenti indipendenti. Con l’arrivo di Curiel a Milano, Pajetta passò ad altri incarichi, mentre al primo fu affidata la responsabilità di seguire e dirigere il movimento giovanile. Ai primi di dicembre del 1943 Ingrao, con cui aveva lavorato fino a quel momento, fu mandato dal partito a Roma, allora Gillo Pontecorvo iniziò a lavorare sotto la direzione di Eugenio Curiel, «una delle personalità più straordinarie della Resistenza italiana, il comandante “Barbieri”, colto, audace, coraggioso», di cui di fatto divenne il vice[11]. Curiel affidò al futuro regista il compito di formare un’organizzazione clandestina unitaria con tutti i partiti antifascisti, democristiani e liberali compresi: il Fronte della Gioventù. Pontecorvo ricorda che l’impresa dei due, nei rapporti con i cattolici, fu aiutata dal gruppo di sacerdoti della chiesa di San Carlo al corso, tra i quali David Maria Turoldo e Camillo De Piaz. Dalla costituzione del Fronte si passò, nel febbraio ’44, alla creazione di gruppi armati per la necessità di estendere l’attività dell’organizzazione dal solo terreno politico a quello militare. Fu così creata una prima brigata con la funzione di compiere azioni di disturbo contro fascisti e tedeschi, Pontecorvo, già responsabile politico, ne assunse la direzione.
A Sassari, tre giorni dopo i moti per il pane, Berlinguer venne arrestato e incarcerato nelle prigioni di San Sebastiano. Fu liberato, insieme ai suoi compagni, il 25 aprile del 1944. Proprio in questi mesi Berlinguer decise di abbandonare l’università (la facoltà di giurisprudenza dove si era iscritto nel 1940), per dedicarsi completamente al lavoro politico per il partito. Dopo un primo incontro con Togliatti, favorito dal padre Mario impegnato in prima fila a Salerno, si trasferì a Roma nel settembre del ’44 per andare a lavorare alla direzione comunista accompagnato da un bigliettino vergato personalmente dal “Migliore”, “questo è il compagno Berlinguer, che viene dalla Sardegna, Utilizzatelo nella vostra organizzazione”.
La sua prima mansione fu l’organizzazione sindacale tra i giovani, quindi venne inviato a Milano per prendere il posto di Eugenio Curiel (ucciso dai fascisti il 24 febbraio) a capo dell’organizzazione giovanile. A Milano era presente una forte organizzazione misuratasi nell’attività clandestina, a Berlinguer fu affidato il compito di traghettarla in campo aperto, nell’attività legale del nuovo quadro democratico. Pontecorvo era ora il coinquilino del futuro Segretario del PCI[12], al di là del lavoro politico tra i due nacque un rapporto di amicizia strettissimo durato poi tutta la vita. Per Pontecorvo, Berlinguer era una sorta di rincarnazione del suo amico scomparso, perché avevano molte cose in comune, la serietà, la riservatezza, la passione per lo studio. «Per Curiel Berlinguer provava una vera curiosità. E si faceva raccontare tutto quello che poteva, studiava i suoi rapporti e i suoi documenti»[13]. L’arrivo a Milano di Berlinguer nell’estate del ‘45, in una fase complessa ed esaltante insieme, sembrò, al futuro regista, quasi colmare il vuoto enorme lasciato dalla morte del suo amico. Berlinguer sentiva di averne ereditato il ruolo, avvertiva appieno il peso di quella responsabilità fino a sentirsi persino inadeguato a farne le veci. Dopo la liberazione, Enrico Berlinguer promosse diverse attività – seminari di formazione, pubblicazioni, convegni e iniziative commemorative – con il preciso scopo di restituire al suo predecessore il giusto ruolo nella storia dell’antifascismo e, segnatamente, in quella dei comunisti italiani. Nella direzione milanese Berlinguer trovò anzitutto Luigi Longo, quindi il gruppo di giovani formatisi nel FdG attorno a Curiel, tra questi, oltre al già citato Pontecorvo con cui condivideva una stanza con due brandine, nella sede del Partito in via dei Filodrammatici, un certo Aldo Tortorella.
Al VI Congresso del PCI, tenutosi a Roma nel gennaio del 1946, divenne membro del Comitato Centrale e per Togliatti il giovane dirigente sardo avrebbe dovuto continuare a lavorare alla costruzione dell’organizzazione unitaria dell’antifascismo, estendendola dal Cetro Nord al Mezzogiorno. Così nel settembre 1946 si tenne a Bologna il Congresso nazionale del FdG, fu una triplice prova del fuoco per Berlinguer: 1) sul piano organizzativo, perché fu lui a costruirlo in ogni minimo aspetto; 2) sul piano politico, perché portò alla sua elezione a Segretario generale dell’organizzazione; 3) sul piano della comunicazione, perché concluse il Congresso con il suo primo grande comizio davanti a decine di migliaia di militanti arrivati da tutto il Paese. Il nuovo incarico sancì il suo ritorno a Roma, dove iniziò a lavorare sempre più a stretto contatto con Togliatti. Ma i rapporti sempre più tesi fra i Partiti che avevano dato vita al CLN, fino alla cacciata di comunisti e socialisti dal governo dopo il viaggio negli USA di De Gasperi, nel maggio del 1947, decretarono la fine del Fronte unitario giovanile. In realtà già a inizio anno, alla conferenza di organizzazione del partito a Firenze, Berlinguer aveva avanzato la necessità di affiancare il Fronte con un’organizzazione autonoma dei Giovani Comunisti.
Nel clima infuocato, interno e internazionale, che precedette le elezioni del 18 aprile ’48, nacquero, su idea di Luigi Longo, le «avanguardie garibaldine», organizzazione giovanili unitarie di socialisti e comunisti, che anche nel nome si richiamavano alla tradizione partigiana, a migliaia si riunirono in Congresso al Salone Ansaldo di Genova l’8 di febbraio. Due anni dopo, il 2 aprile 1950, veniva ricostituita, non casualmente a Livorno, la Federazione giovanile comunista, dopo che il CC del Partito aveva già deliberato in tal senso nel marzo del 1949. Nel mentre era successo di tutto, la sconfitta cocente alle elezioni politiche, l’attentato a Togliatti, uno sciopero generale spontaneo dilagato in moto insurrezionale in diverse parti del Paese a fatica fatto rientrare nei ranghi da un Togliatti scampato alla morte. Proprio lo stesso Togliatti, oramai completamente ristabilitosi, consegnò simbolicamente la bandiera rossa con la stella al centro e la sigla FGCI a Berlinguer, eletto segretario dell’organizzazione. La FGCI divenne «un partito nel partito», che in poco tempo raddoppiò i suoi iscritti fino a raggiungere e superare le 400 mila unità, un’organizzazione molto articolata (scuole quadri, associazioni sportive, ludiche culturali), coccolata, controllata e persino contesa da tre personalità piuttosto ingombranti, Togliatti, Secchia e Longo, ognuno dei quali con una sua idea particolare di cosa dovesse essere la federazione giovanile. Coerentemente con l’impostazione data da Togliatti al lavoro del Partito, il giovane Berlinguer concepiva in termini organici le tematiche della lotta al fascismo e quelli della ricostruzione democratica attraverso la stagione costituente[14]. Il punto d’intesa tra questi due momenti era l’idea della democrazia progressiva tanto cara al suo predecessore Curiel, ossia la prospettiva di un permanente allargamento degli spazi di democrazia economica, sociale e politica, tali da consentire al mondo del lavoro di conquistare posizioni di forza, in un processo di transizione democratica al socialismo. Bisognava rimuovere le radici economico sociali del fascismo, ossia la natura monopolistica di un certo suo capitalismo, il parassitismo oligarchico, causa congenita del sovversivismo reazionario di parte significativa delle sue classi dirigenti. Per raggiungere questo obiettivo, così come per quello precedente della liberazione dell’occupazione nazifascista, era essenziale trovare un’intesa unitaria con le altre forze popolari del Paese, non solo i socialisti ma anche e soprattutto le masse cattoliche. Al di là di miti e leggende sulla presunta “doppiezza togliattiana”, nella scelta operata con la svolta di salerno nel 1944, e in quelle successive, fino all’approvazione della Costituzione non c’era alcun espediente tattico, si trattava di scelte strategiche conseguenti alla ricerca di una via italiana al socialismo scaturite dalle specificità storiche, culturali e sociali della concreta realtà italiana[15]. Era un’anticipazione convinta del tema del policentrismo, poi sviluppato un decennio dopo da Togliatti. In tutto questo, il lavoro di Berlinguer a capo dell’organizzazione giovanile fu pienamente conseguente, senza esitazioni, nonostante i perturbamenti provocati da una fase storica, oramai dominata dal clima della guerra fredda, ricca di contraddizioni e fasi di arretramento. All’interno di questo universo, Enrico Berlinguer, entrato nel gennaio del 1948 nella ristretta e prestigiosa Direzione Nazionale, sebbene non avesse un Curriculum rivoluzionario paragonabile agli eroi della Resistenza, fosse schivo per natura, e evitasse in qualsiasi modo pose teatrali da capo carismatico, divenne la guida indiscussa e quasi idolatrata dei giovani comunisti. Sia chiaro, non fu una marcia trionfale, al contrario non tardrano a manifestarsi molteplici contraddizioni, soprattutto a partire dal 1956, con profonde ripercussioni sull’organizzazione uscita da quella profonda crisi ridimensionata per effettivi, peso e capacità di influenza.
* * *
A questa storia e quegli ideali giovanili di integrale emancipazione umana Berlinguer rimase fedele anche negli anni della maturità, senza mai prendere in considerazione l’ipotesi, poi materializzatasi dopo la sua morte, di liquidare o trasformare in altra cosa il PCI. Ciò nonostante, in vita e ancora più dopo la sua morte, attorno alla figura di Berlinguer le polemiche non sono mai cessate. Si può discutere a lungo se il ragionamento sulla “fine della spinta propulsiva della Rivoluzione d’ottobre” (e il conseguente distanziamento dall’URSS) fu o meno un errore strategico. È legittimo mettere in discussione la prospettiva del blocco di unità nazionale, per il cui successo mancavano le basi politiche, viste le ambiguità del PSI e le zone d’ombra nel principale partito di governo. Tuttavia, la direzione di Berlinguer rappresentò l’ultimo tentativo di rilanciare la questione comunista in Occidente con basi e prospettive di massa. Sicuramente il PCI fece diversi errori, tuttavia, Berlinguer comprese le prospettive di involuzione autoritaria e di riflusso democratico (il discorso sull’austerità e sulla necessità non solo di un diverso modello di sviluppo, ma di una civiltà su basi antropologicamente diverse, rientrava in questa preoccupazione). Al contrario, molti dei gruppi alla sua sinistra consideravano quella fase oggettivamente e soggettivamente rivoluzionaria, non la vigilia del riflusso, individuando nel PCI il principale ostacolo alla liberazione di nuove soggettività di classe e rivoluzionarie. Tutti quelli che lo hanno frequentato sanno perfettamente quanto Berlinguer vivesse con tormento il rischio di una svolta cilena nell’Italia della metà degli anni Settanta, e tutti quanti sappiamo come queste preoccupazioni fossero tutt’altro che campate in area. In quegli anni Berlinguer sollevò il problema del valore universale della democrazia non solo per polemizzare con la sottovalutazione sovietica di questo tema, ma anche per richiamare il quadro dell’arco costituzionale ai valori dell’antifascismo in una fase marcata dalla strategia della tensione e dai molteplici rischi di Golpe autoritari. Sicuramente sbagliò tanto sul piano dell’analisi quanto su quello della proposta politica, riconoscendolo qualche anno dopo, ma sbagliarono ancora di più quei gruppi convinti di essere alla vigilia della rivoluzione che non compresero l’importanza del PCI, in grado di inquadrare milioni di lavoratori e con una capacità di azione che nessun altro partito comunista in Occidente poteva vantare. Berlinguer ci rimanda a un’esperienza e a un tempo nel quale si guardava all’Italia come originale laboratorio politico, non solo per la presenza del più grande partito comunista dell’Occidente, in un Paese chiave per gli equilibri del Patto Atlantico, ma anche per il tentativo di rilancio sia dei suoi presupposti teorici, sia delle sue prospettive politiche in una fase di crisi del movimento a livello internazionale, soprattutto per le contraddizioni interne alla sua nazione guida. In una fase tanto drammatica Berlinguer trovò contro una parte consistente del suo partito, quella che poi prevalse, le diverse e litigiose anime del composito movimento antagonista e extraparlamentare, gli intellettuali che iniziavano a contrapporre il partito in quanto tale alla “società civile”, individuando proprio nel PCI il principale ostacolo al rinnovamento della sinistra. Tutte queste componenti, a partire da punti di vista differenti e con prospettive antitetiche, avevano un minimo comun denominatore, condiviso anche dalle ambizioni di cannibalismo politico di Bettino Craxi: la convinzione che con la fine del PCI si sarebbe superata un’anomalia che avrebbe spalancato le porte alla palingenesi (socialdemocratica, radicale o di classe) della sinistra italiana. Al contrario, dal funerale del PCI non si è determinata né la nascita di un serio e credibile partito di ispirazione socialdemocratica, né un movimento radicale e di classe capace di aprire al mondo del lavoro un nuovo terreno di lotte e conquiste. Al contrario l’Italia ha oggi la sinistra più marginale e priva di credibilità in Europa che di quegli anni ha però conservato una prerogativa: la litigiosità.
Nonostante la lezione della storia, a tanti anni di distanza, ancora non si riesce a sfuggire da quei vecchi posizionamenti, così le esigenze celebrative e politicamente neutralizzanti di quanti ne rinnegarono l’eredità politica convergono con quelle di coloro che individuano in Berlinguer il principale responsabile della fine del PCI, producendo atteggiamenti (speculari e perfettamente complementari) agiografici o liquidatori. Entrambe queste visioni sorvolano sulle contraddizioni storiche e politiche che inevitabilmente hanno reso accidentata e complessa una biografia politica e umana che comunque, dalla gioventù al drammatico comizio di Padova, rimane legata indissolubilmente, senza conversioni o rinnegamenti, alla storia del comunismo italiano. Piaccia o non piaccia, nell’immaginario collettivo della maggioranza degli italiani Berlinguer è ricordato non come un “uomo buono” o un banale riformista, ma come l’ultimo grande comunista del nostro Paese.
Gillo Pontecorvo ebbe a ricordare un aneddoto che racchiude bene la personalità di Enrico Berlinguer con la quale concludiamo questa riflessione. In una delle tante giornate milanesi, successive alla liberazione, un giornalista recatosi a intervistare il futuro regista, si voltò dall’altra parte della stanza e fece una domanda al giovane e ancora sconosciuto Berlinguer: «e lei?, da quanto è in politica?», Berlinguer sollevò la testa, sottraendosi alla lettura in cui era immerso, e lapidario rispose: «io non sono in politica, io sono comunista»[16].
[1] G. Fiori, Vita di Enrico Berlinguer, Laterza, Roma-Bari, 1989.
[2] C. Valentini, Berlinguer. L’eredità difficile, Editori Riuniti, Roma, 2007.
[3] P. Spriano, Storia del Partito comunista italiano. Gli anni della clandestinità, vol. II, Einaudi, Torino, 1969.
[4] P. Togliatti, Discorsi ai giovan, prefazione di E. Berlinguer, Editori riuniti, Roma, 1971.
[5] Ruggero Zangrandi, Il lungo viaggio attraverso il fascismo. Contributo alla storia di una generazione, Feltrinelli, Milano, 1976.
[6] P. Secchia, Lotta antifascista e giovani generazioni, La Pietra, Milano, 1973.
[7] P. Spriano, Storia del Partito comunista italiano. I fronti popolari, Stalin, la guerra. Vol. III, Einaudi, Torino, 1970.
[8] L. Longo, I centri dirigenti del PCI nella Resistenza, Editori Riuniti, Roma, 1977.
[9] P. Secchia, Il Partito comunista italiano e la guerra di liberazione nazionale (1943-1945), Annali Feltrinelli, anno tredicesimo, 1971, Milano.
[10] P. De Lazzari, Storia del Fronte della gioventù, Editori Riuniti, Roma, 1974.
[11] I. Bignardi, Memorie estorte a uno smemorato. Vita di Gillo Pontecorvo, Feltrinelli, Milano, 1999, pag. 47.
[12] «Hanno dato ad Enrico, un alloggio di emergenza: una brandina in uno stanzone scuro e spoglio della Direzione comunista per l’alta Italia, che ha sede in un vecchio palazzo d’abitazioni di via dei Filodrammatici, dietro la Scala. Poco distante, in via del Conservatorio 9, a due passi da San Babila, è la palazzina dell’ex Gil, che il 27 aprile 1945 le Brigate giovanili hanno occupato per metterci il Fronte della Gioventù», G. Fiori, Vita di Enrico Berlinguer, Laterza, Roma -Bari, 1989, pag. 59.
[13] I. Bignardi, Memorie estorte a uno smemorato. Vita di Gillo Pontecorvo, op. cit., pag. 64.
[14] «Critica Marxista», Gli anni di Berlinguer, n. 2-3, marzo giugno 1985, anno 23, Editori Riuniti, Roma.
[15] D. Sassoon, Togliatti e la via italiana al socialismo. Il Pci dal 1944 al 1964,Einaudi, Torino, 1980.
[16] I Bignardi, Memorie estorte a uno smemorato, Vita di Gillo Pontecorvo, Feltrinelli, Milano, 1999, pag. 64.