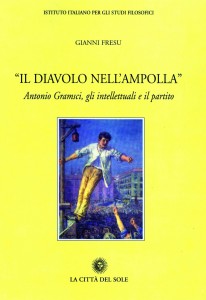ALTHUSSER:
LA “FILOSOFIA DELL’UOMO” E LA “DEVIAZIONE STALINIANA”.
Di Gianni Fresu
Il dibattito, scatenatosi dopo il 1956, a seguito del XX Congresso del PCUS, relativo all’emergere di nuove categorie concettuali quali l’”umanesimo socialista” e il cosiddetto “culto della personalità” ha sicuramente rappresentato, uno dei momenti più controversi e complessi nella storia del movimento operaio del secolo appena concluso, ed ha prodotto lacerazioni tanto profonde da poter essere paragonabile, per gli effetti che esso ha prodotto, alla votazione dei crediti di guerra da parte dei principali partiti della seconda internazionale nel 1914. All’interno di questo dibattito ci pare utile soffermarci sulle riflessioni in merito sviluppate da Louis Althusser che con estrema lucidità e spirito critico ha saputo cogliere l’inadeguatezza sul piano teorico delle “denuncie” contenute nel rapporto segreto e nelle speculazioni che ne sono scaturite, indicando come dall’abbandono dei canoni analitici marxisti e dall’utilizzo di categorie ad esso estranee si avviasse una discussione su un piano inclinato gravida di conseguenze negative per il movimento comunista internazionale. Per Althusser infatti i presupposti di queste denunce e le finalità ideologiche più che teoriche di queste1, per quanto determinate da una reale esigenza storica, oltre a non fornire alcun criterio conoscitivo utile che consentisse di portar luce sui fenomeni che intendeva indagare, oltre a non essere in grado di superare gli “abusi” che intendeva denunciare, fornirono armi ulteriori all’arsenale dell’anticomunismo di maniera e al revisionismo storico e produssero tra numerosi e autorevoli intellettuali marxisti una certa subalternità ideologica ai temi dell’idealismo borghese di cui ancora oggi si avverte il condizionamento all’interno di quelle stesse forze della sinistra radicale e antagonista che in un modo o nell’altro continuano a richiamarsi a Marx.

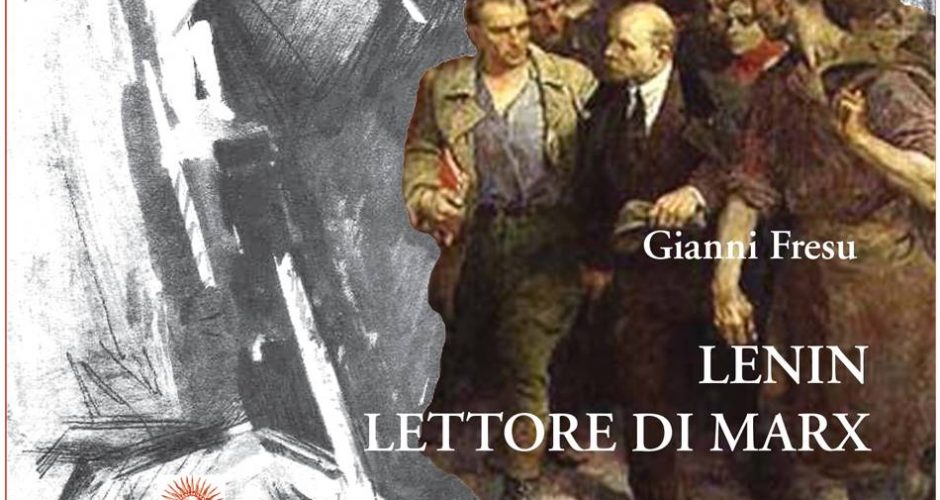
 alisi ampia e dettagliata. Nucleo centrale del suo lavoro, infatti, è determinare il più chiaramente possibile le complesse e varie posizioni del socialismo assunte innanzi ai drammatici eventi nati prima e dopo la Rivoluzione d’Ottobre. In un contesto internazionale angosciante, con una guerra mondiale alle porte, la caduta dello Zar, la vecchia Europa scossa e frastornata, è innegabile che il movimento socialista dovette fare scelte tattiche difficilissime, pena la sconfitta su tutti i fronti. Fresu comincia la sua analisi partendo da questo quadro generale e analizza le posizioni revisioniste di Bernstein o di Kautsky, imputando loro sostanzialmente di contenere in sé ancora un certo idealismo borghese o una mancata comprensione del marxismo. Molto chiara per esempio è la dimostrazione della confusione di Kautsky a proposito dei concetti di capitale finanziario ed industriale, la quale in definitiva lo spinge su posizioni interventiste e quindi ad evidenziare quanto un limite teorico possa incidere sulla sfera politica. La disamina ovviamente è complessa ed avvincente, poiché si avvale di un gran numero di documenti, nonché dei testi di Marx medesimo, ed è preferibile rimandare il lettore ad un diretto confronto con i testi per non concedere troppo a eccessive semplificazioni. Da sottolineare invece l’abilità stilistica dello scrittore e la vocazione sistematica, a tratti didattica, capaci di render l’opera facilmente comprensibile e mai pedante: Fresu coglie nell’essenza le incongruenze del pensiero revisionista o di chi dall’ortodossia passò in seguito a posizioni più moderate, perché sa leggere nella realtà le deviazioni e le sconfitte che queste interpretazioni portarono.
alisi ampia e dettagliata. Nucleo centrale del suo lavoro, infatti, è determinare il più chiaramente possibile le complesse e varie posizioni del socialismo assunte innanzi ai drammatici eventi nati prima e dopo la Rivoluzione d’Ottobre. In un contesto internazionale angosciante, con una guerra mondiale alle porte, la caduta dello Zar, la vecchia Europa scossa e frastornata, è innegabile che il movimento socialista dovette fare scelte tattiche difficilissime, pena la sconfitta su tutti i fronti. Fresu comincia la sua analisi partendo da questo quadro generale e analizza le posizioni revisioniste di Bernstein o di Kautsky, imputando loro sostanzialmente di contenere in sé ancora un certo idealismo borghese o una mancata comprensione del marxismo. Molto chiara per esempio è la dimostrazione della confusione di Kautsky a proposito dei concetti di capitale finanziario ed industriale, la quale in definitiva lo spinge su posizioni interventiste e quindi ad evidenziare quanto un limite teorico possa incidere sulla sfera politica. La disamina ovviamente è complessa ed avvincente, poiché si avvale di un gran numero di documenti, nonché dei testi di Marx medesimo, ed è preferibile rimandare il lettore ad un diretto confronto con i testi per non concedere troppo a eccessive semplificazioni. Da sottolineare invece l’abilità stilistica dello scrittore e la vocazione sistematica, a tratti didattica, capaci di render l’opera facilmente comprensibile e mai pedante: Fresu coglie nell’essenza le incongruenze del pensiero revisionista o di chi dall’ortodossia passò in seguito a posizioni più moderate, perché sa leggere nella realtà le deviazioni e le sconfitte che queste interpretazioni portarono.