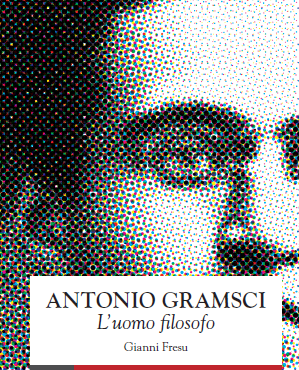LA “SINISTRA CRITICA” E LE NUOVE UTOPIE SOCIALI
Gianni Fresu
Come giustamente ha fatto notare Salvatore D’Albergo nel suo intervento, mi pare sufficientemente logico affermare che i fatti di cui siamo testimoni in questi tempi si prestino in maniera efficace nel fare piazza pulita di tante tesi fallaci e pretenziose – sviluppatesi nell’ambito di una parte della sedicente “sinistra critica” e “no-global” – che nel migliore dei casi si rivelano essere niente altro che la scoperta dell’acqua calda o la riproposizione di paradigmi interpretativi, oltre che modelli d’azione, pre-marxisti, che hanno per giunta l’ardire di porsi incontestabilmente come “il nuovo”. Paradigmi che alla contrapposizione dialettica tra capitale e lavoro, sostituiscono un non ben definito fronte dei diseredati contrapposto a multinazionali e organismi sovranazionali, che alla lotta di classe preferiscono appelli <<ad una grande alleanza degli esclusi del pianeta>>; paradigmi che al di là del loro fascino esteriore rivelano una inconfondibile impronta moralistica ma soprattutto la volontà di disfarsi dell’ingombrante fardello teorico-pratico rappresentato dal marxismo. In questo senso l’individuazione dell’alternativa tra leninismo e populismo e la sua attualizzazione concettuale, colgono bene la natura del dibattito di cui qui ci occupiamo. Nell’affrontarlo, in via preliminare, mi pare utile ripartire dal Manifesto, dal capitolo nel quale Marx si fa beffe della filantropia umanitaria dei vari <<dettaglianti delle riforme>>, dalla variopinta schiera di inventori di nuove scienze sociali, che pur riconoscendo una qualche forma di antagonismo tra le classi, negano al proletariato “alcun movimento che gli sia proprio”. Per questi, “in luogo dell’attività sociale deve subentrare la loro personale azione inventiva; in luogo delle condizioni storiche dell’emancipazione, condizioni immaginarie; e in luogo dell’organizzazione graduale del proletariato in classe, un’organizzazione della società escogitata per l’occasione. La futura storia universale si risolve nella propaganda e nella esecuzione pratica dei loro piani sociali”1.
Gli snodi fondamentali di questa nuova precettistica “rivoluzionaria”, sono rintracciabili nella scoperta di un mondo completamente nuovo chiamato globalizzazione, all’interno del quale si afferma la fine dello stato-nazione e il conseguente superamento della categoria imperialistica, la fine della centralità del lavoro subordinato e il conseguente superamento del conflitto tra capitale e lavoro, l’edificazione di nuovi <<falansteri>>, come ad esempio il terzo settore, attraverso i quali giungere al superamento delle contraddizioni capitalistiche, così come queste vengono rappresentate nell’attuale fase.
Per quanto riguarda il primo punto, va anzitutto detto che quel fenomeno definito globalizzazione o mondializzazione non è certo un’acquisizione recente, ma bensì una tendenza che ha attraversato in profondità tutta la fase di espansione legata alla rivoluzione industriale ed anche, in forme diverse, quelle precedenti.
Già nel Manifesto Marx e Engels parlano del processo che da un’impronta cosmopolita alla produzione e al consumo mondiale, che priva l’industria della sua base nazionale, che porta questa a lavorare materie prime provenienti dalle parti più disparate del pianeta. Marx descrive con estrema linearità anche il determinarsi di nuovi bisogni dati dall’interdipendenza che si viene a creare nel nuovo mercato mondiale, interdipendenza che non riguarda solo le merci ma anche la produzione immateriale, la cultura, e così, “dalle letterature nazionali e locali si sviluppa una letteratura mondiale”. Ma è soprattutto la valutazione relativa alla universalizzazione del modo di produzione e distribuzione borghese a mostrare in che misura ciò che viene spacciato come assoluta novità in realtà non lo sia. “ Col rapido miglioramento di tutti gli strumenti di produzione, con le comunicazioni rese infinitamente più agevoli, la borghesia trascina nella civiltà tutte le nazioni più barbare. I bassi prezzi delle sue merci sono l’artiglieria pesante con cui essa abbatte tutte le muraglie cinesi e con cui costringe alla capitolazione la più ostinata xenofobia dei barbari. Essa costringe tutte le nazioni ad adottare il sistema di produzione della borghesia, se non vogliono andare in rovina, le costringe a introdurre nei loro paesi la cosidetta civiltà, cioè a diventare borghesi. In una parola, essa si crea un mondo a propria immagine e somiglianza” 2.
Tra i vari <<guru no-global>>, che con tanta pervicacia si ostinano a raccontarci che nulla è più come prima, Toni Negri merita sicuramente un postò d’onore. Nel suo recente libro Empire, scritto con Michael Hardt, la globalizzazione è descritta come un <<processo definitivo e irreversibile>>, attraverso il quale il modo di produzione capitalistico si riforma per l’impossibilità di sopravvivere con le vecchie forme. In esso i processi di concentrazione e centralizzazione capitalistica, assumendo un carattere transnazionale – dal punto di vista della composizione della proprietà, della distribuzione territoriale dei processi produttivi, delle transazioni finanziarie – minerebbero in maniera irreversibile le strutture delle economie nazionali, fino ad annullare quindi gran parte delle funzioni proprie dello Stato-nazione. Tra le caratteristiche più peculiari di questo processo, ci sarebbe pertanto lo slittamento della sovranità degli Stati verso una nuova realtà definita <<Impero>>. In essa il ruolo protagonistico sarebbe svolto dagli organismi sovranazionali, che non solo avrebbero decretato il superamento del ruolo dello Stato-nazione, ma avrebbero addirittura determinato un’ attenuazione del ruolo egemonico degli USA. Ora proprio la natura del conflitto in Afganistan, come è stato ampiamente illustrato nei precedenti interventi, dimostra appieno quanto poco questa affermazione possa essere sottoscritta, e quanto ancora meno lo possa essere la successiva, quella per la quale non sarebbe più possibile parlare di imperialismo, ma bisognerebbe semmai fare riferimento ad una nuova realtà, appunto quella imperiale, totalmente sganciata da un’ origine e dimensione nazionale.
Teorie come queste mostrano una totale subalternità ideologica, perché oltre ad accettare in maniera neutra e quasi naturalistica l’idea della globalizzazione, così come questa ci viene rappresentata dalle classi dominanti – cioè l’idea che la globalizzazione dei capitali e delle relazioni economiche non avendo più una radice nazionale avrebbe uno sviluppo eterodiretto, quasi una democratizzazione territoriale di questo – accettano anche la presunta rappresentazione a-nazionale di organismi come il Fondo Monetario o la Banca Mondiale, accontentandosi della facciata che di questi ci viene presentata per nasconderne la reale natura. È sempre più chiaro infatti che questi organismi non solo non hanno alcuna indipendenza dalle grandi potenze (USA, UE, Giappone) e quindi dalle loro economie nazionali, ma ne sono la loro diretta emanazione. Gli organismi sovranazionali infatti, non sono altro che camere di compensazione nelle quali si mediano gli interessi spartitori delle grandi potenze, all’interno delle quali – come fa notare giustamente anche Gregorio Piccin – il potere è direttamente proporzionale alla grandezza economico-militare di queste. E così come è illusoria l’idea degli organismi sovranazionali, altrettanto illusoria e l’idea per la quale è la natura transnazionale delle imprese – che avrebbe soppiantato gli interessi dell’economia nazionale – ad aver portato alla progressiva perdita di ruolo degli Stati nazionali, dato che, al di là della dislocazione produttiva, che comunque non è certo un fenomeno nuovo, la natura di queste è totalmente nazionale per quanto riguarda proprietà di mezzi di produzione e profitti, la direzione e le strategie perseguite, così come del resto i giri di affari, che per la più gran parte sono interni alle aree di origine di queste. Si dovrebbe anzi dire il contrario di quanto viene affermato, e cioè che proprio la dislocazione produttiva negli angoli più remoti del pianeta accresce il ruolo dello Stato-nazione, che si pone come il nume tutelare, politico-militare, di queste imprese, e che proprio gli interessi rappresentati dalle imprese transnazionali, non eliminano ma esaltano il ruolo imperialistico degli Stati-Nazione. Per quanto riguarda poi la finanziarizzazione dell’economia, questa ha accompagnato – non certo ostacolato – l’evoluzione del modo di produzione capitalistico in senso imperialistico, e questo a partire almeno dalla prima grande depressione economica tra il 1870 e il 1890, anzi la finanziarizzazione dell’economia è una delle condizioni essenziali perché possano determinarsi le tendenze di concentrazione monopolistica proprie dell’imperialismo.
E così, nei fatti – nonostante le varie argomentazioni fantasiose e arzigogolate – la “sinistra critica” non è riuscita con le sue tesi a dimostrare l’inattualità di nessuno dei punti fondamentali propri dell’elaborazione leniniana dell’imperialismo: la concentrazione e centralizzazione di capitali verso tendenze monopolistiche, con cui ristretti gruppi – tramite il sistema delle holdings e delle società a catena – controllano interi settori produttivi; la prevalenza del capitale finanziario sulla produzione, come risultato dello stretto intreccio tra capitale bancario e industriale; il prevalere delle esportazioni di capitali rispetto a quella delle merci – e legata a questa la ricerca di aree da assoggettare attraverso lo sfruttamento a basso costo della mano d’opera e l’accaparramento delle materie prime – come risposta alla caduta tendenziale del saggio di profitto; la conseguente spartizione del mondo per aree di influenza e dominio; l’utilizzo della guerra come strumento per ottenere ulteriori spartizioni e con esse la fuoriuscita dalla stagnazione economica.
L’altro passaggio nodale nei paradigmi della “sinistra critica”, come già accennato, è rappresentato dall’idea che il lavoro subordinato non costituirebbe più l’ambito proprio dell’antagonismo sociale, per la semplice ragione che esso – a seguito dell’avvenuta automazione dei processi produttivi e del sorgere delle nuove forme dell’economia virtuale – tenderebbe a scomparire, ad essere oramai residuale. In ragione di ciò, in ultima analisi, si arriva ad affermare il superamento della forma classica del conflitto tra capitale e lavoro, e la possibilità di combattere il capitalismo attraverso “nuove” forme auto-organizzate di associazione, all’interno, <<ma al di fuori>>, delle leggi del mercato capitalistico. L’idea cioè che l’orizzonte dell’antagonismo sociale debba esprimersi, non più nelle <<vecchie>> forme della lotta dei lavoratori ma bensì, attraverso il “no profit”, il terzo settore.
Anche in questo caso i “teorici” della “sinistra critica” sembrano fermarsi alla facciata, alla rappresentazione mistificata della realtà, quasi come un turista che imbattendosi in qualche set di Cinecittà finisce per convincersi di trovarsi a Venezia o chissà dove. Ancora una volta i teorici della “sinistra critica” non sanno andare oltre la <<falsa coscienza>> propria dell’ideologia borghese.
Così, aderendo alle rappresentazioni proprie delle classi dominanti, e derubricando il conflitto tra capitale e lavoro, questi forniscono un grande servigio agli interessi borghesi, e non è certo un caso che tutti, dalla Confindustria, ai tanto avversati organismi sovranazionali, mostrano grande interesse nei confronti del “terzo settore”, del “no profit”, tanto che quegli stessi organismi che, da un lato affamano tre quarti di mondo con gli interessi sui prestiti, contemporaneamente finanziano a piene mani le ONG.
Sono gli stessi dati a dimostrare che il lavoro subordinato non solo non diminuisce ma aumenta esponenzialmente e che mai nella storia come oggi, lo stesso lavoro operaio è presente in tutte le latitudini del pianeta. Anche rispetto al cosiddetto lavoro autonomo non si va al di là della superficie, perché se così fosse si vedrebbe, ad esempio, che dietro il <<popolo delle partite IVA>> si nasconde un lavoro che solo formalmente può dirsi autonomo e che nella realtà è totalmente subordinato alle decisioni della <<casa madre>>, che unilateralmente decide se, come e quando lavorare. E sono ancora gli stessi indicatori economici a dirci che il saggio di profitto continua a basarsi sul pluslavoro, sull’appropriazione padronale di lavoro non pagato.
Dunque la “sinistra critica” si fa portatrice di un’ideologia che si basa su un forte regresso sul piano analitico e che conseguentemente rappresenta un forte regresso anche dal punto di vista della strategie d’azione perseguite, ma soprattutto nell’illusione che sia possibile trovare una fuoriuscita dal modo di produzione capitalistico, all’interno dello stesso modo di produzione, attraverso la creazione di <<isole>>, di nuove comunità di <<New armony>>, di nuovi <<falansteri>>, che per la sola ragione di rifiutare le regole della produzione e riproduzione capitalistica hanno la presunzione di superarle standone all’interno.
Per questo, come già accennato in apertura, il capitolo sul socialismo utopistico del Manifesto si presta ancora perfettamente a liquidare la pretenziosità di simili affermazioni, e per questo non vedo conclusione più appropriata a questo intervento delle stesse parole di Marx e Engels, tenendo però ben presente la differenza di statura politica e intellettuale tra i signori a cui fa questi fanno riferimento e i vari cantastorie della sedicente “sinistra critica” : “le loro affermazioni positive sulla società futura(…) il loro annuncio dell’armonia sociale, dell’amministrazione dello Stato in una semplice amministrazione della produzione – tutte queste affermazioni esprimono soltanto la scomparsa dell’antagonismo di classe(…) Continuano a sognare la realizzazione delle loro utopie sociali, sperimentando qua e là: formazione di singoli falansteri, fondazione di colonie in patria, edificazione di una piccola Icaria – edizione in dodicesimo della Nuova Gerusalemme – e per la costruzione di tutti questi strani castelli in aria si appellano alla filantropia dei cuori e dei borsellini borghesi. A poco a poco finiscono per cadere nella categoria dei socialisti reazionari o conservatori e si distinguono da questi soltanto per la pedanteria più sistematica, per la fede fanatica e superstiziosa nelle virtù miracolose della loro scienza sociale.
Si oppongono quindi aspramente a ogni movimento politico degli operai, che secondo loro può scaturire soltanto da cieca miscredenza nel nuovo vangelo” 3.
1 Marx Engels, Il manifesto del partito comunista, Editori Laterza p.50
2 Ibid. p. 11
3 Ibid, p.52-53