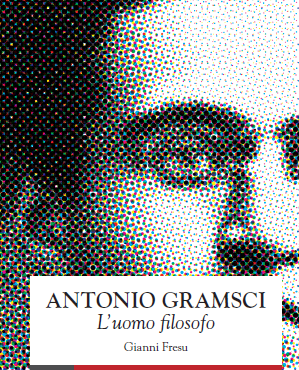“2001 Odissea nel Contratto”
Gianni Fresu
Il tema della politica dei redditi è assolutamente centrale tra le grandi emergenze del paese, ciò nonostante esso è pressoché assente dai grandi argomenti della politica italiana (tanto nel centro destra quanto nel centro sinistra). Eppure è sempre più evidente, la questione salariale è una delle più sentite dall’opinione pubblica, perché il progressivo ridursi del potere d’acquisto nel corso degli ultimi quindici anni è talmente palese e incontrovertibile da non poter essere misconosciuto da nessuno. Malgrado questo, le disastrose politiche dei redditi avviate negli anni Novanta e attualmente perseguite continuano ad essere rivendicate e riproposte con testarda protervia dalle forze moderate o conservatrici di entrambi i poli.
Sono le nude cifre a dimostrare l’insostenibilità dell’attuale condizione di ripartizione della ricchezza prodotta tra profitti e salari. Nel decennio 1993 – 2003 il 3% del PIL è passato dal monte salari ai profitti delle imprese. I dati resi noti nella primavera 2004 dall’Osservatorio dell’industria metalmeccanica della FIOM CGIL, ci parlano di una perdita netta per gli operai di questo settore del 5,8% negli ultimi dieci anni, questo significa che su un salario medio di mille euro, ne mancano circa 60, vale a dire 800 euro l’anno. E la perdita del potere d’acquisto è ancora maggiore con l’abbassarsi del reddito, variando tra il 7% e il 14% per i redditi tra i 10 e i 30 mila euro.
Dal 2004 ad oggi la situazione è ulteriormente peggiorata, al punto che si è determinato un drammatico innalzamento della soglia di povertà tanto da coinvolgere nuovamente – cosa che non accadeva dal dopoguerra – fasce sempre più importanti di lavoro dipendente. Secondo i dati sulla povertà calcolati sui consumi medi, resi noti dall’ISTAT nell’ottobre 2005, ben 2,6 milioni di famiglie risultano al di sotto della soglia di povertà vale a dire l’11,7% della popolazione rispetto al 10,8% dell’anno precedente. Povertà che dilaga tra giovani, anziani e donne specie nel Sud Italia dove una famiglia su quattro vive al di sotto di questa soglia e dove il 25% delle famiglie è nella cosiddetta fascia delle famiglie “relativamente povere”.
La situazione non è minimamente mutata con il governo di centro sinistra, a conferma del fatto che le politiche di rigore monetario e la scelta di puntare tutto sul cuneo fiscale hanno avvantaggiato ancora il capitale e non certo il lavoro.
Secondo i dati dell’Eurispes per il 2007 la crescita europea dei salari tra il 2000 e il 2005 si è attestata intorno ad un valore medio del 18%. I salari italiani sono cresciuti molto al di sotto della media europea tanto da non raggiungere neanche il 14%. Nell’ UE i soli paesi che hanno registrato dati di crescita inferiori all’Italia sono la Germania e la Svezia, cioè due paesi dove le retribuzioni sono nettamente superiori rispetto al resto d’Europa (il salario medio netto di un lavoratore italiano è di 16.242 euro contro i 21.235 di un corrispondente in Germania). Ma questi dati in Italia sono ulteriormente aggravati dall’aumento del costo della vita, nettamente superiore in Italia rispetto al resto d’Europa.
Proprio nelle settimane scorse (esattamente il 19 novembre) l’IRES CGIL ha diramato gli ultimi dati (vedi grafico a fine testo) che confermano questo quadro a tinte fosche. Secondo essi, proprio a causa della forbice tra inflazione programmata e inflazione reale, del mancato rinnovo dei contratti e della mancata restituzione del fiscal drag1 (686 euro in cinque anni), ogni lavoratore dipendente con un reddito di 24.890 euro ha perso circa 1.896 euro in busta paga.
Sempre a conferma di quanto già detto, secondo questi ultimi dati il «reddito disponibile familiare», cioè il potere d’acquisto delle famiglie, negli ultimi cinque anni ha fatto registrare una perdita secca di 2.600 euro nelle famiglie legate ad un lavoro dipendente a fronte di un guadagno di 12.000 euro per quelle di professionisti e imprenditori.Questi dati, che per certi versi sembrano un po’ la scoperta dell’acqua calda, in realtà danno aritmetica conferma a quanto andiamo dicendo da tempo:
14 milioni di lavoratori che guadagnano meno di 1.300 euro al mese; 7,3 milioni che ne guadagnano meno di 1.000, con una ripartizione territoriale che ripropone drammaticamente anche sul versante salariale la Questione meridionale. Tra le fasce della “risorsa lavoro atipico”, che stanno monopolizzando i rapporti contrattuali delle giovani generazioni si va dai 737 euro mensili degli apprendisti, ai 769 euro dei collaboratori occasionali, agli 899 euro dei contratti a progetto.
Ma, purtroppo, non è tutto! I dati di rilevamento degli ultimi anni hanno dimostrato che i pensionati sono i cittadini che hanno pagato i maggiori costi sociali dell’aumento del costo della vita e del taglio delle spese sociali dello Stato. Ma la questione pensioni non diviene centrale solo in relazione alla necessità di adeguare le prestazioni erogate al costo della vita, perché la controriforma varata in tutta fretta a colpi di fiducia nel corso dell’estate 2004 ha messo a repentaglio anche la possibilità di percepire una pensione per le generazione che si affacciano ora e si affacceranno nei prossimi anni nel mercato del lavoro. Come ben sappiamo, nonostante gli annunci della campagna elettorale, anche su questo versante nulla di nuovo, o meglio di positivo, si profila sotto il sole del governo Prodi.
Eppure, anche in questo caso, basterebbero solo le nude cifre per comprendere la grave situazione sociale che ci si para davanti. Negli ultimi anni, secondo dati ISTAT, più di un milione di italiani è andato in pensione, l’OCSE ha poi calcolato che nel 2050 in Italia il 33% della popolazione avrà più di 65 anni, vale a dire che un italiano su tre peserà sul sistema previdenziale, le cui risorse invece sono destinate a diminuire a causa del calo demografico, della controriforma pensionistica e della Legge 30. La cosiddetta «riforma Biagi», precarizzando quote sempre più ampie di lavoro dipendente, sta già determinando infatti una sensibile e costante diminuzione dei valori medi contributivi, vale a dire, una costante crescita del disavanzo tra prestazioni e contributi, dato che questi ultimi hanno come origine sempre più lavoratori precari e flessibili, piuttosto che a tempo indeterminato. Risultato: restringimento inesorabile del gettito contributivo per le casse dell’INPS. Grazie a mirabili riforme del mercato del lavoro come quelle inaugurate dal pacchetto Treu , già tra il 1995 e il 2003 i contributi sono passati da 23, 1 miliardi di euro a 8, 9 miliardi.
Tutto questo ci dice che se non si interviene rapidamente con una radicale svolta – che anzitutto separi l’assistenza dalla previdenza e quindi intervenga non innalzando l’età pensionabile, ma limitando le tipologie di lavoro precario e combattendo al contempo lavoro nero ed evasione contributiva – il sistema è destinato ad implodere.
I risultati negativi di questa campagna di assalto all’arma bianca ai diritti del lavoro da parte delle politiche economiche liberiste degli ultimi venti anni sono incontestabili, e nessuno può, senza essere o sprovveduto o in malafede, negarne il fallimento. Ciò nonostante da tutta questa situazione il centro sinistra sembra non aver tratto alcuna lezione, e preferisce tendere le sue orecchie in direzione di Confindustria o di vecchie cariatidi del sistema politico-finanziario italiano come Lamberto Dini, piuttosto che imprimere una svolta che oltre ad essere socialmente necessaria gli farebbe finalmente conquistare un minimo di consenso popolare.
Come si accennava in apertura, lo scenario apocalittico che ci si para di fronte in materia di salari è stato preparato dai tecnocrati della Banca d’Italia nel corso degli anni Novanta. Come i più avranno modo di ricordare, con gli accordi del luglio 92 e 93 è stata abolita la «scala mobile» perché si affermava che questa finiva per innescare una spirale inflattiva che deprimeva l’economia. Si disse che invece, agganciando l’indicizzazione salariale all’inflazione «programmata» e non a quella reale, e intervenendo poi a colmare l’eventuale scarto tra queste due attraverso la contrattazione effettuata dal sindacato, al momento del rinnovo del contratto nazionale, si sarebbe garantito il potere d’acquisto dei salari e al contempo si sarebbe favorita l’economia e l’occupazione. Oltre a questo l’accordo prevedeva un impegno governativo a tenere sotto controllo i prezzi, cosa che in un regime di esternalizzazione e privatizzazione o comunque l’affidamento ai privati di settori chiave dell’economia come il gas, l’elettricità e le telecomunicazioni, appariva già da allora come difficilmente realizzabile.
La contropartita dell’ accordo erano i milioni di posti di lavoro che un intervento di questo tipo avrebbe dovuto produrre negli anni successivi, perché si disse che il taglio della scala mobile avrebbe prodotto un «circolo virtuoso», cioè avrebbe determinato il calo dell’inflazione e dei tassi d’interesse, i quali avrebbero poi a loro volta garantito un aumento degli investimenti produttivi e – in un regime di flessibilità e mobilità del lavoro – un aumento dei tassi d’occupazione, il tutto come già detto accompagnato dalla salvaguardia del potere d’acquisto dei salari.
I dati rilevati dall’ISTAT ci hanno invece detto tutt’altro: in Italia, a fronte di una crescita notevole di produzione, produttività e profitti, si è determinato un drastico ridimensionamento del potere d’acquisto dei salari, un sensibile calo degli investimenti produttivi – contemporaneamente ad un aumento sia degli investimenti delle imprese italiane all’estero che della speculazione finanziaria – mentre non si è vista né una redistribuzione dell’enorme ricchezza prodotta, né tanto meno alcun incremento dei tassi occupazionali, anzi. Le imprese italiane, che hanno goduto di una massiccia liberalizzazione del mercato del lavoro, contratti d’area, lavoro interinale, contatti atipici, e di benefici d’ogni sorta, dai contributi alla rottamazione, agli sgravi fiscali e contributivi, hanno coperto le congiunture favorevoli con mero lavoro straordinario, cioè sfruttamento ulteriore di lavoro esistente. I dati economici hanno cioè dimostrato che l’insieme di quelle politiche economiche-sociali hanno accentuato la distruzione di posti di lavoro anziché contrastarla, hanno dimostrato che queste non solo non producono ricadute occupazionali sul territorio ma più spesso non fanno che accelerare il processo di delocalizzazione delle imprese stesse.
Per essere ancora più precisi nel periodo di maggior espansione dell’economia italiana, tra il 1996 e il 1997, a fronte di un raddoppio del fatturato delle imprese rispetto all’aumento del costo del lavoro (6,1% del primo contro il 2,3% del secondo) e a fronte di un aumento del valore aggiunto per addetto (del 3,4%), si ha una riduzione in Italia degli investimenti dello 0,1% e degli occupati dello 0,3%. Quasi contemporaneamente dai dati EUROSTAT si evince che nello stesso periodo l’economia italiana ha quasi raddoppiato il volume degli investimenti diretti all’estero, e che il saldo negativo tra il flusso dei capitali in uscita e quelli in entrata si è quasi triplicato (da 2,3 miliardi di ECU e 6,10 miliardi di ECU).
È dunque l’evidenza dei fatti a dirci che è ora di invertire la tendenza. La questione salariale non è solo un problema di ridistribuzione della ricchezza prodotta, ma è più in generale una questione di sistema economico, di modello di sviluppo; il salario è divenuto una variabile dipendente dell’economia finanziaria, del valore del denaro, delle politiche di stabilità, e i rapporti sono fondati oramai sul possesso di denaro e patrimoni e non sulla ripartizione della ricchezza prodotta. L’idea malsana di economia che ha avuto il suo boom negli anni Novanta, quella per cui si fanno soldi con i soldi attraverso speculazioni finanziarie spericolate di ogni tipo – come gli ennesimi scandali (Cirio, Parmalat, Banca di Lodi) confermano – va radicalmente ostacolata e rovesciata. Ciò significa che si deve intervenire politicamente in favore di un diverso modello di sviluppo, che privilegi la produzione rispetto alla speculazione e che in ogni caso intervenga per ridistribuire, attraverso la tassazione, le enormi plusvalenze che si realizzano sui mercati azionari.
Ma su tutto questo versante il silenzio della politica italiana è reso assordante dalla trasversalità sempre più evidente che coglie con le mani nel sacco parte significativa della classe dirigente economica e politica nazionale. Unipol e Banca Popolare, così come i lunghi silenzi bipartizan su Fazio e le reazioni scomposte di entrambi i versanti della politica in difesa dei rispettivi amici, sono solo la punta di un iceberg fatto di un consociativismo affaristico e clientelare che ha al suo fondo la condivisione dello stesso modello di società e di economia. È di questo consociativismo teorico e pratico che si nutre la più vecchia e perniciosa malattia della politica italiana, il trasformismo. Se andiamo a riguardare la cronaca degli scandali sulle commistioni improprie tra politica ed economia degli anni d’oro del trasformismo – quelli di Crispi e Giolitti – vediamo chiaramente come rispetto ad allora sono cambiati gli attori ma la trama è sempre la stessa
Ripartire da salari e lavoro significa dunque dare risposte alle esigenze delle masse popolari, ed insieme, instillare nuovi anticorpi nell’organismo sociale della sinistra italiana.
La conferma di ciò è sotto gli occhi di tutti: un anno fa la prima manovra finanziaria targata Padoa Schioppa ha deciso di puntare tutto sul “rigore monetario”, concentrando le enormi risorse drenate nell’obiettivo dell’abbattimento del rapporto tra debito pubblico e PIL, ciò nonostante un aumento dell’8% delle entrate fiscali nel primo semestre del 2006, che già aveva comportato una riduzione del disavanzo al 2.9%. Come se non bastasse, le uniche briciole di ridistribuite sono andate, grazie al «Cuneo fiscale», in direzione del capitale, non certo del lavoro, e i dati riportati ne sono una conferma. La finanziaria attualmente in discussione è un ulteriore manifesto di questa continuità di scelte nelle politiche economiche perseguite dal 1992 ad oggi. Il compromesso deteriore del “Protocollo sul Welfare” e la decisione di non intervenire su quel vulnus alla figura contrattuale del lavoro che rientra nella vasta categoria della precarietà, rappresentano la definitiva resa del centro sinistra e delle organizzazioni sindacali a qualsiasi ipotesi di invertire la tendenza degli ultimi due decenni.
Emerge un quadro che rende dannatamente attuale la categoria utilizzata da Gramsci per descrivere le fasi di modernizzazione capitalistica reazionaria, quelle basate sulla sistematica esclusione e passivizzazione delle classi subalterne, appunto la categoria della «rivoluzione passiva».
Concludendo, tra precarietà, perdita del potere d’acquisto, peggioramento delle condizioni di lavoro e di quelle previdenziali, è certo che in tutti questi anni le classi dirigenti di questo paese (mondo dell’economia e della finanza politica di centro-sinistra e centro destra) hanno scritto la sceneggiatura di un film nel quale al lavoratore è riservata la parte dell’attore non protagonista, un personaggio sempre più subalterno costretto a barcamenarsi tra mille peripezie in un percorso ad ostacoli sempre più accidentato e insostenibile. Parafrasando il titolo del bel film di Stanley Kubrick potremmo intitolarlo “2001 Odissea nel contratto”. Ma sappiamo che si può scrivere la storia non il futuro. Dal copione imposto ci si può ribellare, restituendo voce, centralità e soggettività politica a quel soggetto oggi vilipeso. Ripartire dal lavoro, ripartire dal conflitto, questo è il compito.
FONTE: IRES-CGIL, Stipendi 2002-2007, novembre 2007
| Anno | Inflazione (a) | Retribuzioni (b) | Potere di acquisto | Perdita/guagagno cumulato del potere d’acquisto | Perdita per mancata restituzione fiscal. drag. |
| 2002 | 2,8 | 2,4% | -0,4% | -532 | -171 |
| 2003 | 2,9 | 1,8% | -1,1% | -1.298 | -151 |
| 2004 | 2,7 | 2,7% | 0,0 | – | -124 |
| 2005 | 2,3 | 2,8% | +0,5 | +312 | -118 |
| 2006 | 2,7 | 3,3% | +0,6 | +283 | –121 |
| 2007 | 1,9 | 2,0% | +0,1 | +25 | – |
| (-0,3) | -1.210 | -686 | |||
| -1.896 | |||||
1Il fiscal drag sintetizza il fenomeno della crescita della pressione fiscale diretta legata all’aumento del costo della vita. La restituzione del fiscal drag è esattamente quel che uno Stato dovrebbe restituire in busta paga ciò che si è perso a causa dell’inflazione. In Italia le tecniche per raggiungere questo scopo sono contenute nell’art. 3 della legge n. 154/1989: quando l’indice medio di inflazione cresce nel periodo 1° settembre-31 agosto più del 2%, il governo provvede ad adeguare opportunamente gli scaglioni, le aliquote e le detrazioni di imposta. La legge inoltre stabilisce che in tal caso le modifiche dovrebbero neutralizzare integralmente gli effetti del fiscal drag. Per ragioni di finanza pubblica, però, il governo può decidere di restituirlo soltanto in parte.